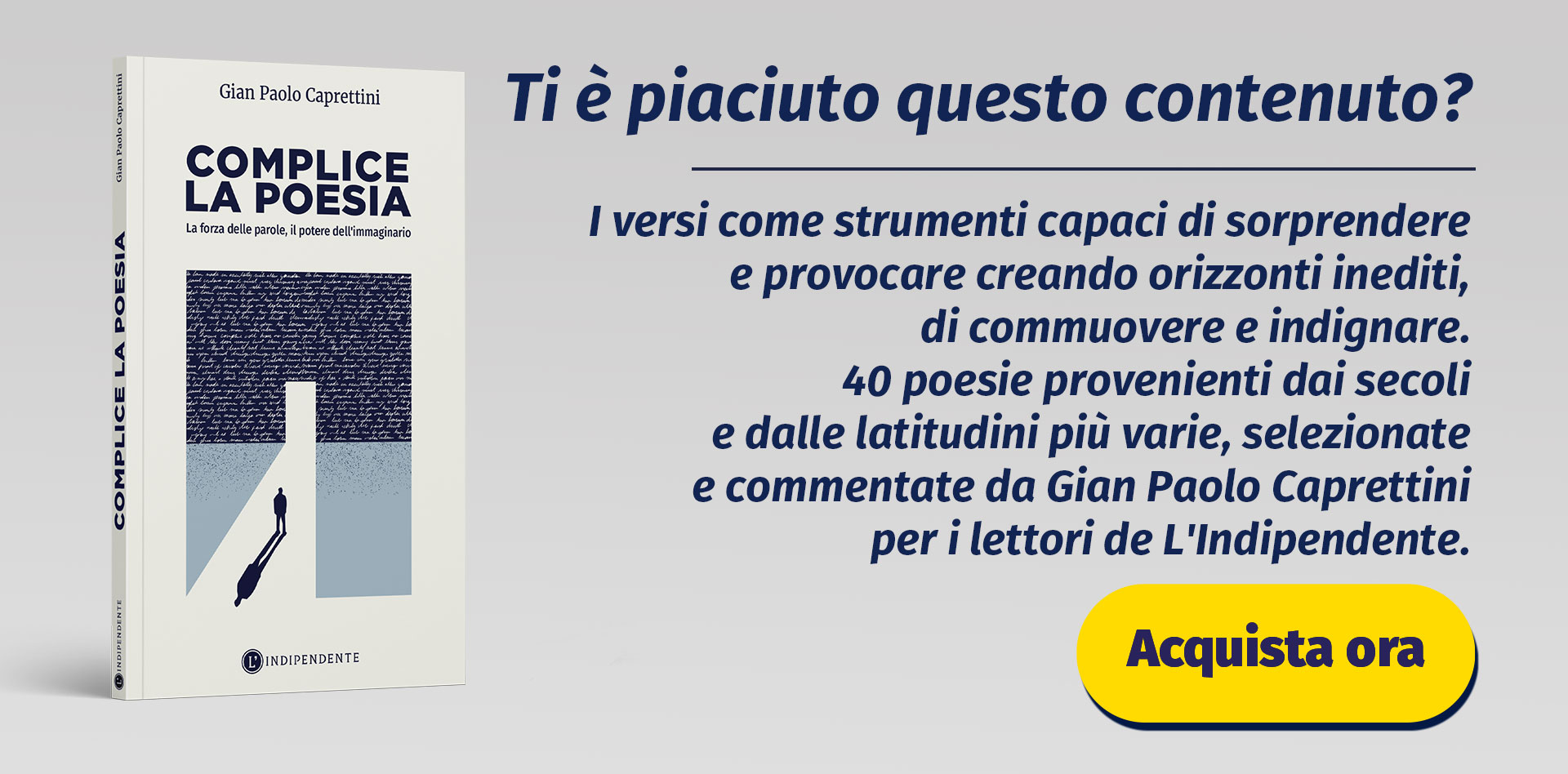Forse aveva ragione Hans M. Enzensberger quando affermava nell’Elogio dell’analfabetismo (1988) che “sono stati gli analfabeti a inventare la letteratura. Le sue forme elementari, dal mito fino alle poesiole da bambini, dalle favole al canto, dalla preghiera fino all’indovinello, sono tutte più antiche della scrittura. Senza tradizione orale non ci sarebbe poesia e senza gli analfabeti non ci sarebbero libri”. Gli ha fatto eco il grande Ray Bradbury, visionario e surreale, nella postilla di Addio all’estate (2006): “La zia Neva è stata la custode e giardiniera delle metafore che sono diventate la parte più importante di me. Si è occupata di nutrirmi con le fiabe più belle, con la poesia, il cinema e il teatro, in modo che la febbre della vita continuasse a bruciare insieme alla voglia di scrivere. Oggi, dopo tanti anni, quando scrivo ho ancora l’impressione che mi guardi di sopra la spalla e sprizzi orgoglio”.
L’inizio di Doppio sogno (1926) di A. Schnitzler, a cui corrisponde con una certa fedeltà la sequenza d’avvio di Eyes Wide Shut di Kubrick che vi si è ispirato, riporta una pagina delle Mille e una notte letta da una bimba che si addormenterà a quelle parole, e poi tutta la storia e tutto il film verranno dominati dai colori e dalle luci di quel racconto. E sostanzialmente da una perdita dell’innocenza.
“Il concepire mitico dell’infanzia è insomma un sollevare alla sfera di eventi unici e assoluti le successive rivelazioni delle cose, per cui queste vivranno nella coscienza come schemi normativi dell’immaginazione affettiva. Così ognuno di noi possiede una mitologia personale…che dà un valore assoluto al suo mondo più remoto… dove pare, come in un simbolo, riassumersi il senso di tutta una vita” (Cesare Pavese, Feria d’agosto, 1946).
Infanzia e poesia ritornano nei suggerimenti di Rainer M. Rilke al giovane poeta: “Se la vostra vita quotidiana vi sembra povera, non l’accusate; accusate voi stesso, che non siete assai poeta da evocarne la ricchezza…E se anche foste in un carcere, le cui pareti non lasciassero filtrare alcuno dei rumori del mondo… non avreste ancora sempre la vostra infanzia, questa ricchezza preziosa, regale, questo tesoro dei ricordi?” (Lettere a un giovane poeta, 1903-8).
Parliamo ovviamente dell’analfabetismo immerso nella tradizione, nella ritualità, nella ricerca del tempo perduto, non dell’analfabetismo di ritorno, sempre secondo Enzensberger, che è quello gestito dalla televisione che impedisce qualsiasi ricerca, qualsiasi dubbio, qualsiasi seria discussione o pacato colloquio.
L’analfabetismo che faceva coincidere, in Giovanni Pascoli, la poesia con la lampada “ch’ arde soave”, che “ascolta novelle e ragioni…/ e vecchie parole sentite/ da presso con palpiti nuovi”, che presiede ai riti di una famiglia di campagna, che non ha paura di coltivare sentimenti. Pascoli che scrive La canzone del girarrosto dove celebra le “piccole grida” della cucina, il “ronzare… d’un ospite molto ciarliero”. O altrimenti, la poesia che essa stessa diventa analfabeta quando “consiste/ nel dir sempre peggio/ le stesse cose” (E. Montale).
Tutto questo per suggerire che bisogna riprendersi il tempo, cioè perderne un po’, per ritrovare la socialità, il disinteresse, le banalità e le grandezze di una semplice conversazione.
Scriveva Vasco Pratolini ne La costanza della ragione (1963, cap. 26): “I suoi Poeti, cosa gli avevano insegnato? Essi vissero con un’idea. Furono soldati e teatranti, diplomatici e miliziani, contadini e ingegneri. Si chiamavano Lorca e Majakovski quelli che lui più amava. Conobbero l’estasi e il dolore, cantarono il sangue e la rosa, i grattacieli e gli ulivi, la metropoli e il mare, le macchine, la betulla e il maggese. Si fecero uccidere o si uccisero. Ma sarebbe stato lui senza i suoi Poeti? … Come ogni creatura che della propria costanza si è fatta una ragione, portarono addosso le pene e i deliri, le contraddizioni che prevaricano verità e giustizia, i vizi che travolgono le innocenze. E i miti, che incarcerano la libertà. Crollarono sotto il peso del mondo, dopo averlo sospinto di un passo verso la salvazione”.
Dovremmo insomma camminare tenendo accanto “dimesse parole e volti senza maschera”, come scriveva Montale, ostinarci a persistere nella fantasia. In un crescente bisogno di semplicità e autenticità, come avanguardie di una nuova rivoluzione che sa mescolare progetti e memoria, e li sa condividere.
Mentre oggi facciamo fatica, come gli abitanti di Macondo, a riconoscere il mondo circostante. Altri cent’anni di solitudine, allora? In un’intervista, Eugenio Montale concludeva scetticamente: “L’uomo non sa nulla di se stesso: ma esiste la cosiddetta scienza per stabilire qualche cosa, e bisogna fingere di crederci se si vuole essere iscritti all’elenco degli uomini pensanti”. Era il 1974.
[di Gian Paolo Caprettini – semiologo, critico televisivo, accademico]