“Oggi si combatte la guerra fredda con la tecnologia dell’informazione perché tutte le guerre si sono sempre combattute con la tecnologia più nuova che ogni cultura aveva a disposizione”. D’altro canto, la guerra di vecchio tipo è ormai inattuabile; sarebbe come fare un gioco di società con dei bulldozer. Questo scriveva Marshall McLuhan nel 1964 in conclusione di Understanding Media (trad.it. Gli strumenti del comunicare, Il Saggiatore). McLuhan aveva sostanzialmente una visione ottimistica, è stato il profeta della “fase finale dell’estensione dell’uomo: quella cioè in cui, attraverso la simulazione tecnologica, il processo creativo di conoscenza verrà collettivamente esteso all’intera società umana, proprio come, tramite i vari media abbiamo esteso i nostri sensi e i nostri nervi”. La realtà, e il mito, sono quelli della simultaneità, dovuti al dominio dell’era elettrica, al potere della informazione, capaci di mettere in luce la realtà esattamente quando si sta producendo. Mentre la precedente epoca dell’industria meccanica vedeva l’affermarsi di opinioni personali a seguito della frammentazione di percezioni, nell’epoca elettronica, dominata dalla automazione, è inevitabile il ricorso alla totalità, all’empatia, alla consapevolezza in profondità. Sappiamo che le cose non sono proprio andate così e che il concetto di interdipendenza e la trasformazione del mondo in un unico mastodontico sistema nervoso centrale, la messa a disposizione simultanea e planetaria dell’informazione non hanno affatto evitato che si perpetuasse, con nuovi strumenti, il vecchio sistema di “frazionare e dividere ogni cosa al fine di controllarla”. Ora, aggiunge Mc Luhan, che l’età dell’informazione richiede l’uso convergente di tutte le nostre facoltà, “ci accorgiamo di riposare soprattutto quando siamo intensamente coinvolti, come del resto accadde sempre agli artisti, in tutti i tempi”. Pensiamo ad esempio all’intensità crescente con cui utilizziamo il cellulare per potenziare la nostra rete di relazioni ma anche per dare una raffigurazione al nostro mondo simbolico e di valori, ad esempio mediante Instagram. Si è dunque venuta ad affermare una logica iconica, visiva dominata dall’immediatezza, mediante la sincronizzazione di numerose operazioni che hanno “posto fine al vecchio sistema meccanico di disporre le operazioni in una sequenza lineare”. Di qui una nuova predominanza dei sistemi visivi che fa parlare McLuhan – siamo nel 1964 – di armi come “guerra delle icone”, orizzonte che ha favorito, a suo parere i russi, abituati a un sistema di propaganda, quale perpetuazione “delle loro tradizioni religiose e culturali”, atte a costruire icone, a dare valore concreto alle immagini. Ma ci sono altre conseguenze prodotte dal mondo istantaneo dell’organizzazione elettrica: esso, ad esempio, ha reso il sistema scolastico frammentario, prigioniero del lavoro servile conseguente alla produzione meccanica. McLuhan alterna nelle sue pagine considerazioni visionarie e formule efficacissime, come quando afferma che l’automazione ha liberato le nostre risorse interiori esattamente come la macchina ha liberato il cavallo dalla fatica trasformandolo in un animale da svago. “Gli uomini sono diventati raccoglitori di conoscenza, nomadi come mai nel passato, informati come mai nel passato”, abituati insomma all’interdipendenza totale come punto di partenza. Una interdipendenza insita nell’automazione che ha ridisegnato le nostre forme di lavoro, fornendoci una spinta per una personale ricerca estetica e autonomia artistica, essendo l’utopia di McLuhan la stessa di Oscar Wilde, quella di trasformare il mondo in una grande opera artistica.
La guerra appare ovviamente una minaccia a tutto questo. Come affermava Yves Montand in Z-L’orgia del potere, il notevole film di Costa-Gavras (1968), “viviamo in un paese in cui persino la fantasia è sospetta. E invece ci vuole fantasia per risolvere i problemi di questo pianeta, sul quale la potenza esplosiva delle bombe atomiche in deposito corrisponde a una tonnellata di dinamite per abitante”. Fantasia al potere, dunque, e potrebbe anche andar bene. Ma vorrei ora richiamarmi alla fantasia narrativa, con le sue ragioni e la sua forza. La fantasia, intrecciata alla catastrofica esperienza della prima guerra mondiale, che permise a Ernest Hemingway di consegnare alle stampe, nel 1948, “Addio alle armi”, scritto vent’anni prima: “Ero sempre imbarazzato dalle parole sacro, glorioso e sacrificio e dall’espressione invano. Le avevamo udite a volte ritti nella pioggia, quasi fuori dalla portata della voce…e le avevamo lette sui proclami … ma non avevo visto niente di sacro, e le cose gloriose non avevano gloria… Le parole astratte erano oscene accanto ai nomi concreti dei villaggi, ai numeri delle strade, ai nomi dei fiumi…”. Nella nota di apertura del romanzo Hemingway parla della sua esperienza: “Forse è chiaro perché uno scrittore debba interessarsi al continuo, prepotente, criminale, sporco delitto che è la guerra… Le guerre sono combattute dalla più bella gente che c’è… ma sono fatte, provocate e iniziate da precise rivalità economiche e da maiali che sorgono a profittarne”. Ci sono soldati scrittori, come Hemingway, che sfidano la banalità del male inventando, nelle loro storie, amori magari di pura fantasia. Il nostro Renato Serra, impegnato anche lui sulle nostre montagne, nel primo conflitto mondiale, scriveva dalla trincea a un amico che “una nuvola che passa e un raggio di sole che viene a trovarti in fondo alla buca acquista più importanza della pallottola che t’ha sfiorato il collo”. Il contrario della guerra non è insomma la pace ma, per ogni singolo essere vivente, e per tutti insieme, il contrario è l’amore, la pietà. Come scrive Serra nel suo Esame di coscienza di un letterato, “la guerra non cambia niente. Non migliora, non redime, non cancella… Non paga i debiti, non lava i peccati, in questo mondo che non conosce più la grazia… Le orme dei movimenti e dei passaggi si sono logorate nel confuso calpestio delle strade… ma la vita ha continuato uguale; è ripullulata dalle semenze nascoste con lo stesso suono di linguaggi e con gli stessi oscuri vincoli che fanno di tanti piccoli esseri divisi, dentro un cerchio, indefinibile e preciso, una cosa sola”.
[di Gian Paolo Caprettini]

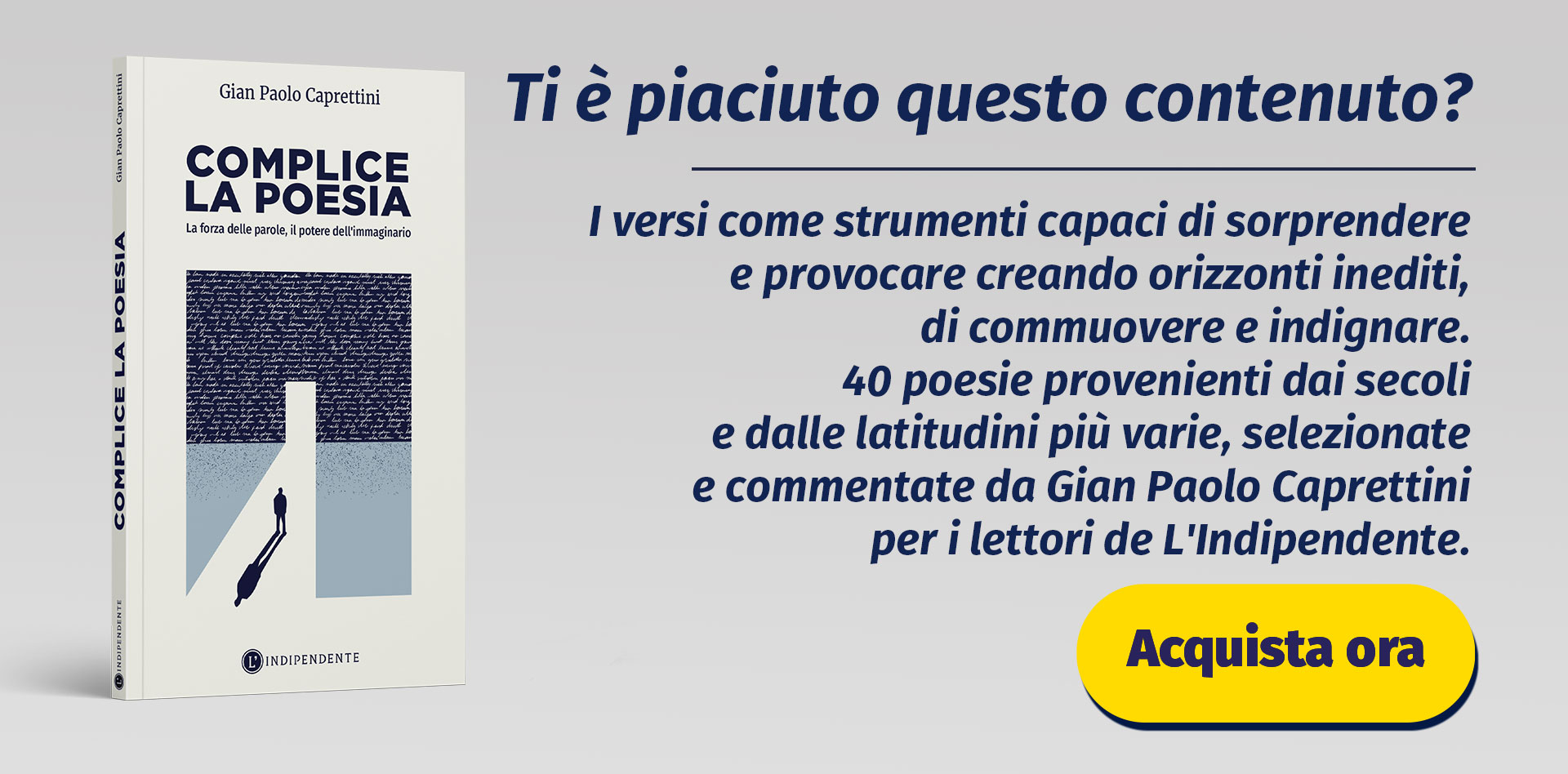



Divide et impera. È ancora valido dopo secoli
Serra profondo e commovente.