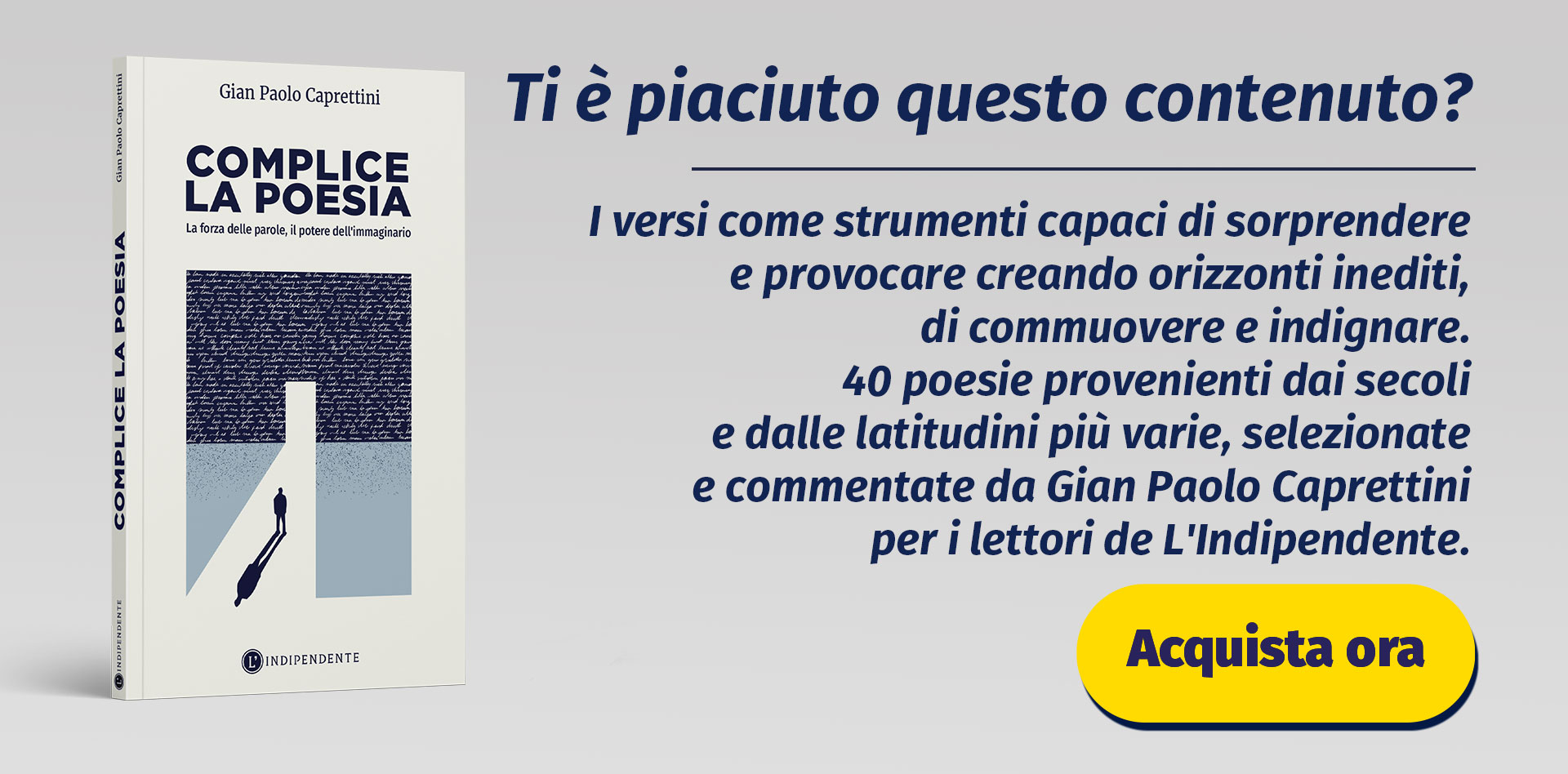Non si tratta di cancel culture, non si tratta di revisionismo e nemmeno di critica radicale al sistema simbolico del consumismo o del capitalismo. Se parliamo dell’albero di Natale, tuttavia, lo facciamo per assumere un punto di vista inconsueto e metterci dalla parte dell’abete. Con l’aiuto non di un anarchico e nemmeno di un ecologista battagliero ma semplicemente di uno scrittore di favole, il danese Hans Christian Andersen.
In una delle sue fiabe, L’abete, pubblicata nel 1844 (n. 29 della raccolta curata da B. Berti, Donzelli editore) lo scrittore dà appunto la voce a un malinconico albero che, prima trascurato nel bosco perché troppo piccolo, una volta sviluppatosi vigorosamente viene tagliato per essere portato, in occasione del Natale, in una bella casa. Terminati i sontuosi, allegri fasti della festa e raggiunto il massimo della sua gloria, l’abete è gettato in un angolo buio della soffitta e alla fine ridotto in piccoli pezzi e bruciato.
La storia, che rispecchia l’atmosfera amara e a tratti crudele dei racconti favolistici di Andersen, segue alcuni assi simbolici che rispondono anche a valori archetipici. Primo fra tutti incontriamo il desiderio, l’ansia di crescere da parte della pianta, che poi si concreta, raggiunte le giuste dimensioni, nell’essere espiantata. “Oh, crescere, crescere, diventare grande e vecchio, è l’unica cosa bella al mondo, pensava l’albero”. Questo valore va a contrapporsi, alla fine del racconto, con il concetto di passare: il passare suo, quello della serata festosa in cui si era trovato al centro delle attenzioni e il passare, complessivamente, dell’avventura.
Ciò che prima era cresciuto è destinato appunto a cedere al tempo, evidentemente raffigurando, nel diventare cenere della pianta, non soltanto il destino umano ma il trascorrere dell’anno che il Natale, giorno di nascita e rinascita, va a concludere. “I ragazzini giocavano in cortile e il più piccolo aveva sul petto la stella d’oro che l’albero aveva portato nella sua sera più felice; adesso era passata, e l’albero era passato, e anche la storia; passata, passata, e così sarà per tutte le storie!”
L’albero di Natale, e quindi anche l’abete in questione, si presenta inoltre come esempio del modello dell’albero universale che in tutta l’Eurasia, fin dalla preistoria, segna l’organizzazione dello spazio naturale. Secondo tale modello, l’albero – in quanto anche asse del mondo – va ad articolarsi su tre piani: una parte superiore, i rami, associati ovviamente agli uccelli con i loro canti e ai nidi, una parte centrale, il tronco, associata agli animali ungulati e all’uomo, e infine una sezione inferiore, le radici, collegata ai serpenti, topi, rane e talvolta animali fantastici (cfr. V.N. Toporov, L’ ‘albero universale’, in Ricerche semiotiche, a cura di V. Strada, Einaudi ) . “Potrei allargare i miei rami tutto intorno… allora gli uccelli costruirebbero il nido tra le mie fronde”, si chiedeva prima di venire tagliato.
La dimensione sotterranea, ctonia, ancestrale dell’albero viene di conseguenza annullata quando l’albero è reciso e le radici sono abbandonate o gettate via, e la stazione eretta dell’albero dipende dal suo essere conficcato in un vaso o provvisoriamente nel terreno. L’abete di Andersen ne sembra al corrente quando teme di non mettere più radici e non conoscere più l’avvicendarsi delle stagioni. “Chissà se metterò radici qui e rimarrò adornato estate e inverno”.
Un’ulteriore, decisiva impronta della personalità simbolica dell’abete, quello della fiaba e quello generalmente dell’albero di Natale, consiste nella sua connessione con la luce – dalla stella di carta dorata al vertice, che richiama la personalità angelica della stella cometa, a quella delle tante candele, coccarde, sfere, piccoli dolci colorati e decori luminosi degli alberi delle feste e infine, con connotati cerimoniali e tragici, all’incendiarsi finale dell’abete che corrisponde ai riti popolari dei falò dell’abbruciamento dell’anno nei giorni della sua fine, con la variante anche dei fuochi artificiali.
Viene dunque ad associarsi, dopo il ‘crescere’ e prima del ‘passare’, il predicato dello splendere, quella nozione assoluta che indica la pienezza del tempo in rapporto alle varie forme della luce, e il predicato dell’ascoltare: le storie raccontate attorno all’albero, le parole delle conversazioni che lo attorniano e le parole che l’albero stesso, nella fiaba di Andersen, rivolge ai topolini quando, abbandonato in soffitta, parla dei suoi passati momenti gloriosi nell’ambito della celebrazione natalizia.
Ritornano dunque, benché in forma residuale, quelle corrispondenze fra cosmo e uomo che organizzano il pensiero sia in forma di esteriorizzazione – la decorazione dell’albero come celebrazione di doni, divini e materiali, che l’uomo ha ricevuto e di cui rende conto nella cerchia familiare e in quella sociale -, sia in forma di interiorizzazione, come riconquista di una coscienza personale del tempo e degli affetti.
Tutto un apparato metaforico che si manifesta però a discapito della vita dell’albero, sottoposto prima all’esaltazione festosa poi alla degradazione e alla rovina, a raffigurare una ambiguità che investe ogni forma vivente soggetta alla strumentalizzazione. Albero reciso dunque che nella pittura seicentesca entrava nei quadri delle nature morte e nella simbologia della vanitas e della caducità umana.
Straordinaria infine un’altra fiaba di Andersen, Una foglia dal cielo (n. 76 della raccolta Berni) che va in direzione opposta. Invece di cadere nel fatalismo deterministico, estremizza il principio della soggettività parlando di una pianta meravigliosa, una pianta calata probabilmente dal cielo, che irradiava luce, grazie alla neve che la copriva, e che sfuggiva a ogni classificazione botanica. “ ‘Si tratta di una variante!’ disse il professore di botanica. ‘Non la conosco, non fa parte del sistema!’, ‘Non fa parte del sistema!’, ripeterono i cardi e le ortiche ”.
[di Gian Paolo Caprettini – semiologo, critico televisivo, accademico]