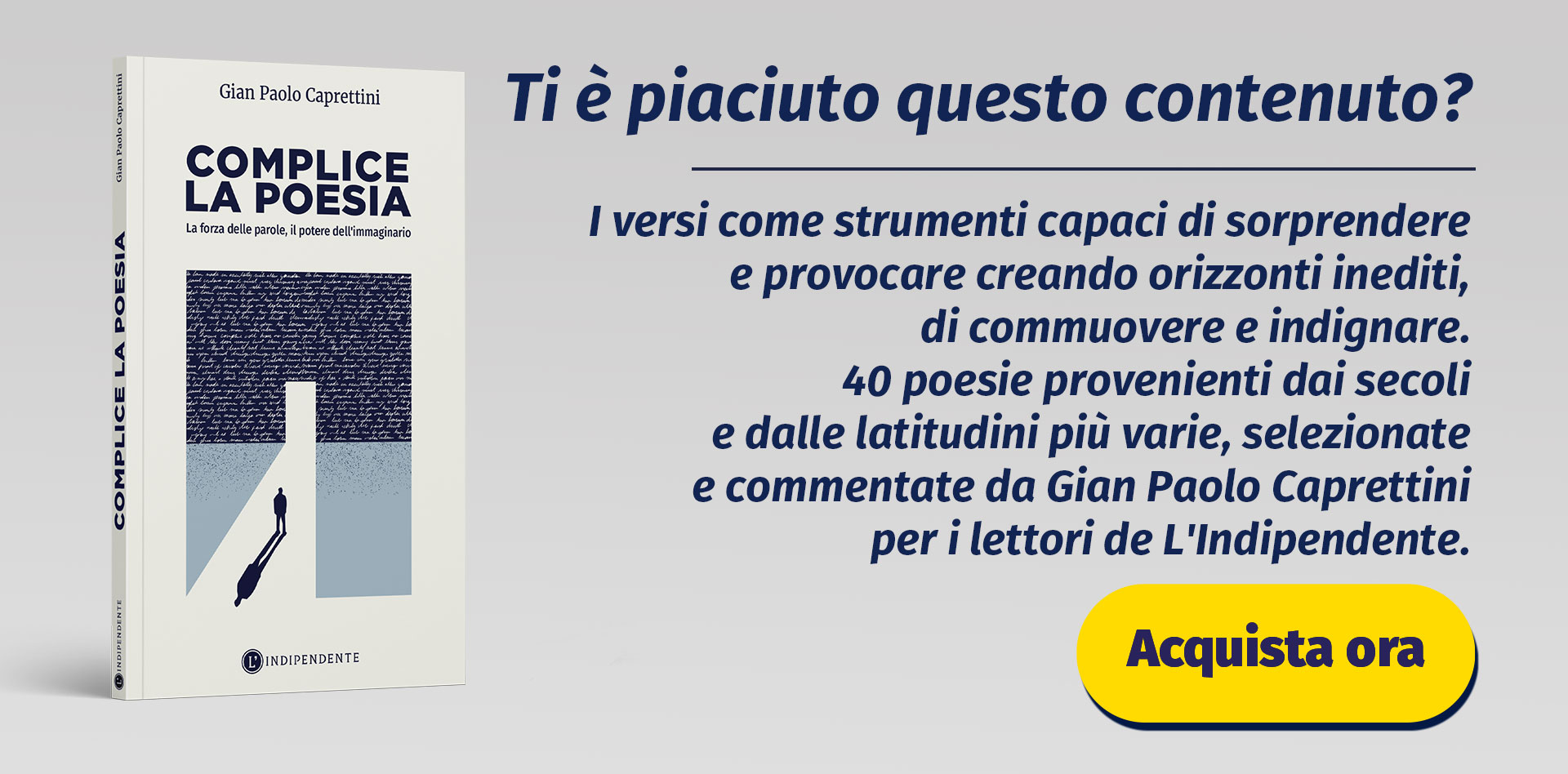Seminare nei solchi, gettare speranza nel terreno dissodato, guardare il tuo campo disteso, rossastro, bruno di terra smossa, fertile, che aspetta il gesto di qualcuno o della macchina che butta il seme, dove poi vedrai spuntare le gemme, crescere gli steli. E poi avverrà secondo la pioggia, il sole e tutto il resto.
Seminare è perpetuare, è procreare, è rendere fertile, è diventare alleati del tempo.
La terra, dunque, nelle simbologie e nelle tradizioni di ogni contrada del mondo è collegata alla nozione di corpo, di vita, di conoscenza, assimilando ad esempio l’atto dello scrivere a quello di seminare il nero seme dell’inchiostro sul foglio (così nell’Indovinello veronese, fine ottavo secolo).
Le leggi della fatica e degli eventi atmosferici, del cielo buono o cattivo, si perpetuano in vista del raccolto, del premio della fatica e del sapere. Lavorare la terra ha anche un valore sacro, attinente all’energia, al ritmo vitale, al segnare un solco, una strada. Lavorare la terra e rispettare chi la lavora ha a che fare con l’inconscio collettivo, con l’attesa e con l’idea che ora facciamo qualcosa per dopo.
Ecco invece lo smantellamento dell’apparato simbolico, dei campi e della natura, in favore della aridità indifferenziata di una tecnologia intesa erroneamente come strumento del progresso. Un progresso reso inevitabile che vuole trasformare i saggi in ignoranti, e coloro che si impegnano nel proprio lavoro in emarginati. Tutti prigionieri della dottrina dell’ultima ora, massacrati nella libertà di pensare dal diktat di una élite spietata e indegna che vuole umiliare lavoratori e imprenditori facendoli sentire sulla strada sbagliata.
Si fa un uso strumentale di concetti sani. Si combatte giustamente contro gli allevamenti intensivi per fare poi dire ad altri, rintontiti da presunti guadagni, che la soluzione è il cibo sintetico. Non la riduzione della produzione e della offerta di carne e il corretto trattamento degli animali. Non il rispetto per chi persegue alternative vegetariane o vegane.
Intanto il governante mondialista gira col suo jet inquinante, mangia quello che vuole nei posti più rinomati, si fa ricevere come un capo di Stato.
E il solco attende, attende i seminatori, il sole e la pioggia, la luna e il concime, gli sguardi e le braccia di chi lo ama. Rimane solo come una donna, come un uomo abbandonato, si secca invano, aspetta, come diceva il mito, che Cerere, la dea delle messi, si incanti, che le spighe crescano, che avvenga il raccolto religiosamente al chiaro di luna, che a casa si attendano i carri, che un Dio benedica e che insieme tutti festeggino, con falò e con musiche e balli, con giochi e con amori, il raccolto, quel raccolto generoso o scarso, ma che ritorna ripetuto e scandito come la musica perenne di un tempo illimitato, come l’alternarsi di ogni cosa.
I distruttori di generazioni, gli assassini sorridenti propugnatori del meno per gli altri perché loro hanno tutto devono smettere di gioire. Devono soffocare sotto le loro profezie maledette. Devono restare sterili con i loro progetti, affossati dal buon senso e dalla cattiveria tenace di chi crede e vuole andare avanti in una santa ripetizione, in un ciclo perenne. Nonostante loro, nonostante tutto.
Diceva bene Cesare Pavese in una sua poesia: “La terra è così bella verde e, zappata, ha il colore, sotto l’alba, dei volti bruciati”. Chi non lo capisce o non lo approva non ci appartiene, è un usurpatore.
[di Gianpaolo Caprettini]