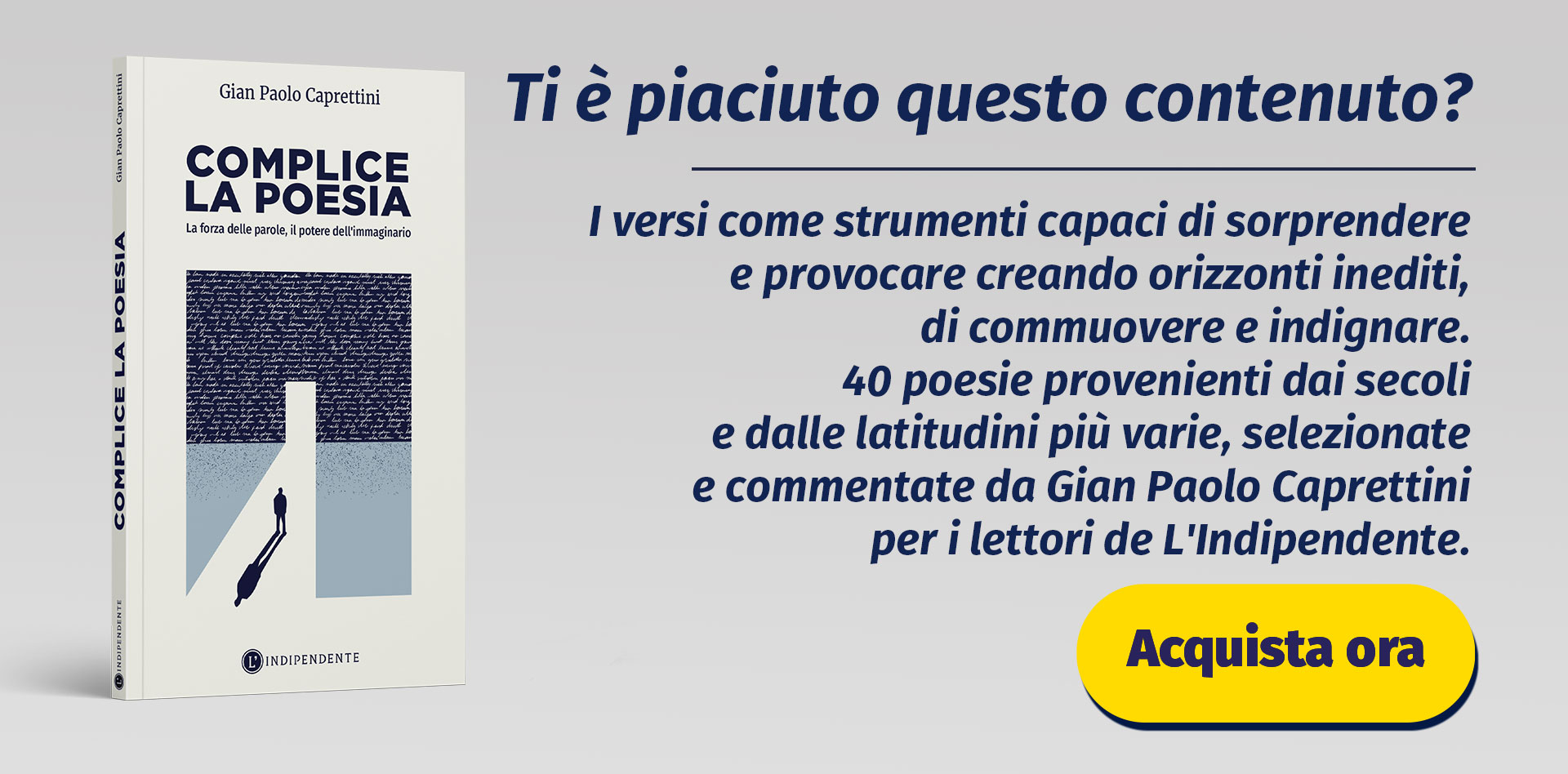Parleranno le tempeste, di loro puoi fidarti. Sulla sabbia il vento e la marea scrivono bollettini di sconfitta, gusci imperfetti presso il memoriale liscio d’ alberi d’altura, alghe, uccello lacero, rasoio affilato, corno d’ariete, conchiglia.
Dacci le notizie, dicono gli asceti leggendo e rileggendo dieci miglia di spiaggia; tra gusci vuoti, guarda, bruciano nella stampa del sale, storie d’inondazione: come abbandonai casa e famiglia.
Rasoio: come tagliai la gola alla luce del sole. Corno d’ariete: come caricai danzando alla luce lanosa del sole.
Conchiglia: come la mia vita salpò su un’oscura marea.
(a cura di F. Benocci ed E. Bello)
La poesia canta le rovine del tempo. Esattamente come la bufera. John Keats, intorno al 1817, mette in versi “il mare del tempo”, “cinque anni di bassa marea… lunghe ore di sabbia invano scorrente” per raffigurare concretamente dolcezze che vanno oltre i sensi, percezioni fisiche e insieme mentali, dove la “splendida rete” è quella della “dolorosa gioia d’amore”.
Montale, nella sua Bufera convoca in una “eternità d’istante” una “nube di capelli”, corporea come fisiche sono la guancia e le labbra nei versi di Keats. Janet Frame, anche lei, e in un suo modo sublime, vive quei lampi e quegli schianti che furono anche di Montale e di Keats, senza saperlo o sapendolo non importa, continua il canto Emily Dickinson che attribuisce pensieri agli oggetti e ovunque ascolta, ma è lei, soltanto lei, Janet, che vive le sue “storie di inondazione”, che sente il mondo venirle addosso, e i gusci vuoti che si riempiono di quella sabbia che sta nella clessidra che continua a svuotarsi.
Il tempo divora le sue dolcezze – “devour its sweets”, scriveva Keats, entra come ragione di tutto in questa poesia che illumina una autobiografia piena di dolore e di abbandoni. Tutto dinanzi al mare è relitto, è guasto, è “ciarpame infranto” (dice lei in un’altra poesia), è immenso abbandono e la luce del sole, quasi artificiale come quella di un film, rende spietata la verità infelice, inonda davvero senza nulla tralasciare. Inonda me, dice Janet, e mi lascia sospesa e pronta a salpare.
Se la poesia riuscirà a salvare, sarà grazie al linguaggio immaginifico, quello della follia, del sogno, dell’infanzia, del sentimento, della perdita di controllo e dell’urlo; la poesia avrà la forza e insieme la dolcezza di rappresentare, di segnare e, sì, di dare notizie raffigurando a suo modo. Ascetica anche perché estranea al divenire, ininfluente nei confronti degli accadimenti e delle sentenze che il mondo vorrebbe eseguire.
Poesia sempre come quell’angelo seduto a tavola, cantato da lei, una specie speciale di Emmaus del poeta dove il divino ti conosce ma tu fai fatica ad accettarlo. L’esilio e il trionfo, invece, li accetterai, grazie al linguaggio, “ai lunghi tuoni” e ai “suoni di cristallo” di quella bufera del poeta ligure, e ai “rasoi affilati” di questa voce neozelandese e della incantevole, inquietante illusione che si cela tra questi versi, tra le voci delle tempeste.
[di Gianpaolo Caprettini]