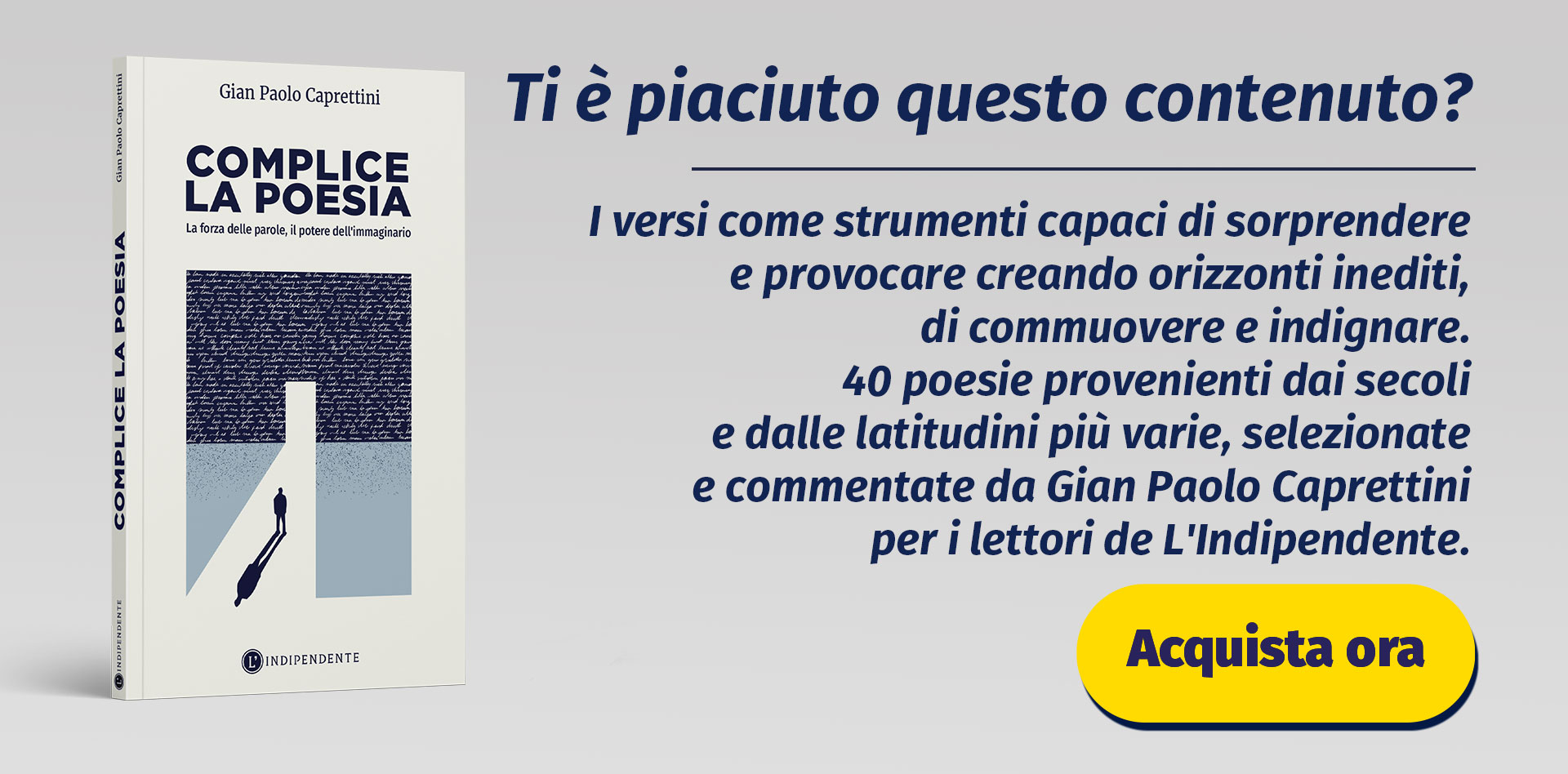Le tradizioni occidentali sono generate da due grandi correnti. Una orientale – a cui vorrei dare lo sguardo di Alessandro Magno – che approda in Grecia e a Roma, trascinando con sé quell’apparato indoeuropeo che ha attribuito nomi e valori a tutti gli aspetti della nostra vita organizzata, agli orizzonti simbolici, alle forme del quotidiano e del divino, alle rappresentazioni dei sentimenti e dei poteri, delle relazioni e dei concetti.
L’altra corrente è quella nativa americana, che pullula di richiami ancestrali, che pone la natura e le sue leggi al centro di tutto, che scorge nei ritmi della vita l’influsso astrale, la voce degli antenati, i richiami dell’eterno ritorno.
In particolare, gli immaginari mesoamericano, caraibico, sudamericano hanno saputo integrare gli apporti della Conquista, cristianesimo compreso, in una nuova enciclopedia di costumi e visioni, mantenendo quel particolare ritmo musicale, esplosivo e malinconico insieme, che caratterizza il loro immaginario: una forma speciale del tempo e dell’eternità che si concreta nell’idea della mancanza di confini e nella visione della continuità e della compresenza atemporale dei dati di realtà.
Questa visione è stata espressa in modo straordinario, coinvolgente e drammatico, nell’opera di Eduardo Galeano, quasi si trattasse di una epopea in cui sono gli sconfitti, coloro che hanno subìto secolari sfruttamenti, a risultare eroi, perché quell’America è la terra di tutti e di nessuno, dell’oro e dell’odio, del canto e del silenzio, del sacrificio e del tradimento, scritta la sua storia in un infinito tramonto pieno però ancora di lampi.
Nel suo libro, Le vene aperte dell’America Latina (1971), Galeano afferma crudamente: «Sono passati i secoli e l’America Latina ha perfezionato il proprio ruolo. Questo ormai non è più il Paese delle meraviglie in cui la realtà sconfiggeva la favola e la fantasia veniva umiliata dai trofei della conquista, dai giacimenti d’oro e dalle montagne d’argento. […] Essa continua a fare da serva. Continua a vivere al servizio delle necessità altrui, come fonte e riserva di petrolio e di ferro, di rame e di carne, di frutta e caffè: materie prime e alimentari destinate ai Paesi ricchi che guadagnano, consumandole, molto più di quanto l’America Latina guadagni producendole».
E all’inizio del libro fa valere l’idea che l’America sia diventata terra d’altri perché è stata scoperta, e dunque è diventata una preda di caccia.

«Quando Cristoforo Colombo decise di attraversare i grandi spazi vuoti a ovest dell’Universo accettò la sfida delle leggende. Terribili tempeste avrebbero giocato con le sue navi quasi fossero gusci di noce gettandole in bocca ai mostri; e il gran serpente dei mari tenebrosi, affamato di carne umana, sarebbe stato in agguato. Gli uomini del XV secolo credevano che mancassero soltanto mille anni perché i fuochi purificatori del Giudizio distruggessero il mondo; e il mondo era allora il Mar Mediterraneo con le sue coste ambigue: Europa, Africa, Asia. I navigatori portoghesi raccontavano che il vento dell’Ovest portava strani cadaveri e, a volte, pezzi di legno intagliati in modo curioso, ma nessuno pensava che il mondo si sarebbe ben presto, meravigliosamente, accresciuto d’una nuova vasta terra».
Una terra generatrice di immaginario, di orizzonti folgoranti. Ho scelto qualche inizio narrativo per ricreare, seppure parzialmente, l’ambiente di quelle visioni, focalizzandomi su una rivoluzione mentale che persiste ai frequenti orrori di poteri politici ed economici fuori controllo.
«…Tutti gli anni, nel mese di marzo, una famiglia di zingari straccioni piantava la tenda vicino al villaggio, e con gran chiasso di fischietti e timbales veniva a far conoscere le nuove invenzioni. Prima portarono la calamita» (Gabriel García Márquez, Cent’anni di solitudine, 1967).
«Barrabás arrivò in famiglia per via mare, annotò la piccola Clara con la sua delicata calligrafia. Già allora aveva l’abitudine di scrivere le cose importanti e più tardi, quando rimase muta, scriveva anche le banalità, senza sospettare che, cinquant’anni dopo, i suoi quaderni mi sarebbero serviti per riscattare la memoria del passato, e per sopravvivere al mio stesso terrore» (Isabel Allende, La casa degli spiriti, 1982).
«Il cielo, che gravava minaccioso a pochi palmi dalle teste, sembrava una pancia d’asino rigonfia. Il vento, tiepido e appiccicoso, spazzava via alcune foglie morte e scuoteva con violenza i banani rachitici che decoravano la facciata del municipio. I pochi abitanti di El Idilio, e un pugno di avventurieri arrivati dai dintorni, si erano riuniti sul molo e aspettavano il loro turno per sedersi sulla poltrona portatile del dottor Rubicundo Loachamín, il dentista, che leniva i dolori dei suoi pazienti» (Luís Sepúlveda, Il vecchio che leggeva romanzi d’amore, 1989).
«Nel passo delle Enneadi che intende investigare e definire la natura del tempo si afferma che innanzi tutto è indispensabile conoscere l’eternità, la quale come tutti sanno ne è il modello e l’archetipo. Questa avvertenza preliminare, tanto più grave se la riteniamo sincera, sembra annientare ogni speranza di intenderci con l’uomo che la scrisse. Il tempo è per noi un problema, un inquietante ed esigente problema, forse il più vitale della metafisica; l’eternità, un gioco o una faticosa speranza. Leggiamo nel Timeo di Platone che il tempo è un’immagine mobile dell’eternità, ma si tratta di un semplice postulato, che non distoglie nessuno dalla convinzione che l’eternità sia un’immagine la cui sostanza è il tempo. Questa immagine, questa banale parola arricchita dalle discordanze umane, è ciò di cui mi propongo di narrare la storia» (Jorge Luis Borges, Storia dell’eternità, 1936).
«A furia di sentirla raccontare da mia madre, la scena diventò viva e reale come se avessi conservato il ricordo di quel che era avvenuto, la cavalla che stramazzava morta, mio padre bagnato di sangue, che mi raccoglieva da terra. Avevo dieci mesi, me ne andavo carponi per la veranda della casa al cadere del crepuscolo quando le prime ombre della sera scendevano sui giovani alberi del cacao, sulla foresta vergine, inospitale e antica. Dissodatore di terre, mio padre aveva costruito la sua casa oltre Ferradas, villaggio del recente municipio di Itabuna, aveva piantato il cacao, ricchezza del mondo.
All’epoca delle grandi lotte. La lotta per il possesso delle foreste, terra di nessuno, si dilatava in imboscate, intrighi politici, incontri di banditi nel sud dello Stato di Bahia: si negoziavano animali, armi e la vita umana. In cerca dell’Eldorado, dove far soldi era un gioco da ragazzi, arrivava la manodopera, venuta dall’alto sertão delle secche o dal Sergipe della miseria e della mancanza di lavoro. Pagati ad alte tariffe, i jagunços dallo sparo sicuro erano privilegiati. Le croci segnavano le vie del decantato progresso della regione, i cadaveri concimavano le piantagioni del cacao» (Jorge Amado, Il ragazzo di Bahia, 1982).
In conclusione, come ha scritto Onetti, la letteratura è uno speciale modo di dire la verità.
[di Gian Paolo Caprettini]