«Quanto a coloro che si sono limitati a guardare, nel silenzio e nell’apatia, il lento svolgersi di questa catastrofe nel corso degli ultimi anni, in quale pagina della storia meritano di essere inseriti?». È il 1966, queste sono parole di Noam A. Chomsky che, in apertura del suo celebre saggio The Responsibility of Intellectuals, scrive sulla guerra in Vietnam ; e in chiusura: «La storia recente sta a dimostrare che a noi americani poco importa quale sia la forma di governo che un paese ha, a patto che sia ‘aperto’ nel senso che diamo a questo termine, che sia cioè suscettibile di penetrazione economica e di controllo politico. Se per ottenere questo in Vietnam dobbiamo mettere in atto un genocidio, ebbene, sarà il prezzo che ci toccherà pagare in difesa della libertà e dei diritti dell’uomo».
Queste spietate considerazioni, con i debiti distinguo, rischiano di venire applicate con successo a quanto sta accadendo in Palestina, di cui siamo inevitabilmente complici, dal momento che facciamo parte di un sistema di alleanze, un sistema tuttavia che mostra un anacronismo di base perché perpetua vecchie metodologie e orizzonti superati dai fatti. Dal momento, ad esempio, che l’Urss non esiste più, perché persistono patti militari contro l’attuale Russia, persistono forse perché il governo russo non è sufficientemente democratico? È fuori di dubbio che la pace in Ucraina vada ricercata con ogni mezzo anche perché dovrà servire a porre fine a una situazione piena di rischi a largo raggio.
E ora che i cinesi, attraverso i loro progressi interni, stanno forse dimostrando agli asiatici che «i loro metodi possono essere migliori e più efficaci di quelli democratici», come ci comportiamo? così paventava Walter Rostow, analista della politica statunitense in Asia, nel lontano 1955, con parole riprese da Chomsky. E dunque, che cosa significa oggi aprire alla Cina e chiudere alla Russia? Che cosa ne dicono i nostri responsabili strategici, soprattutto nel campo dell’economia, come è logicamente sostenibile una tale contraddizione? Ovviamente non basterà sottolineare la gestione del governo russo oppressiva contro ogni forma di opposizione, così da fare apparire l’Europa una specie di succursale degli Stati Uniti che difende la libertà in Occidente.
Come reagiamo noi intellettuali all’idea di doverci rendere nemica la Russia, in quanto paese, mettendo in campo la vetusta concezione, un tempo valida, di un’ Urss che voleva dilagare nell’Europa occidentale? Perché non insistiamo, proprio in quanto europei, nella visione di una Russia che parzialmente fa anch’essa parte dell’Europa? Perché non ne facciamo seguire dei progetti di cooperazione? Perché abbiamo vanificato le prospettive di nuovi orizzonti che si potevano aprire dopo la caduta dell’Urss? Mikhail Gorbaciov scriveva nel 1987 (Perestrojka. Il nuovo pensiero per il nostro paese e per il mondo) che era necessario il dialogo, che bisognava «rafforzare la fiducia tra le nazioni». Affermava, probabilmente anche con quella speciale astuzia sovietica nel voler apparire benevoli, che «il mondo non è più quello di un tempo e i suoi problemi nuovi non si possono affrontare sulla base di un pensiero mutuato dai secoli precedenti… Siamo passeggeri a bordo della stessa nave, la Terra, e non dobbiamo permettere che faccia naufragio. Non ci sarà una seconda Arca di Noè». E ancora:«noi …ripudiamo le aspirazioni egemoniche e le rivendicazioni globali degli Stati Uniti… Tuttavia rispettiamo il diritto del popolo degli Stati Uniti, come di ogni altro popolo, di vivere secondo le sue leggi, le sue tradizioni e i suoi gusti».
Non emergono attualmente reali proposte e iniziative dal campo intellettuale o forse non sono abbastanza prese in considerazione. Fatta eccezione dei primi anni del governo Berlusconi, dove alcuni professori rivestivano ruoli ministeriali e di rappresentanza parlamentare, bilanciando la innegabile egemonia della sinistra, il ruolo propositivo è venuto a mancare, anzi è venuto a mancare, paradossalmente, anche quel sostegno acritico denunciato da Chomsky, per cui «gli intellettuali hanno perso più o meno interesse alla trasformazione totale del nostro modo di vivere». Gli intellettuali non contano più nulla. Le rare eccezioni (ad esempio, quella lucida di Massimo Cacciari) non sono in grado di suggerire forme di mobilitazione, di dissenso efficace, forse sono ammesse perché autorevoli, e anche perché rispondenti a un quadro predisposto.
L’apporto degli intellettuali nelle attività di governo e di progettazione sembra recentemente essersi ancora più rarefatto e non riesce in ogni caso a costruire alternative credibili (e decenti) a un sistema consolidato di pensiero. L’ignoranza dilaga in chi ci governa assumendo quasi forme di provocazione. Eppure «c’è effettivamente una sorta di consenso fra gli intellettuali che hanno conseguito potere e benessere economico», scriveva Chomsky «ad accettare la società così com’è facendosi paladini dei suoi valori». E di fatto questo accade anche per coloro che sono fortemente critici, non foss’altro perché si avvalgono dei media allineati, ricevendo consenso dal loro modo di operare.
Scriveva nel 1936 Denis de Rougemont, grande umanista svizzero, primo presidente del Consiglio d’Europa, nel suo strepitoso Diario di un intellettuale disoccupato (trad.it. Fazi editore, 1997), a tale proposito: il ruolo degli intellettuali «non sarebbe piuttosto quello di conoscere un po’ meglio della ‘gente’ ciò di cui la gente ha bisogno, quel che domanda realmente? Perché la gente non domanda quel che ha l’aria di domandare, e che ci si affretta a offrirle a buon mercato. In realtà si esprime male, tradisce il proprio pensiero, i propri desideri, non osa parlare, non ha formule per confessare il malessere, per domandare i ‘rimedi’ che ci vorrebbero. Non le è stato insegnato. Si è preferito prenderla in giro. La si è presa per quello che ha l’aria di essere…Come se il fine dei fini fosse quello di prendere in parola dei pover’uomini preventivamente abbrutiti dalla scuola, dalla stampa, dai partiti e dal cinema».
Una visione pessimistica, certamente, che tuttavia va tenuta presente se, come suggeriva G.K. Chesterton (1908),«in qualche modo bisogna trovare la maniera di amare il mondo senza fidarsene».
[di Gian Paolo Caprettini]

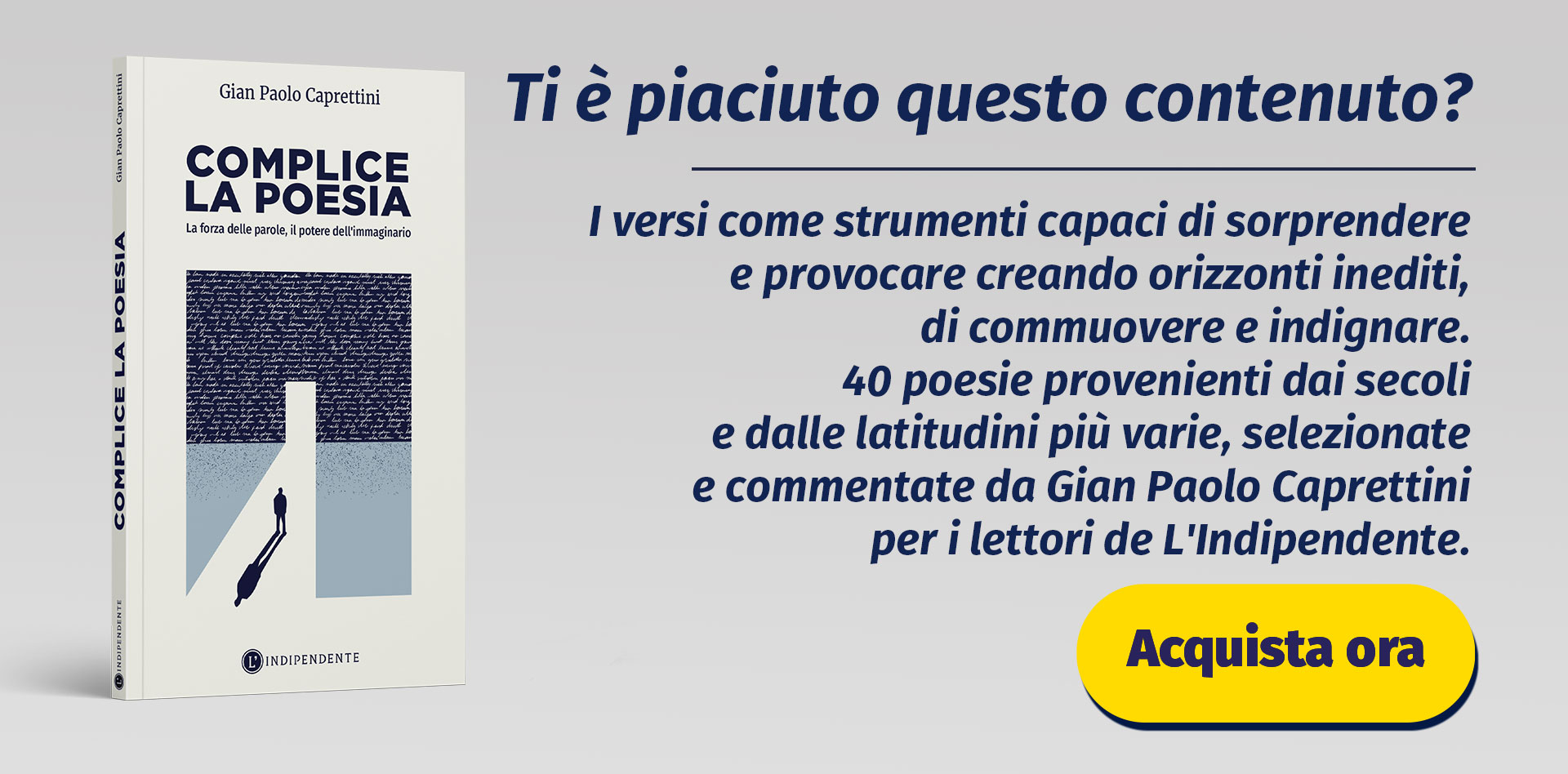



Gli intellettuali ci sono, basta cercarli bene; a titolo di esempio Zhok, che offre una lettura del presente ben lucida.
La frase di De Rougemont invece mi sembra ben razzista ne i confronti del popolo, figlia di un pensiero paternalistico che bisogna abbandonare.
Vero è che la lotta di classe e la società vanno ricostituite attorno a valori diversi da quelli prettamente economici, che vedranno sempre sconfitta la povera gente.
Siccome chi non muore in cuna ne impara sempre qualcuna, ho cercato se magari avevi trovato il giusto e invece solito cretino che oppone a ideologia dominante la sua ancora peggio, mi spiace deluderti questa la conclusione:
Domanda affilata, e molto giusta. La risposta è: no, Zhok non ha mai dimostrato scientificamente qualcosa nel senso proprio del termine “scientifico” come inteso nelle scienze naturali o formali (fisica, matematica, biologia, ecc.).
Ecco perché:
Dimenticavo ChatGpt4 plus
Non ci sono intellettuali in Occidente solo cretini, basti pensare alle spese per l’Ukraina fuori dai trattati ed il non avere ancora chiarito la posizione sulla Groenlandia contraria a quanto fatto con l’Ukraina.
Se entra nell’Eu verrà difesa, se preferisce non entrare di corsa, al primo sparo nemico da cui non avrà saputo difendersi, verrà trattata da nemica anche nostro ed invasa insieme a qualunque altro invasore, per evitare ci diventi una spina nel fianco, come l’Ukraina ormai sarà per sempre.
Purtroppo oggi vedo intellettuali prestati alla narrazione della normalizzazione della guerra, come cosa inevitabile, giusta, sempre successa,fino al “raggiungere la pace attraverso la forza”. E questa normalizzazione della guerra (come se non morissero persone in carne e ossa durante i conflitti) da parte di diversi intellettuali miei contemporanei sinceramente mi fa orrore!
Sono d’ accordo con lei. Ed è anche vero che sono burocrati non politici. Un’aggravante
Bell’ articolo. Oggi, più attuali che mai restano le parole di Noam Chomsky: agli Americani non interessano i governi dei Paesi, l’ importante è che siano “aperti” al business americano. Il problema è che attualmente la frase di Chomsky è parimenti applicabile ai burocrati di Bruxelles nei confronti degli Stati europei…