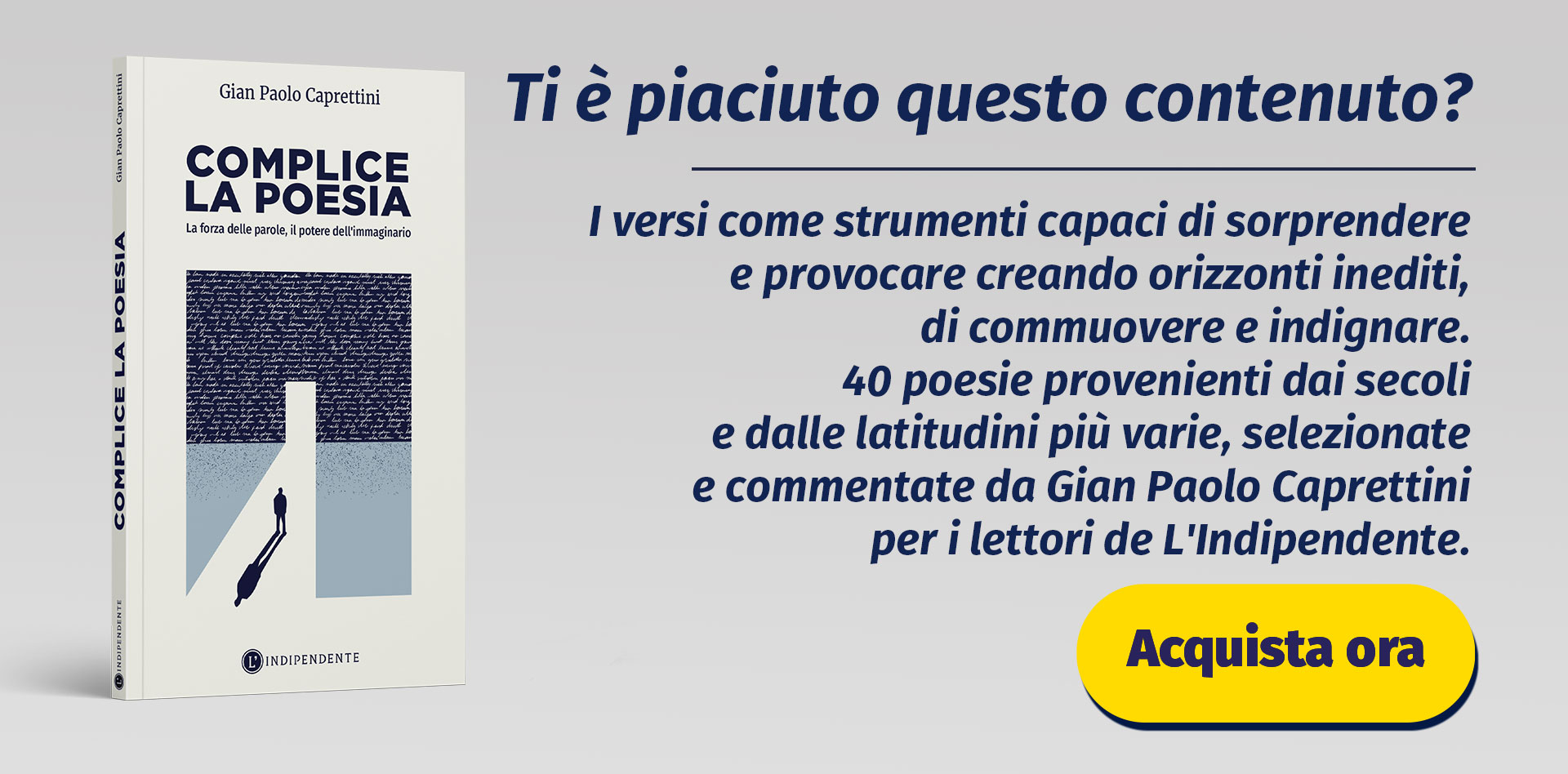“Il diritto, il bisogno di pensare in termini diversi da quelli dell’uso comune“: è una affermazione di Herbert Marcuse, 1964. Ma oggi che cos’è l’uso comune? Quello che si impone nella televisione e nei social a fronte della vita di tutti i giorni? Oppure quello che si sta preparando all’orizzonte come omologazione planetaria dove di consapevolmente comune, anche in modo residuale, non rimarrà più niente? E sul terreno della alimentazione, del cibo, quali sono le condizioni?
Prendiamo alla sprovvista la logica del buon senso e non facciamoci domande sul futuro, sui rischi che corriamo ecc. ecc. Andiamo direttamente sul luogo del delitto, e poi chiediamoci quale può essere il movente. Eccoci dunque in cucina, il luogo più allegorico che ci è rimasto, l’ultima frontiera della produzione simbolica, il fronte bollente della difesa dall’invasione del cibo pianificato, il fortino della diversità, del bollente e del tiepido, dell’unto e del vapore, dell’umido e del secco. Il grande antropologo Claude Lévy Strauss intitolava il suo capolavoro, erano gli anni di Marcuse, Il crudo e il cotto. Da questo principio culinario e metafisico nessuna cultura del mondo transige. Nemmeno le capitalistiche microonde ci sottraggono al bisogno di trovare la giusta temperatura, ciò che il piatto e i commensali richiedono.
Nessuno dunque con successo speri di propinarci, qui o in qualsiasi contrada del mondo, lo stesso cibo preconfezionato, conforme ai profitti dei controllori mondialisti, sterile, neutrale papocchio della loro ipocrisia.
Dopo le straordinarie, molteplici iniziative, ad esempio di Slow Food e Eataly, non è pensabile ridurre l’umanità alle stesse porzioni e scatolette, con il pretesto dell’equa distribuzione. Il cibo è iniquo invece, è giustamente sintomo delle disuguaglianze, dei bisogni. Con tutto ciò saranno i pescatori e i contadini, con la loro fatica e le loro lotte a salvare il mondo, sempre che i consumatori non credano all’ignoranza e al credo distopico degli equalizzatori del mondo.
Viva le cucine etniche e multietniche, le prescrizioni religiose e le trasgressioni, viva le ricette delle più grandi tradizioni e quelle delle più eccessive contaminazioni.
Guardiamo pure i format culinari in tivù con il loro impietoso spirito competitivo, con le ansie e le lacrime, con le loro cucine chirurgiche e i loro giudici intolleranti. Seguiamo i food blogger più intelligenti ma anche quelli scemi, tutto purché in qualche parte oscura del mondo non si preparino le razioni per tutti come se la alimentazione fosse un problema di sopravvivenza. No, è la cucina che deve sopravvivere, la cucina, il tempio dell’oikos, dimora dell’incontro, con i suoi fumi e i suoi profumi, i suoi tempi e i suoi spazi, le sue sconfitte e le sue glorie. La cucina, luogo del sistema nervoso centrale periferico della civiltà, pietra tombale degli oppressori.
Tomaso Garzoni, il fantasmagorico scrittore cinquecentesco, così percorreva con la sua prosa immaginifica e roboante i tratti costitutivi della cucina: “I golosi del loro dio divoti corrono sovente al cerchio dell’Hostarie, come da una campana desti e svegghiati, alla cucina come al tempio, alla dispensa come all’altare; alla cantina come al lavello di sacristia, al pollaro come al luogo delle vittime; e si dilettano del fumo degli arrosti come d’incenso, del colar del grasso come di balsamo, dello stridor delle padelle come di suono d’organo e del friger delle teglie come di canto fermo e figurato insieme. Ebbe questa professione il suo principio in Asia…, e quindi come racconta Tito Livio le morbidezze forastiere… entrarono nella città di Roma, e fu la prima volta allora che le vivande s’incominciarono apparecchiare con maggior cura e spesa, e fu allora che i cuochi salirono in prezzo e, uscendo fuori d’una cucina tutta onta, bagnati ancora di brodo, tinti di fumo, sporchi di grasso, onti di olio, con le pentole, i piatti, il pestello, il mortaio e lo spiedo, entrarono nelle scuole e, drizzando un’Accademia di Leccardia, si cominciarono a far conoscere per maestri e dottori di quanto in tutta la lor arte si ritrova” (Della Piazza Universale di tutte le professioni del mondo, discorso XCIIII).
[di Gian Paolo Caprettini – semiologo, critico televisivo, accademico]