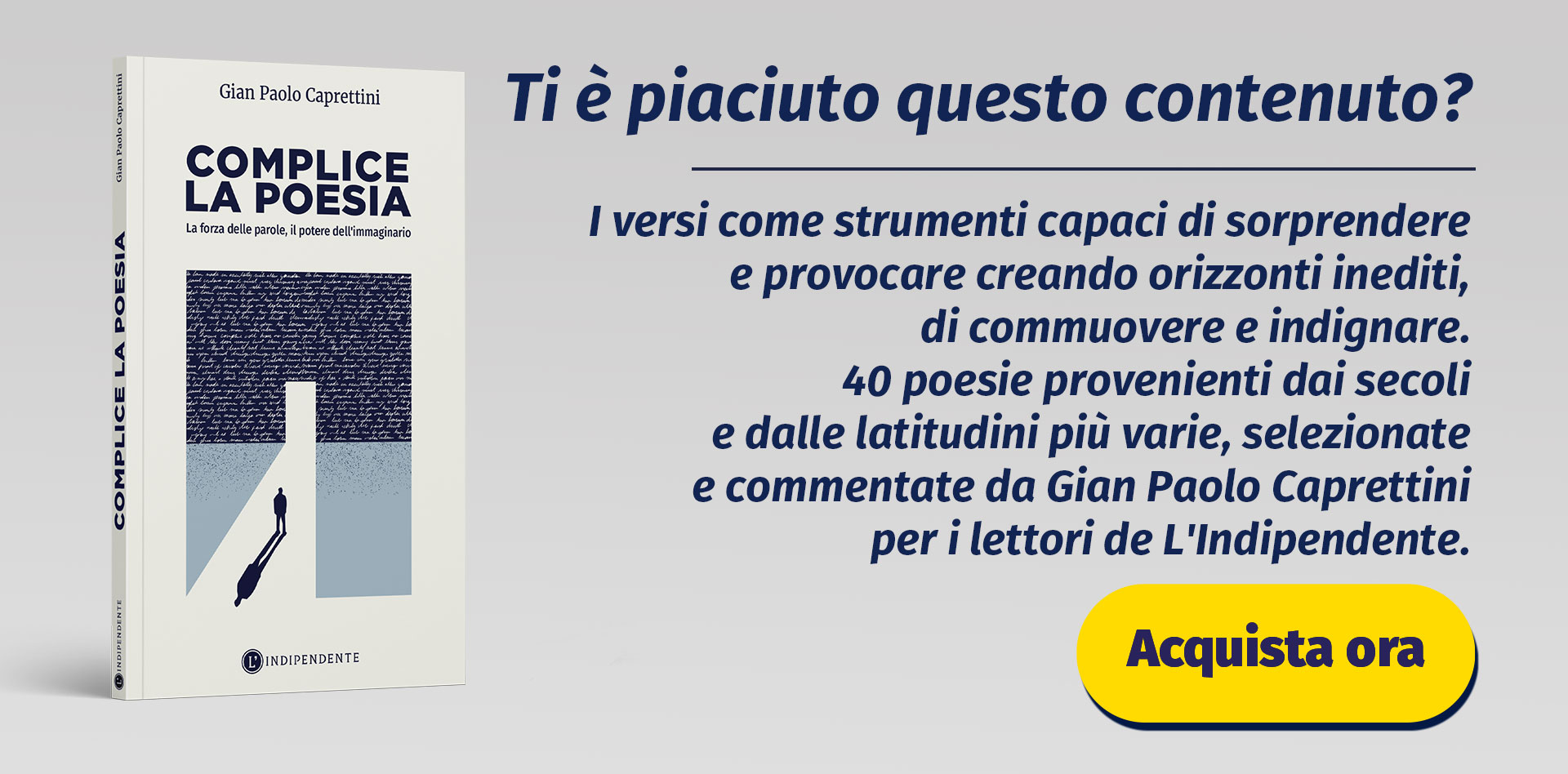Se il sonno fosse (c’è chi dice) una
tregua, un puro riposo della mente,
perché, se ti si desta bruscamente,
senti che t’han rubato una fortuna?
Perché è triste levarsi presto? L’ora
Ci deruba d’un dono inconcepibile,
intimo al punto da esser traducibile
solo in sopore, che la veglia dora
di sogni, forse pallidi riflessi
interrotti dei tesori dell’ombra,
d’un mondo intemporale, senza nome,
che già il giorno deforma nei suoi specchi.
Chi sarai questa notte nell’oscuro
Sonno, dall’altra parte del suo muro?
Desiderio di realtà. Sembra questo ciò che Borges tace in questa poesia, densa tutta delle sue immagini sfuocate, abitate da un bisogno di persistere nell’immaginario, nelle ombre del mondo e negli angoli oscuri della veglia dove il sogno fatica a imporsi, anche se si affaccia come la vera realtà.
Borges ha amato più la chiaroveggenza che la chiarezza, convinto che la molteplicità e i labirinti generassero “arabeschi da caleidoscopio”, convinto, come un medievale, che ci fosse più verità nei libri che nei fatti, quei libri “che sono parte di me”, come le mie tempie e i miei occhi grigi, dice in altre poesie.
Ritenere che il retaggio della memoria storica, di quella immaginaria e di quella effettiva, disegni l’identità delle cose, che in fondo la verità venga dal passato, fantasticare che gli oggetti siano enigmi da decifrare e che le sensazioni siano ingannevoli perché stratificate, contraddittorie, indefinite e complesse, porta a credere che la vita si identifichi con la scrittura, e che quindi la notte e il sogno trasmettano più evidenze della realtà percepibile.
La “fatica magica” della notte, scrive in un’altra poesia, esprime le sue ramificazioni infinite, disfa quell’universo che la ragione vorrebbe controllare una volta per tutte.
Il tempo è dunque un abisso senza fondo, l’immaginario è una matrice fantascientifica che annienta le pretese del tempo di accamparsi negli spazi e negli eventi con un determinismo oggettivo, fuori da ogni fantasia.
Credo che Borges, quando afferma che “nel corso della vita ci sono accadimenti modesti che possono essere un dono” (Atlante, 1984), ci spinga a un esercizio creativo: quello di cogliere nelle pieghe della banalità quotidiana i germi della magia, le vie di una liberazione dall’ovvio.
Non è necessaria la maestria di un artista. Bastano le “povere vesti di un ospite”, cantava Omero nell’Odissea, basta ascoltare un brano musicale che ci incanti, basta imparare ad ascoltare gli altri, trasformando in mito, in valore originale i fatti più ordinari di una vita.
Sfuggire dunque alle trappole dell’ovvio, degli echi scontati, ripetitivi di chi vuole continuamente fornirci spiegazioni.
Nell’epoca dei media usati come armi di conformismo, obbedire ai sogni invece che ai comandi di una burocrazia impietosa è già una forma di libertà e di emancipazione. Fare vincere l’ideale contro la spietatezza dell’evidenza è già qualcosa.
Convincersi di compiti alti, quanto meno nei confronti di noi stessi. Abbattere i confini che ci imprigionano. “Sei ogni solitario istante”, scriveva Borges in un’altra sua poesia. Io, tu, noi siamo autori di ciò che ci accade, non soltanto lettori o spettatori. Occorre diventare di conseguenza registi immaginari di quelle avventure e di quelle incertezze che ci regalano stupore, non farci determinare dall’oblio e dalla disattenzione. Superare le censure, osare.
Credere dunque ai sogni e al loro speciale modo di dire la verità.
[di Gian Paolo Caprettini – semiologo, critico televisivo, accademico]