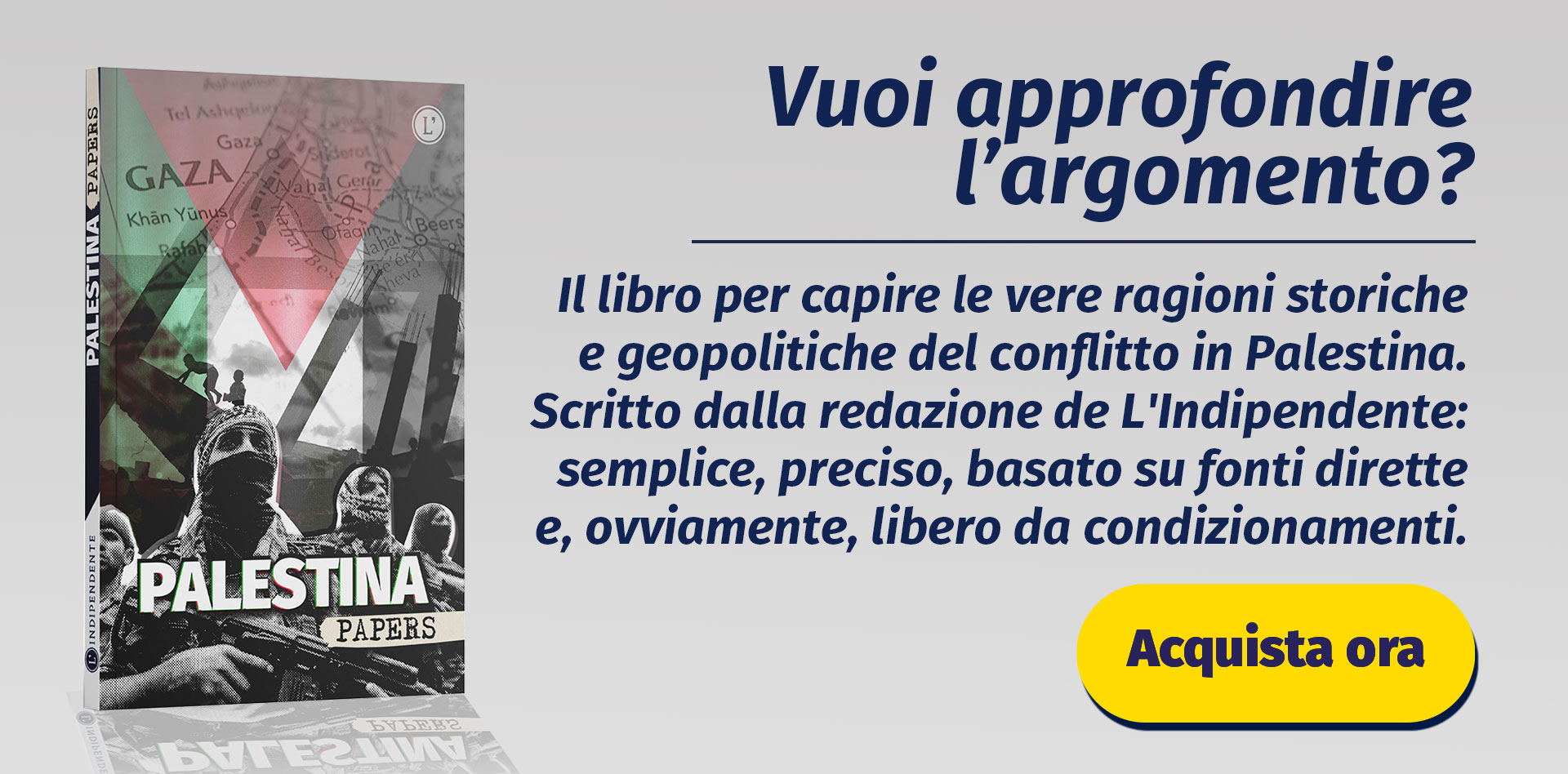Con 204 voti a favore e 85 contrari, il Parlamento sudcoreano ha approvato la mozione di impeachment contro il presidente Yoon. Per essere approvata, la mozione richiedeva il voto favorevole di due terzi dell’Assemblea, composta da 300 membri. Ora si attende il giudizio della Corte Costituzionale, che ha sei mesi di tempo per confermare o respingere l’impeachment del presidente. La mozione era stata già sottoposta a votazione, ma non era stata approvata a causa dell’opposizione del Partito del Potere Popolare, il partito del presidente. Yoon è stato oggetto di impeachment in seguito al tentativo di instaurare la legge marziale lo scorso 3 dicembre.
Le bugie nel mondo dei cosmetici: non è tutto buono ciò che è bio
L’ecologia di facciata (o greenwashing) è appannaggio di quasi tutte le industrie: da quella alimentare a quella della moda, passando per quella tecnologia fino a quella dell’energia. Non si salva nessuno. Nemmeno il mondo dei cosmetici, nonostante confezioni colorate di verde e preziose diciture “bio” sui prodotti. Tutto ciò accade, come sempre, per la mancanza di regolamentazioni chiare riguardo a cosa significhi «naturale» o «biologico» nei cosmetici, andando ad alimentare la confusione tra i consumatori e, nello stesso tempo, permettendo alle aziende di presentare i loro prodotti come più sostenibili di quanto non siano realmente.
Creare confusione con le parole (e con l’opacità)
Osservando il proliferare di confezioni che ammiccano alla sostenibilità, tra prodotti «puliti» e bollini «cruelty free», il dubbio sulla veridicità delle informazioni riportate è sorto più di una volta. I vaghi termini del marketing, come succede nella moda, sono spesso uno specchietto per attirare consumatori distratti. Secondo un rapporto della piattaforma Good on You, che si occupa di valutare la veridicità dei criteri di sostenibilità millantati dalle aziende, dopo aver analizzato circa 240 marchi di cosmetica, ha rilevato che «c’è un livello generale di trasparenza inferiore nel settore della bellezza rispetto alla moda». Questo perché la filiera della cosmesi è frammentata quanto, se non di più, quella del fashion. Un singolo tubetto di crema, ad esempio, potrebbe essere stato progettato in Italia e riempito in Cina prima di essere venduto in Canada. Al suo interno si possono trovare tantissime materie prime, ciascuna delle quali proveniente da una catena di approvvigionamento differente, alla quale spesso è difficile risalire. Tante volte i marchi fanno addirittura fatica a fornire le informazioni sugli ingredienti di base che compongono i prodotti! Una mancanza importante, visto che i cosmetici entrano in contatto con l’organo più esteso del nostro corpo: la pelle! Inutile dire che l’impatto di questa carenza (o omissione volontaria) di informazioni ha delle notevoli ripercussioni sulla salute umana. Così come a livello ambientale.

Molte delle materie prime utilizzate, infatti, sono connesse con lo sfruttamento e la distruzione ambientale, ma anche con la violazione dei diritti umani. A partire dall’olio di palma, utilizzato comunemente per le sue qualità idratanti, e responsabile della deforestazione di intere zone. Secondo il report, tutti i marchi analizzati utilizzano questo ingrediente, ma meno della metà conosce la sua provenienza; solo il 17% usa olio da fonti certificate. Stessa carenza di dati è stata rilevata anche per quanto riguarda i test sugli animali: quasi l’80% dei marchi analizzati non aveva alcuna certificazione che dimostrasse di non testare sugli animali. Tra opacità, carenza di informazioni ed etichette ingannevoli, destreggiarsi nel reparto cosmetica sta diventando sempre più complicato.
Oltre le apparenze: cosa cercare nelle etichette
Non lasciarsi abbindolare dall’estetica «verde» delle confezioni, andare oltre alle parole di facciata come «consapevole», «ecobio», «sostenibile» o «amico dall’ambiente», sono i due primi passi fondamentali per approcciarsi in maniera critica ai prodotti di bellezza. In seconda battuta, controllare la lista degli ingredienti (il famoso “inci” – International nomenclature of cosmetic ingredients), per verificare la presenza e la quantità dei presunti ingredienti di origine naturale. Un prodotto che si auto-definisce green, per essere di buona qualità, dovrebbe contenere almeno il 98/99% di questi elementi, mentre la minima parte restante sono stabilizzanti e conservanti, indispensabili per la sicurezza e la durata del cosmetico. Gli ingredienti naturali, inoltre, dovrebbero essere in alto nella lista, dimostrando di essere la percentuale maggiore contenuta nel prodotto (più gli ingredienti eco sono in alto, più il cosmetico può definirsi naturale).

Altro aspetto da valutare è la presenza o meno di sostanze non biodegradabili all’interno del prodotto; queste ultime sono molto impattanti sia per l’ambiente sia per gli organismi che lo abitano. Tra gli inquinanti più dannosi, oltre ai profumi, ci sono siliconi, petrolati e le microplastiche (al momento vietate per legge nei detergenti ed esfolianti a risciacquo, ma ancora presenti in altre formule) che spesso, nella lista ingredienti, appaiono con nomi insospettabili come Polyethylene (PE), Polymethyl methacrylate (PMMA), Nylon, Polyethylene terephthalate (PET) o Polypropylene (PP).
Tra le sostanze sintetiche da tenere d’occhio, ci sono anche silossani, tensioattivi anionici e parabeni. Questi ultimi, sospettati di fungere da interferenti endocrini (ovvero disturbare la normale funzionalità ormonale del corpo umano), oltre che danneggiare l’ecosistema marino, dovrebbero essere completamente assenti in un prodotto che si dichiara bio o eco-friendly. Conservanti sì, ma che almeno siano biocompatibili, come acido benzoico, sodio benzoato, acido sorbico e i suoi sali, potassio sorbato e sodio sorbato, tocoferolo (vitamina E) oppure oli essenziali come il tea tree oil (che in buone percentuali può funzionare da conservante).
In generale, meno ingredienti sono presenti e più informazioni dettagliate ci sono, minore è il rischio di incorrere in operazioni di greenwashing. In caso di dubbio, affidarsi a strumenti come la app Good on You o controllare gli ingredienti sul Biodizionario Cosmetico presente online, può essere un ulteriore supporto per scelte consapevoli e ben ponderate da chi ha davvero a cuore la propria pelle (e anche l’ecosistema in cui vive).
[Marina Savarese]
Sciopero generale, scontri a Torino tra studenti e forze dell’ordine
Questa mattina a Torino si sono verificati alcuni scontri tra le forze dell’ordine e gli studenti che manifestavano nell’ambito dello sciopero nazionale contro il governo. Gli agenti avrebbero infatti reagito con cariche al lancio di uova e pietre da parte dei manifestanti di fronte alla sede del Politecnico. Successivamente, il corteo si è spostato di fronte alla sede della Rai in via Verdi, per contestare la disinformazione diffusa dalla televisione di Stato in merito agli eventi in Medio Oriente. Uno studente si troverebbe in stato di fermo. «La repressione ha colpito duro sulle teste degli studenti che rivendicavano soldi alla formazione e non alla guerra», hanno scritto i collettivi sui social.
Bruxelles salva la pesca a strascico: altra vittoria contro l’ambiente del governo Meloni
Per l’intero 2025 i pescherecci italiani a strascico non dovranno ridurre i giorni di pesca. È questo il risultato ottenuto dall’Italia e un’altra manciata di Stati Membri a Bruxelles. «È la prima volta che l’Italia ottiene un simile successo», ha commentato soddisfatto il ministro dell’Agricoltura italiano, Francesco Lolloobrigida. La proposta iniziale prevedeva per l’Italia il 39% di riduzione dei giorni di pesca a strascico per il 2025 ma, grazie a un articolato pacchetto di misure di compensazione, l’Italia ha potuto in pratica annullare l’intero taglio proposto dalla Commissione, con il plauso di tutto le associazioni di categoria. Un traguardo però tutt’altro che positivo per l’ecosistema marino dato che la pesca a strascico, in quanto tecnica non selettiva, è in assoluto la più impattante sulla fauna e i fondali.
La decisione è stata presa dal Consiglio UE Agricoltura a seguito del raggiungimento di un accordo tra i ministri UE dell’Agricoltura, arrivato dopo giorni di intensi negoziati segnati dalle richieste di Italia, Francia e Spagna di limitare il taglio dei giorni di pesca nel Mediterraneo proposto dalla Commissione europea alla fine di novembre. Le riduzioni proposte dall’esecutivo UE saranno mantenute, in media -66% per i pescherecci a strascico, di cui -79% per la Spagna, -40% per la Francia e -39% per l’Italia, ma i Paesi potranno attuare una serie di misure per compensare queste riduzioni. Il che vale a dire che i giorni in cui i pescherecchi potranno operare mediante reti a strascico resterà invariato rispetto al 2024. L’accordo in particolare introduce dei meccanismi che consentono ai Paesi di continuare a pescare indisturbati se adottano alcune misure di gestione, come il miglioramento della dimensione delle maglie, le chiusure stagionali e gli attrezzi da pesca selettivi. Tuttavia, che l’adozione di tali misure mitighi effettivamente i danni della pesca a strascico è tutt’altro che accertato.
La pesca a strascico è una tecnica di pesca industriale che sfrutta grandi reti trainate sul fondo del mare o sospese nella colonna d’acqua. Tali reti sono spesso dotate di pesi per mantenerle a contatto con il fondale e possono essere lunghe centinaia di metri. Nella pesca a strascico demersale, le reti vengono trascinate direttamente sul fondale marino, catturando le cosiddette specie bentoniche, ovvero quelle che hanno rapporti con il fondo del mare, sia in maniera permanente che temporanea. Nella pesca a strascico pelagica, le reti vengono invece trascinate nella colonna d’acqua, senza toccare il fondale, per catturare pesci che vivono a mezz’acqua. In entrambi i casi le catture portano al prelievo di grandi quantità di esemplari ittici, ma nelle reti finiscono anche molte specie non bersaglio, che vengono rigettate a mare, spesso morte o ferite. Il movimento delle reti disturba inoltre i sedimenti marini, rilasciando il carbonio precedentemente immagazzinato nei fondali, al punto che ogni anno si stimano emissioni pari a 370 milioni di tonnellate di CO₂ causate da questa pratica. Nel complesso, come è noto già da decenni, la pesca a strascico ha un impatto profondamente distruttivo sugli ecosistemi marini, determinando direttamente l’alterazione degli habitat, delle reti alimentari, dei cicli naturali e, in definitiva, la riduzione della biodiversità. La stessa biodiversità, paradosso vuole, che è fondamentale per il mantenimento degli stock ittici tanto difesi dalla politica.
Si è stimato che nel Mediterraneo il 96% degli stock ittici sia sovrasfruttato e pescato principalmente utilizzando reti a strascico. In Europa, tra il 2015 e il 2023, sono state registrate 4,4 milioni di ore di pesca a strascico, anche in aree marine protette. Il risultato, senza mezzi termini, è che tra qualche decennio potrebbe non esserci più pesce da pescare. Se da un lato, nel breve periodo, la riduzione di tale pratica darebbe un bel colpo economico al settore ittico, dall’altro, rappresenta l’unica via per garantire la sostenibilità a lungo termine della pesca. E, si badi bene, sostenibilità non indica solamente la solita svolta “verde” tanto richiesta dall’Europa. In questo caso, sostenibilità è anche un termine tecnico che significa pescare quantità tali da permettere alle popolazioni biologiche di recuperare attraverso la riproduzione i numeri persi, quindi, di continuare a rappresentare delle risorse per l’umanità. Un concetto che tuttavia viene difficilmente afferrato, l’importante è difendere l’economia ora e ad ogni costo.
«Ogni anno – ha commentato ciecamente Lollobrigida – la Commissione Europea propone tagli che minacciano la sopravvivenza della flotta peschereccia, ma questa volta gli interessi della Nazione sono stati difesi con fermezza, dimostrando l’efficacia della strategia negoziale adottata. Le ragioni italiane sono state fatte valere in Europa, garantendo stabilità e prospettive di crescita a un comparto essenziale per l’economia». Una posizione che non guarda oltre e che contrasta con le stesse prospettive di crescita citate. Coerentemente con la linea politica ambientale dell’esecutivo Meloni, già l’anno scorso l’Italia era stato l’unico Paese UE ad opporsi all’eliminazione della pesca a strascico. “Ambientalismo non ideologico”, lo chiamano. Tradotto: l’ambiente va tutelato a patto che non interferisca in alcun modo con gli interessi economici ed industriali. Eppure a dire che l’iniziativa economica privata non può svolgersi in modo da recare danno all’ambiente non lo dice l’ambientalista di turno, bensì la nostra stessa Costituzione.
[di Simone Valeri]
“Costretti a dormire in fabbrica”: gli operai di Forlì bloccano l’azienda
Immaginate di essere stati assunti come operai per una ditta che produce mobili. Siete disoccupati, il lavoro è a 200 km da casa, ma vi promettono un alloggio e uno stipendio adeguato. Accettate l’offerta e partite alla ricerca di un futuro migliore. Invece vi ritrovate a lavorare 12 ore al giorno, venendo pagati solo per 8, per sei giorni alla settimana. Le condizioni di lavoro sono prive di sicurezza e vi tocca dormire nello stesso capannone in cui lavorate, senza riscaldamento, su materassi buttati per terra. È quanto accaduto a un gruppo di operai pakistani reclutati a Prato da una ditta, la Sofalegname, che produce mobili imbottiti a Forlì. «Avevano detto che col tempo ci avrebbero trovato una casa – racconta uno di loro – ma il tempo passava e noi restavamo sempre lì, nel magazzino». Dopo otto mesi, con l’arrivo dell’inverno, la situazione è diventata insostenibile. Così i 17 operai della ditta hanno occupato gli uffici riscaldati dello stabilimento, dove ora dormono, e hanno allestito un presidio davanti alla Gruppo 8, l’azienda madre che subappalta il lavoro alla Sofalegname. La sede della Gruppo 8 si trova a poche centinaia di metri di distanza.
Da sabato 7 dicembre, ogni mattina, gli operai accendono un fuoco per scaldarsi e si siedono davanti ai cancelli, bloccando di fatto la produzione di entrambi gli stabilimenti. Sopra di loro sventolano alcune bandiere con scritto «8 X 5». «Significa 8 ore per 5 giorni di lavoro – spiega Sarah Caudiero, sindacalista di Sudd Cobas – è questa la loro richiesta, oltre naturalmente a ottenere una sistemazione dignitosa». Richieste che rappresenterebbero il minimo sindacale in una situazione normale. «Stiamo parlando della semplice applicazione del contratto collettivo nazionale – continua Caudiero – invece ci troviamo davanti a una realtà pianificata per abbattere i costi, a scapito della dignità dei lavoratori».
Una forma di sfruttamento alla luce del sole, ben nota ai sindacalisti di Sudd Cobas che operano a Prato. In quella città gli alloggi di fortuna ricavati direttamente nelle fabbriche per gli operai cinesi sono stati una prassi fino al 2013, quando un incendio nell’azienda tessile Teresa Moda causò la morte di otto persone, sorprese nel sonno dalle fiamme. Per quella tragedia le due titolari dell’azienda sono state condannate, ma nel frattempo sono tornate in Cina. Anche la Gruppo 8 di Forlì ha legami con la Cina: fa capo alla multinazionale della moda HTL, con sede a Singapore. «A Prato, nel corso degli anni, i controlli sono aumentati e le condizioni di lavoro sono migliorate, anche se persistono turni massacranti e sottopagati – continua Caudiero – mentre a Forlì regna la confusione».
Forlì si trova infatti in una delle zone dove, negli ultimi anni, il settore del mobile è cresciuto significativamente. Secondo un rapporto di Intesa Sanpaolo, nel 2023 le esportazioni sono aumentate del 63,3% rispetto al 2019. La Romagna rappresenta infatti un “Distretto del’imbottito” composto da oltre 300 aziende, molte delle quali piccole o piccolissime, le quali operano in un contesto fertile – anche grazie, secondo la CGIL, alla mancanza di controlli. «Queste persone vengono qui per lavorare, ma si trovano in condizioni disumane – spiega Antonella Arfelli di Fillea CGIL – Giovedì scorso abbiamo partecipato a un tavolo con la Prefettura, chiedendo maggiore attenzione da parte delle forze dell’ordine, affinché casi come questo emergano più spesso».
E l’azienda? Gruppo 8, attraverso il suo legale Massimiliano Pompignoli, consigliere comunale di Fratelli d’Italia, respinge le accuse, dichiarandosi estranea alla vicenda, scaricando la colpa sulla Sofalegname e minacciando di prendere provvedimenti. Durante l’incontro con i sindacati, avvenuto giovedì mattina, si è persino ipotizzata la cassa integrazione per tutti gli operai, a causa del blocco dello stabilimento e delle consegne che non vengono portate a termine. Una sorta di scaricabarile tra Gruppo 8 e Sofalegname, mentre i lavoratori restano nel mezzo. «Si sta interrompendo l’attività dell’azienda senza alcun fondamento, creando enormi disagi sia dal punto di vista lavorativo che economico», ha dichiarato Pompignoli.
Una parola, «disagi», che sembra un insulto alla realtà, di fronte alle condizioni di vita di 17 persone costrette, da otto mesi, a dormire in un magazzino.
[di Fulvio Zappatore]
Francia, Macron sceglie il centrista Bayrou come nuovo premier
Il nuovo premier francese è il politico centrista François Bayrou. Lo ha reso noto il presidente Emmanuel Macron, che stamani aveva avuto con il leader del MoDem, principale forza politica di centro, un colloquio di quasi due ore. Bayrou subentra al gollista Michel Barnier, che lo scorso settembre era stato nominato dal presidente francese alla guida del governo ed è stato sfiduciato in Parlamento ad appena tre mesi dal suo insediamento. Bayrou avrà il difficile compito di formare un esecutivo in grado di sopravvivere a una Assemblea nazionale senza maggioranza.
Il Word Economic Forum indica Israele come esempio del “grande reset alimentare”
Il World Economic Forum (WEF), la potente organizzazione dell’élite finanziaria globale che ogni anno si riunisce a Davos influenzando le decisioni dei governi, ha individuato in Israele il capofila di quella trasformazione alimentare all’insegna delle proteine alternative che costituisce uno dei capisaldi dei progetti del WEF per il mondo del futuro, sempre più digitalizzato e dominato dalle tecnologie della Quarta rivoluzione industriale. Se quest’ultima, con le sue tecnologie “futuristiche” (intelligenza artificiale, nanotecnologie, biotecnologie, l’Internet delle cose (IoT)), promette un grande reset socioculturale, lavorativo e antropologico, il nascente mercanto delle proteine alternative – che per ora stenta a decollare – è la chiave del grande reset alimentare che, secondo i sacerdoti di Davos, sarebbe indispensabile per fermare il riscaldamento globale e garantire “la sicurezza alimentare”. “Guardando al 2030, la produzione di proteine alternative rappresenta un’opportunità significativa per migliorare la sostenibilità e la circolarità all’interno della filiera alimentare”, si legge nel report del WEF intitolato “Creating a Vibrant Food Innovation Ecosystem”. In quanto Nazione all’avanguardia in questo settore, secondo il rapporto, “Esaminando Israele come caso di studio, si possono identificare spunti più ampi che altri paesi possono seguire, utilizzando risorse locali e sottolineando l’importanza della collaborazione internazionale in questo settore per dare forma al futuro del cibo”.
Israele risulta il più grande investitore globale in proteine alternative – ottenute attraverso tre tecnologie: carne coltivata in laboratorio, derivata dalle piante e fermentata – dopo gli Stati Uniti: Tel Aviv, infatti, nel 2023 ha speso ben 1,2 miliardi di dollari in questo campo, dietro solo a Washington con un investimento di 10,2 miliardi di dollari. Il mix vincente di Israele è costituito da una stretta sinergia tra conoscenze accademiche multidisciplinari, un ambiente imprenditoriale dinamico e propenso al rischio e un coinvolgimento attivo del settore pubblico. Secondo il WEF, infatti, i governi hanno un ruolo fondamentale in questa svolta verso il “cibo del futuro”. Nello Stato ebraico, ci sono più di 70 ricercatori che lavorano allo sviluppo di proteine alternative, oltre a più di 300 scienziati che lavorano in settori paralleli, quali biotecnologie, microbiologia e prodotti farmaceutici. L’Università di Hebron e il Volcani Center (il centro nazionale di ricerca e sviluppo agricolo di Israele) sono le istituzioni con il più alto numero di progetti sulle proteine alternative del Paese. «La leadership di Israele nelle proteine alternative è una testimonianza dell’impegno dell’Innovation Authority (Autorità dell’Innovazione) per l’innovazione nel settore alimentare. Oltre il 75% degli investimenti dell’Authority in tecnologie alimentari è indirizzato verso tecnologie profonde ad alto rischio. Consentiamo lo sviluppo di settori verticali di crescita come incubatori alimentari e consorzi collaborativi quali il Cultivated Meat Consortium, nonché il finanziamento diretto di aziende, dalle start-up in fase iniziale fino alle aziende mature con linee di produzione», ha affermato Ronit Eshel, capo dell’Innovation Authority di israele.
Nel 2023, in Israele, si è registrato un record di 15 nuove start-up nel settore delle proteine alternative, dedicate allo sviluppo di tutte e tre le tecnologie (carni coltivate, vegetali e fermentate). A partire da gennaio 2024, invece, Israele ha 73 start-up attive solo in questo settore e più di 200 start-up nelle tecnologie alimentari nel loro complesso. Secondo l’amministratore delegato (Ad) del Good Food Institute di Israele, Nir Goldstein, «I sistemi alimentari globali affrontano sfide immense, dai fallimenti nella filiera alimentare globale ai declini macroeconomici e alle tensioni geopolitiche che sottolineano la necessità di soluzioni trasformative. Il raggiungimento di zero emissioni nette e la creazione di sistemi alimentari resilienti richiedono l’adozione diffusa di tecnologie proteiche innovative e l’ecosistema israeliano sta tracciando la strada». Secondo il WEF per affermare il grande reset alimentare c’è ancora molta strada da fare, in quanto molte nazioni non stanno investendo in questo settore: “per accelerare la transizione proteica alla scala e al ritmo richiesti sono necessari livelli molto più alti d’investimento”. Come esempi di Stati “virtuosi” che si stanno muovendo in questa direzione, il rapporto dell’organizzazione di Davos cita Danimarca, Singapore e Paesi Bassi. A livello d’investimenti, dopo Stati Uniti e Israele si collocano Svezia, Regno Unito, Cile, Australia, Francia, Singapore, Paesi Bassi e Cina.
Il progetto del Grande Reset – un piano proposto dal fondatore del WEF, l’ingegnere ed economista tedesco Klaus Schwab, e dall’allora Principe del Galles, ora re Carlo III, nel maggio 2020 – nella sua versione alimentare mira a ridurre anche l’agricoltura e il cibo a entità artificiali create in laboratorio e controllate dall’uomo stesso. Quest’ultimo, oltre a voler essere artefice di se stesso (transumanesimo), punta inevitabilmente a voler controllare anche l’alimentazione, nella sua versione artificiale, lontana dai criteri di produzione naturali. Il rischio è quello di un accentramento sempre più esclusivo della produzione alimentare nelle mani di poche multinazionali, a causa degli alti costi di produzione e delle tecnologie necessarie per sviluppare le proteine alternative. Allo stesso tempo, gli eventuali rischi per la salute connessi a questo tipo di tecnologie alimentari non sono presi in considerazione. In questo contesto, grazie alla sua superiorità tecnologica e alla visione di vedute comune con il WEF, Israele viene indicato come esempio virtuoso, mentre gli adepti del circolo di Davos ignorano completamente la strage che sta perpetrando a Gaza, dove i palestinesi soffrono una grave carestia alimentare ormai da più di un anno.
[di Giorgia Audiello]
NAS, controlli su B&B: irregolare 1 su 5
In tutta Italia i Nas dei Carabinieri hanno svolto controlli sui Bed and Breakfast, anche in vista del Giubileo, riscontrando irregolarità in una struttura su 5. Ad alzare la media è proprio la città di Roma, in cui sono fuori regola 7 B&B su 30 verificati. Su oltre mille strutture ricettive controllate, ne risultano irregolari 200 per autorizzazioni, aumento della capacità ricettiva, carenze igienico-sanitarie e violazioni in materia di sicurezza. Dieci le strutture sequestrate o sospese, per un valore di 3,5 milioni. Tra i sequestri, nella provincia di Pescara, c’è anche un B&B totalmente abusivo allestito in un garage di un’abitazione privata.