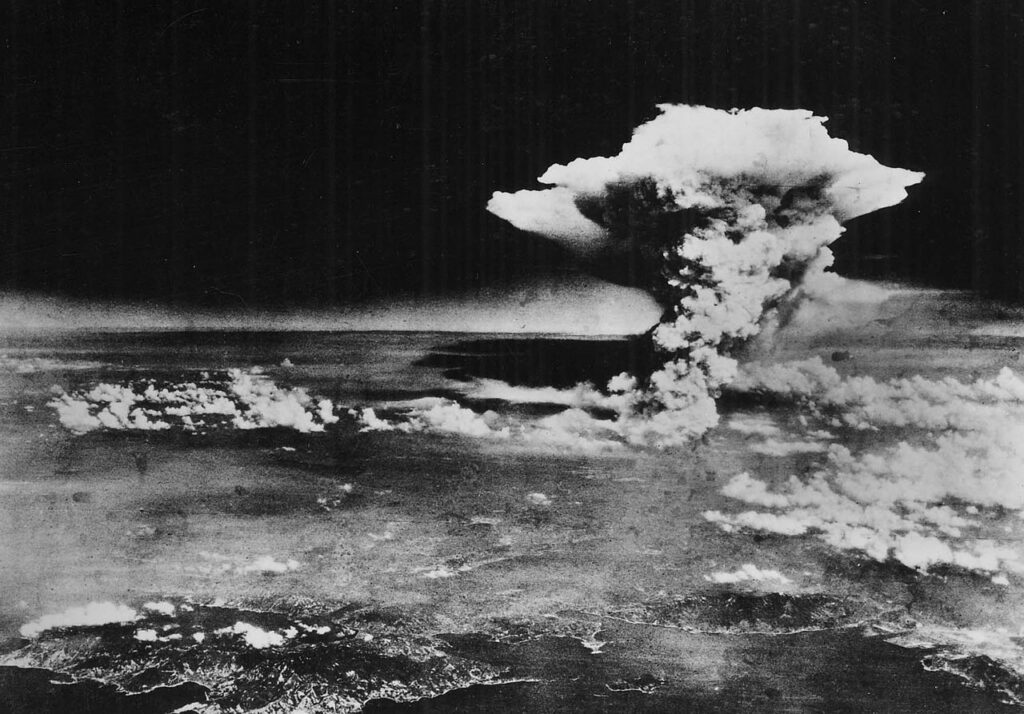Manca solo l’annuncio ufficiale: dopo la chiamata della Pennsylvania dalla maggior parte dei network statunitensi, il candidato repubblicano Donald Trump è a un passo dalla vittoria delle elezioni presidenziali 2024. L’emittente Fox News dà già per vincitore il tycoon, con 277 grandi elettori sui 270 necessari a ottenere la presidenza, mentre CNN, CBS ed ABC gli assicurano oltre 260 voti. Anche la più prudente Associated Press dipinge una vittoria ormai quasi certa del candidato repubblicano, pre-assegnandogli 267 seggi. Da tutti gli exit poll, inoltre, appare certa una maggioranza assoluta repubblicana in Senato, e sempre più vicina quella della camera dei rappresentanti. Sembra prefigurarsi come una vittoria totale, insomma, quella di Donald Trump, che è già salito sul palco del proprio quartier generale elettorale a West Palm Beach per ringraziare i propri sostenitori e reclamare la vittoria. Nel frattempo, dai vari leader del mondo iniziano già ad arrivare i primi messaggi di congratulazioni a Trump: tra i tanti, Macron, Netanyahu, e Zelensky hanno già diffuso un messaggio in cui riconoscono la vittoria del candidato repubblicano, augurandogli una buona presidenza.
I seggi per le elezioni presidenziali statunitensi sono ufficialmente chiusi alle 7:00 (ora italiana), quando anche l’Alaska ha chiuso le tende delle proprie cabine elettorali. Per avere i risultati ufficiali si dovrà presumibilmente attendere ancora qualche ora, ma la vittoria di Trump appare praticamente certa e schiacciante: Fox News gli assegna 277 seggi, Associated Press 267, CNN, ABC e CBS gliene attribuiscono 266. Tutti i maggiori network statunitensi, inoltre, danno ormai per scontata la vittoria repubblicana al Senato, e dipingono di rosso (il colore simbolo dei repubblicani) anche la Camera dei Rappresentanti; sembra insomma prospettarsi un trionfo a 360 gradi per Trump, che è già andato a congratularsi con i suoi elettori.
Dei sette swing state (Stati in bilico) tutte le principali emittenti statunitensi ne assegnano almeno 3 a Trump: Pennsylvania (che, coi suoi 19 grandi elettori, risultava sin da subito lo Stato chiave di queste elezioni), Georgia (16 grandi elettori) e North Carolina (16). Quella della chiamata è una tradizione elettorale di giornali, agenzie di stampa e grandi network televisivi, che, ottenuto il via libera dal cosiddetto “decision desk” – un gruppo di analisti, esperti, e statistici – decidono di dichiarare il proprio vincitore in un determinato Stato. Gli altri swing state sembrano essere tutti a maggioranza repubblicana, specialmente per quanto riguarda il Wisconsin (10) e il Michigan (15). Fox News ha già assegnato il Wisconsin a Trump. I due swing state rimanenti sono Arizona (11) e Nevada (6).
Per vincere la corsa alla presidenza, i candidati devono ottenere almeno 270 dei 538 grandi elettori distribuiti nei cinquanta Stati federati del Paese; il Collegio elettorale statunitense è infatti composto da 538 elettori che votano per le due cariche di presidente e vicepresidente a maggioranza assoluta. Ogni Stato fornisce un numero di elettori in proporzione alla popolazione. Sebbene in cabina elettorale i cittadini statunitensi scelgano un candidato presidente, il loro voto serve (a eccezione di Maine e Nebraska) a determinare i grandi elettori dello Stato seguendo il sistema “winner takes all”, in base al quale il candidato che ottiene più voti popolari ottiene tutti i grandi elettori di quello Stato. Questo sistema elettorale finisce per dare grande rilevanza agli swing state; in sede di campagna elettorale, è infatti difficile che un candidato alla presidenza dedichi molta attenzione a uno degli Stati tradizionalmente orientati dalla sua parte, perché la vittoria è considerata già sicura.
[di Dario Lucisano]