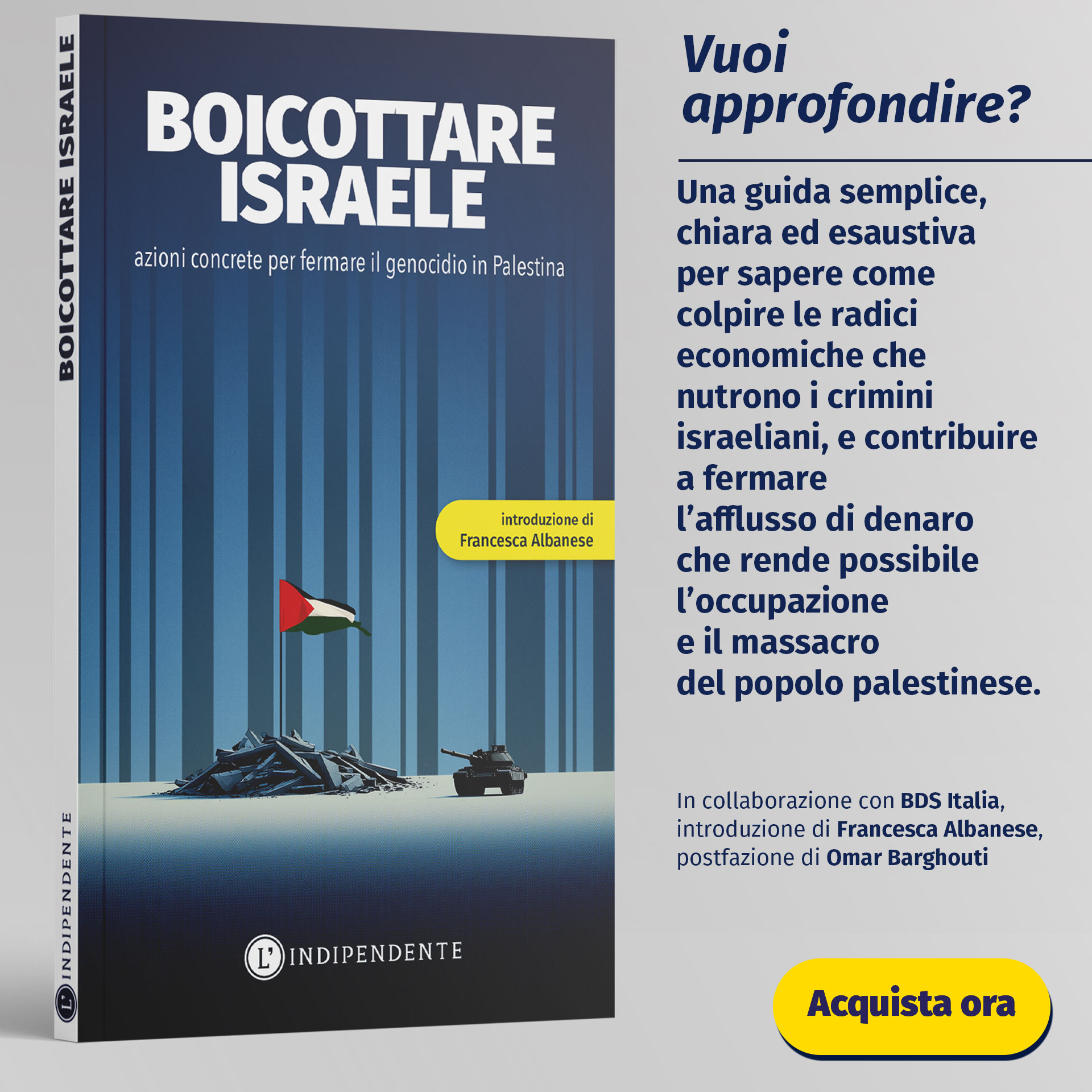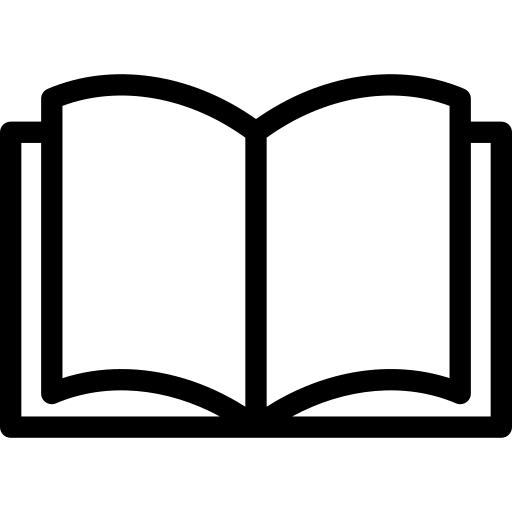Il presidente americano Donald Trump ha interrotto con effetto immediato ogni canale diplomatico con il governo guidato da Nicolás Maduro. L’inviato speciale USA, Richard Grenell, è stato richiamato da Caracas con un ordine diretto del presidente: qualsiasi negoziato in corso – esplorativo o avanzato – è stato congelato secondo fonti del New York Times. La decisione segna un cambio netto nel corso degli ultimi mesi, in cui Grenell aveva condotto interlocuzioni con il regime venezuelano per sondare accordi e percorsi di distensione. Trump ha motivato lo stop con accuse di “azioni ostili e minacce incombenti”, mentre Maduro ha reagito denunciando un piano per attentare all’ambasciata statunitense a Caracas, affermando che “un gruppo terroristico locale” era già al lavoro su ordigni esplosivi e che “l’amministrazione americana è già a conoscenza dei fatti”. Sullo sfondo, gli Stati Uniti mantengono una potente presenza militare nei Caraibi: almeno otto navi da guerra, un sommergibile d’attacco e una forza di oltre 4.500 soldati stazionano nella regione, ufficialmente per contrastare il narcotraffico. Maduro ha definito tali assetti “minacce chiare e provocazioni per un cambio di regime mascherato” e la rottura diplomatica lascia aperta la possibilità di ulteriori escalation.
L’Ucraina avrebbe colpito impianti di armi e petrolio in Russia: Mosca avvisa l’Europa
Nella notte tra il 5 e il 6 ottobre 2025, le forze ucraine hanno lanciato un massiccio attacco con droni e missili verso il territorio russo, reclamando il colpo a un impianto di munizioni nella regione di Nizhny Novgorod (Sverdlov), a un deposito di armi della 18ª Armata e a un terminal petrolifero in Crimea. Secondo lo Stato maggiore ucraino, gli attacchi avrebbero provocato esplosioni multiple, incendi e danni all’infrastruttura logistica dell’industria bellica russa. Le autorità russe – pur riconoscendo di aver subito un “attacco su 14 regioni”, comprese zone attorno al Mar Nero e al Mar d’Azov – sostengono che le loro difese aeree abbiano intercettato 251 droni. Gleb Nikitin, il governatore di Nizhny Novgorod ha precisato che l’impianto di munizioni non avrebbe subito danni rilevanti, rivendicando che le difese abbiano deviato i droni verso aree industriali. Contestualmente, fonti russe indicano che un terminal petrolifero in Crimea è stato colpito, causando un incendio: l’obiettivo strategico, secondo gli ucraini, era ampliare la pressione sulle risorse energetiche russe. L’episodio rientra in una strategia ucraina ormai consolidata: intensificare gli attacchi alla rete di approvvigionamento russa, danneggiare il complesso militare-industriale dell’avversario e dimostrare un’autonomia crescente nella produzione di armi – che si sarebbe addirittura triplicata – in particolare droni. Nelle ultime settimane, attacchi simili si sono ripetuti: tra questi, un attacco a un impianto chimico del Perm Krai e incendi in raffinerie vicino a San Pietroburgo (Kirishi) sono stati segnalati da fonti russe.
Considerate le scarse possibilità che l’Ucraina entri a far parte della NATO, gli alleati occidentali hanno adottato una strategia alternativa per aiutare Kiev a respingere l’aggressione russa: investire miliardi nell’industria bellica ucraina, in modo che possa difendersi meglio. Un recente progresso nell’arsenale interno ucraino è un drone quadrirotore in grado di eludere i dispositivi di disturbo russi, volare per oltre 20 chilometri e sganciare sei chilogrammi di esplosivo guidato su carri armati e altri obiettivi di alto valore. La risposta di Mosca non si è fatta attendere. Le autorità russe hanno condannato gli attacchi come atti di “terrorismo” e di “escalation”, avvertendo che qualsiasi sostegno europeo all’Ucraina – sia diplomatico, sia militare – sarebbe considerato un coinvolgimento diretto nella guerra. Il presidente Vladimir Putin ha ammonito che la Russia reagirà con “forza significativa” se l’Occidente proseguirà nell’armare Kiev. Intervenendo giovedì 2 ottobre al Club Valdai a Sochi, sul Mar Nero, il leader russo aveva già ammonito l’Alleanza Atlantica: «Nessuno dovrebbe avere dubbi sul fatto che le contromisure della Russia non tarderanno ad arrivare». In sedi internazionali, il ministro degli Esteri Sergej Lavrov ha ribadito che Mosca «non intende attaccare l’Europa», ma che risponderà in modo “decisivo” alle provocazioni. Il clima è già molto teso: oltre alle continue notizie di voli sospetti di droni in vari Paesi europei, intrusioni aeree e manovre belliche, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump si trova a dover decidere se inviare inviare i missili a lunga gittata Tomahawk in Ucraina. Il tycoon ha dichiarato di aver «già preso una decisione, più o meno», ma di voler prima capire come verranno utilizzati. Intanto, Dmitri Medvedev, vicepresidente del Consiglio di Sicurezza russo, ha affermato che resta un mistero chi si cela dietro le incursioni dei droni che hanno interessato gli aeroporti europei, ma che tali episodi devono servire da “monito” ai cittadini europei sui pericoli della guerra. Mosca sottolinea che, se l’Europa continuerà a fornire sistemi missilistici, intelligence e assistenza militare all’Ucraina, finirà per essere considerata parte del conflitto stesso – una linea che richiama discorsi già emersi nei mesi precedenti.
Se l’attacco ucraino risultasse confermato nei suoi effetti, non si tratterebbe soltanto di un’azione militare isolata, ma di un cambio di paradigma: l’Ucraina che colpisce profondamente nella Federazione russa e sfida i principi e soprattutto i confini della “non interferenza”. Ciò mette l’Europa in una posizione delicata: chiudere gli occhi significherebbe accettare che il conflitto stia già varcando le sue frontiere. Le reazioni politiche non si fanno attendere: i leader di Bruxelles discutono ormai apertamente della necessità di rafforzare le difese dell’Unione e un esempio concreto lo abbiamo avuto nelle scorse settimane con l’operazione Sentinella dell’Est, ma si teme che la linea tra sostegno a Kiev e coinvolgimento diretto diventi sempre più labile. Un nodo cruciale rimane la politica delle armi: finora molti Stati europei hanno evitato di autorizzare l’uso dei propri sistemi su obiettivi russi, ma l’attenzione strategica di Kiev si sposta sempre più su obiettivi logistici e infrastrutturali del nemico. Zelensky e le autorità di Kiev insistono che i recenti raid sono stati condotti con armamenti di produzione nazionale, per dimostrare la propria autonomia, ma anche per rispondere alle critiche occidentali sul rischio di scatenare una escalation. Per l’Europa, la sfida è trovare un equilibrio tra la volontà di non essere trascinata nel conflitto come parte attiva e la necessità di continuare a mostrare un sostegno concreto all’Ucraina. Qualsiasi decisione comporterà conseguenze strategiche e morali, mentre Mosca avverte l’Europa che non sarà “spettatrice” e invita i governi di Bruxelles a scegliere da che parte stare, prima che il conflitto decida da sé.
Napoli: un altro uomo è morto dopo essere stato colpito con il taser dalla polizia
È morto in ambulanza, ancora prima di raggiungere l’ospedale, l’uomo colpito dal taser a Napoli dai carabinieri intervenuti nella sua abitazione dopo la segnalazione di una lite in famiglia. Tutto ha avuto luogo ieri, a Napoli, in quartiere Brancaccio: gli agenti avrebbero impiegato l’arma a impulsi elettrici per calmare il 35enne, in evidente stato di agitazione, per poi affidarlo ai sanitari del 118. A nulla, tuttavia, è servita la corsa in ospedale: l’uomo è morto durante il tragitto. Sul caso è stata aperta un’inchiesta e sul corpo dell’uomo sarà disposta l’autopsia, per determinare le cause del decesso. La morte dell’uomo, la quinta sospetta da taser nel giro di quattro mesi, accende ulteriormente il dibattito sull’impiego dell’arma a impulsi elettrici, che per il ministro Piantedosi rappresenta l’alternativa più sicura all’arma da fuoco.
«Ogni volta che si verificano questi tragici casi è stata esclusa la riconducibilità all’utilizzo del taser, che è sempre l’alternativa all’arma da fuoco», ha commentato il ministro Matteo Piantedosi ai microfoni del programma Cinque Minuti di Bruno Vespa. Eppure, il numero di decessi che seguono l’utilizzo dell’arma a impulsi elettrici è sempre più elevato. Solamente nelle ultime settimane sono state almeno tre le persone morte dopo essere state colpite dal taser: il caso più recente è quello di Claudio Citro, 41 anni, morto a Reggio Emilia il 15 settembre; prima di lui la stessa sorte era toccata a Gianpaolo Demartis, 57 anni, anche lui morto durante il trasporto in ambulanza, a Olbia, dopo essere stato fermato in stato di agitazione e sotto effetto di droghe, e ad Elton Bani, 41 anni, morto a Manesseno, nell’entroterra genovese, dopo essere stato colpito dal taser per tre volte. Poche settimane prima era toccato a Riccardo Zappone, 30 anni, deceduto il 3 giugno in ospedale a Pescara poco dopo l’arresto. Cinque morti in quattro mesi, tutte avvenute con dinamiche molto simili: soggetti in forte stato di agitazione, e quindi verosimilmente con attività cardiaca alterata, di età diverse, deceduti dopo aver ricevuto la scarica elettrica. In molti casi le indagini sono ancora aperte: secondo quanto è stato fino ad ora reso noto, ad esempio, nel caso di Gianpaolo Demartis il consulente della procura di Tempio Pausania, Salvatore Lorenzoni, avrebbe escluso il taser come causa del decesso, ipotizzando invece una morte dovuta al consumo di droghe, ma per avere dei risultati certi è necessario attendere l’esame tossicologico, che dovrebbe arrivare a fine ottobre.
Introdotto in Italia in via sperimentale dal primo governo Conte, con un decreto legge firmato dall’allora ministro dell’Interno Matteo Salvini, l’uso dell’arma è stato approvato definitivamente nel 2020 in 12 città con popolazione superiore ai 100 mila abitanti. A partire dal 14 marzo 2022, l’arma è stata data definitivamente in dotazione agli agenti di 18 città italiane: secondo l’allora ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese, questo «costituisce un passo importante per ridurre i rischi per l’incolumità del personale di polizia impegnato nelle attività di prevenzione e controllo del territorio». E quest’anno, con l’approvazione di un emendamento (fortemente voluto dalla Lega) al decreto Milleproroghe, è stata autorizzata l’estensione dell’utilizzo del taser in forma sperimentale a tutti i Comuni con meno di 20 mila abitanti.
Secono il presidente del gruppo GIEC (Gruppo di Intervento Emergenze Cardiologiche, che già nel 2018 segnalava il rischio di morte collegato all’impiego dell’arma a impulsi elettrici), Maurizio Santomauro, in una lettera inviata al ministro Piantedosi e citata dai media, sarebbe necessario, «alla luce delle evidenze scientifiche», evidenziare «l’esistenza di un potenziale rischio di arresto cardiaco correlato all’uso della pistola elettrica taser che potrebbe generare un’aritmia letale (la fibrillazione ventricolare) e provocare un decesso non voluto da parte di chi la usa», motivo per il quale gli agenti delle Forze dell’Ordine dovrebbero essere quantomeno «periodicamente addestrati e certificati nelle procedure di rianimazione cardio-polmonare di base e di defibrillazione». «La distribuzione di defibrillatori alle pattuglie di polizia e carabinieri che controllano il territorio è già abbastanza estesa», ha tuttavia commentato il ministro.
UE, al via le discussioni per le mozioni di sfiducia contro von der Leyen
A Strasburgo si apre oggi il dibattito sulle due mozioni di censura presentate contro Ursula von der Leyen, che saranno poi sottoposte al voto giovedì. Le iniziative, promosse dai gruppi The Left (sinistra) e Patrioti per l’Europa (destra), giungono poco dopo un primo tentativo fallito e riflettono le crescenti tensioni sull’operato della Commissione europea. I promotori criticano gli accordi commerciali ritenuti troppo favorevoli agli Stati Uniti, l’intesa UE-Mercosur e la presunta mancanza di trasparenza e incisività nelle politiche migratorie, sociali e climatiche. Von der Leyen parteciperà al dibattito ma non al voto, che richiederà una maggioranza qualificata di 480 voti su 719. Pur mancando l’appoggio dei principali schieramenti – Popolari, Socialisti e Liberali voteranno contro – le mozioni rappresentano un banco di prova politico per la presidente e segnalano un crescente fermento per la mancata trasparenza delle sue politiche.
La Cina ha deciso di ridurre la collaborazione con le aziende tecnologiche europee
La Repubblica Popolare Cinese sta riducendo sensibilmente le forniture tecnologiche provenienti dall’Europa, almeno per quanto riguarda le apparecchiature di telecomunicazione. Secondo indiscrezioni riportate dalla stampa estera, nel mirino delle nuove restrizioni ci sarebbero in particolare la finlandese Nokia e la svedese Ericsson, aziende finite di fatto al centro del fuoco incrociato di una guerra commerciale e considerate da Pechino come un potenziale rischio per la sicurezza nazionale. La mossa appare come una risposta speculare alle decisioni prese nel 2020 da diversi Paesi europei, i quali bandirono le tecnologie 5G dei colossi cinesi Huawei e ZTE. All’epoca, la misura fu per l’appunto giustificata con la necessità di tutelare la sicurezza nazionale, tuttavia la decisione cadde fatalmente in concomitanza con le forti pressioni esercitate da Washington, impegnata in una guerra commerciale e tecnologica con Pechino. Oggi, con l’acuirsi delle tensioni politiche ed economiche, non sorprende che – come riportato dal Financial Times – Pechino si stia attrezzando per alleggerire i suoi legami con le industrie occidentali, imponendo loro un più stringente – e opaco – processo revisionale da parte della Cyberspace Administration of China (CAC).
Secondo quando riportato dalla testata, i criteri di valutazione correntemente adottati dalla CAC non vengono resi pubblici né spiegati ai fornitori, lasciando le imprese in una condizione di incertezza riguardo alle motivazioni e alle tempistiche delle decisioni.
La misura si inserisce in un contesto internazionale già segnato da diffidenze sull’origine e sull’affidabilità dei componenti 5G, oltre che dalla crescente politicizzazione delle scelte infrastrutturali nel settore delle telecomunicazioni. È l’ennesima conferma di come, in un mondo in cui anche tra alleati lo spionaggio digitale è una realtà quotidiana, nessun Paese ritenga più prudente fondare le proprie infrastrutture critiche su tecnologie provenienti da Stati che manifestano interessi divergenti. La decisione cinese di limitare l’accesso ai fornitori europei reitera come la sicurezza tecnologica sia divenuta una vera e propria leva strategica, tanto industriale quanto geopolitica. Le nuove revisioni di sicurezza e gli obblighi informativi imposti da Pechino costringeranno infatti i fornitori europei a investire risorse significative in compliance, tracciabilità dei componenti e certificazioni di sicurezza — processi complessi che possono tradursi in ritardi, modifiche contrattuali o, nei casi più estremi, nell’esclusione da gare e appalti strategici. Un panorama che, di fatto, spinge verso la localizzazione delle produzioni e che la Camera di Commercio dell’Unione Europea in Cina ha definito una “minaccia esistenziale” per le imprese europee.
Detto ciò, i rischi legati ai rapporti tecnologici tra Stati restano concreti, soprattutto in un contesto di interdipendenza in cui ogni azienda distribuisce prodotti a “doppio uso”, impiegabili sia in contesti civili, che militari. Gli USA stanno in questo periodo obbligando Bytedance a svendere TikTok a imprenditori statunitensi vicini al governo, così da poter mettere mano sui suoi algoritmi. Parallelamente, molte aziende cinesi continuano a produrre sistemi di videosorveglianza che mostrano la tendenza di inviare flussi di dati verso i loro server in Asia. Tuttavia, lo stesso governo cinese si affida a tecnologie americane per alimentare i propri apparati di sorveglianza e controllo. Nel frattempo, anche Nokia ed Ericsson mantengono legami stretti con le forze armate europee e statunitensi — un elemento che, agli occhi di Pechino, potrebbe rafforzare l’idea di un potenziale rischio per la propria sicurezza interna.
Elezioni Calabria: vince il centrodestra
Sono terminati gli spogli per le elezioni regionali in Calabria. Il candidato di centrodestra e presidente uscente Roberto Occhiuto ha vinto con il 61,58% delle preferenze, battendo il candidato di centrosinistra Pasquale Tridico, che si è fermato al 37,81%. L’affluenza si è attestata al 43,13% contro il 44,36% delle scorse regionali. La provincia dove si è votato di meno è quella di Vibo Valentia che ha raggiunto il 38,89%.