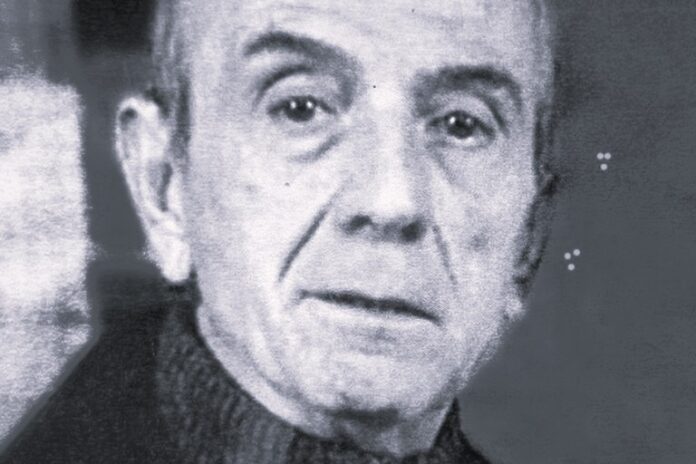Il caso dell’omicidio di Abderrahim Mansouri sta mandando il governo in tilt. Il ragazzo era stato ucciso il 26 gennaio scorso da un colpo di pistola alla testa sparato da un agente, che aveva affermato di avere agito per legittima difesa, dopo essersi visto puntare contro una pistola. La dinamica dei fatti sta ancora venendo ricostruita, ma ieri, 23 febbraio, quello stesso agente è stato arrestato per omicidio volontario. La sua versione era stata ripresa dai vertici dell’esecutivo per rilanciare i provvedimenti in agenda: all’indomani della sparatoria, Salvini rivendicava una stretta sui migranti e – soprattutto – più tutele per le forze di polizia, affermando che fosse «sbagliato indagare sugli agenti che si difendono» e rilanciando il nuovo pacchetto sicurezza. Oggi, invece, parla di un possibile «oltraggio alla divisa», mentre Meloni mette le mani avanti, sottolineando che nella proposta di legge non è presente alcuno scudo penale.
L’arresto di Carmelo Cinturrino, il poliziotto che lo scorso 26 gennaio ha sparato un colpo di pistola alla testa di Abderrahim Mansouri, è avvenuto ieri mattina. Dopo l’omicidio, il poliziotto aveva dichiarato di avere sparato al ragazzo per legittima difesa, e da Palazzo Chigi si era alzato un coro di voci in sua difesa: intervistata a Dritto e Rovescio, Meloni rispolverava la retorica del presunto «doppiopesismo» dei magistrati che ostacolerebbe la messa in sicurezza dei cittadini; Salvini, invece, rilanciava le misure contenute nel nuovo decreto sicurezza, proponendo una campagna di raccolta firme per esprimere solidarietà a Cinturrino. Con i giorni e i costanti sviluppi sul caso, il sostegno del governo al poliziotto è andato sempre più scemando, fino ad arrivare, con l’arresto, a costringerlo a battere in ritirata: «Se fosse confermato il comportamento criminale nel caso di Rogoredo, sarebbe un oltraggio ai suoi colleghi in divisa», ha detto Salvini; «Se quanto ipotizzato trovasse conferma nel seguito delle indagini, ci ritroveremmo davanti a un fatto gravissimo, un tradimento nei confronti della Nazione», Meloni. La prima ministra è così tornata sul pacchetto sicurezza che il vicepremier aveva in precedenza rilanciato con fermezza, rassicurando i cittadini: «La giustizia farà il suo corso e confidiamo che sia determinata, anche perché – a differenza di quello che leggo – non esiste alcuno scudo penale».
Il nuovo decreto sicurezza prevede un insieme di misure che, con il caso Mansouri, erano finite al centro dell’attenzione. Il tema più discusso è stato quello del cosiddetto “scudo penale”. Presentando la misura, il ministro della Giustizia Nordio – dopo avere contestato l’utilizzo di tale espressione – ha spiegato che la misura prevista verrebbe estesa a tutti i cittadini e che intende far sì che le persone coinvolte non vengano iscritte nel registro degli indagati e messe davanti l’opinione pubblica pur garantendo loro la possibilità di partecipare alle indagini. Le novità riguarderebbero «l’uso legittimo delle armi o altre cause di giustificazione» quali la legittima difesa, l’adempimento di un dovere, o lo stato di necessità: «Qualora appaia evidente che il fatto è stato compiuto in presenza di una di queste cause, il pubblico ministero non iscrive il soggetto nel registro delle notizie di reato, ma effettua un’annotazione preliminare in un modello separato». Verrebbe, dunque, creato un registro diverso, precedente al cosiddetto registro degli indagati, in cui il pm potrebbe iscrivere le persone che hanno commesso un reato per cause di giustificazione. «Il pm ha 120 giorni per svolgere gli accertamenti necessari (più 30 giorni per l’eventuale richiesta di archiviazione) e l’iscrizione nel registro degli indagati scatta obbligatoriamente solo se si deve procedere a un incidente probatorio». Per quanto la misura coinvolga tutti, alle forze dell’ordine sarebbe garantita la tutela legale, con l’anticipazione delle spese di difesa.
L’omicidio di Abderrahim Mansouri ha sin da subito fatto parlare di sé per via della difficoltà nell’accertamento dei fatti che la versione fornita dal poliziotto comportava. Cinturrino ha spiegato di essersi recato sul posto – un’area boschiva nei pressi della stazione di Rogoredo, a Milano – dopo avere effettuato un appostamento. L’agente, vestito con abiti borghesi, sarebbe entrato nel boschetto assieme a un collega, dove avrebbe trovato Mansouri e un altro uomo; dopo essersi identificato come poliziotto, il secondo sarebbe fuggito, mentre Mansouri avrebbe tirato fuori una pistola – poi rivelatasi essere a salve – e l’avrebbe puntata contro Cinturrino. Da lì, lo sparo. I dubbi sollevati dai legali della famiglia Mansouri sono diversi: dalla condotta del ragazzo, che avrebbe tirato fuori una pistola puntandola contro un agente che conosceva, fino alla supposta assenza di testimoni e telecamere. Nei giorni, sono emersi diversi elementi indiziari che sono culminati nell’arresto di Cinturrino: dall’autopsia pare che Mansouri sia stato colpito sul lato della testa, e che dunque fosse girato al momento dello sparo, e sul suo volto sono state riscontrate ecchimosi e lividi, compatibili con una caduta a faccia in avanti. Inoltre, i rilevamenti sull’arma mostrerebbero che essa non sia stata impugnata dal ragazzo, e sul giubbotto sarebbe ben visibile l’impronta di una scarpa. A insospettire ulteriormente gli inquirenti vi è poi il fatto che i soccorsi sono stati chiamati con ben 23 minuti di ritardo, elemento determinante nella morte di Mansouri.