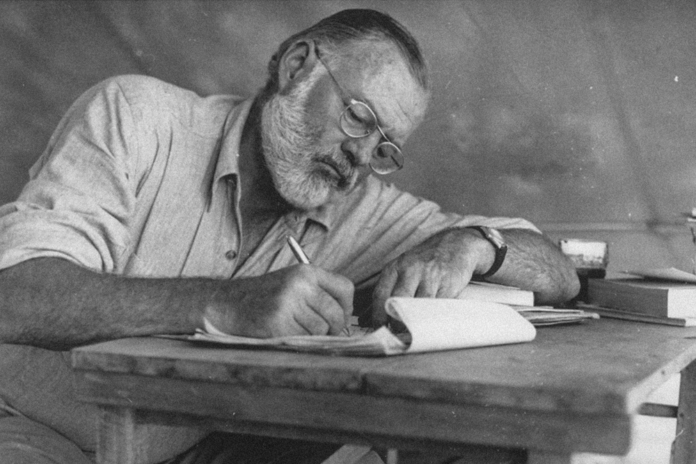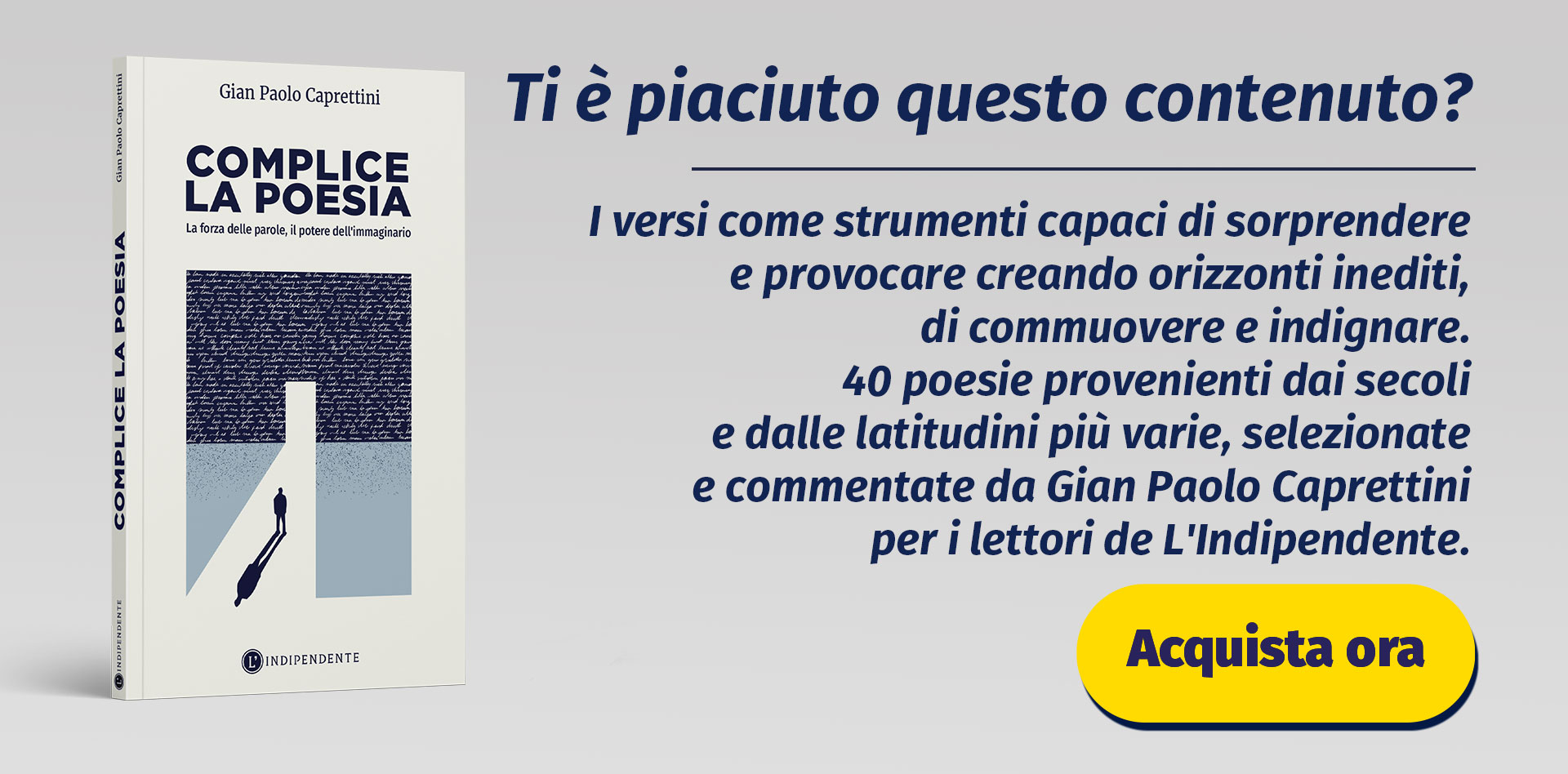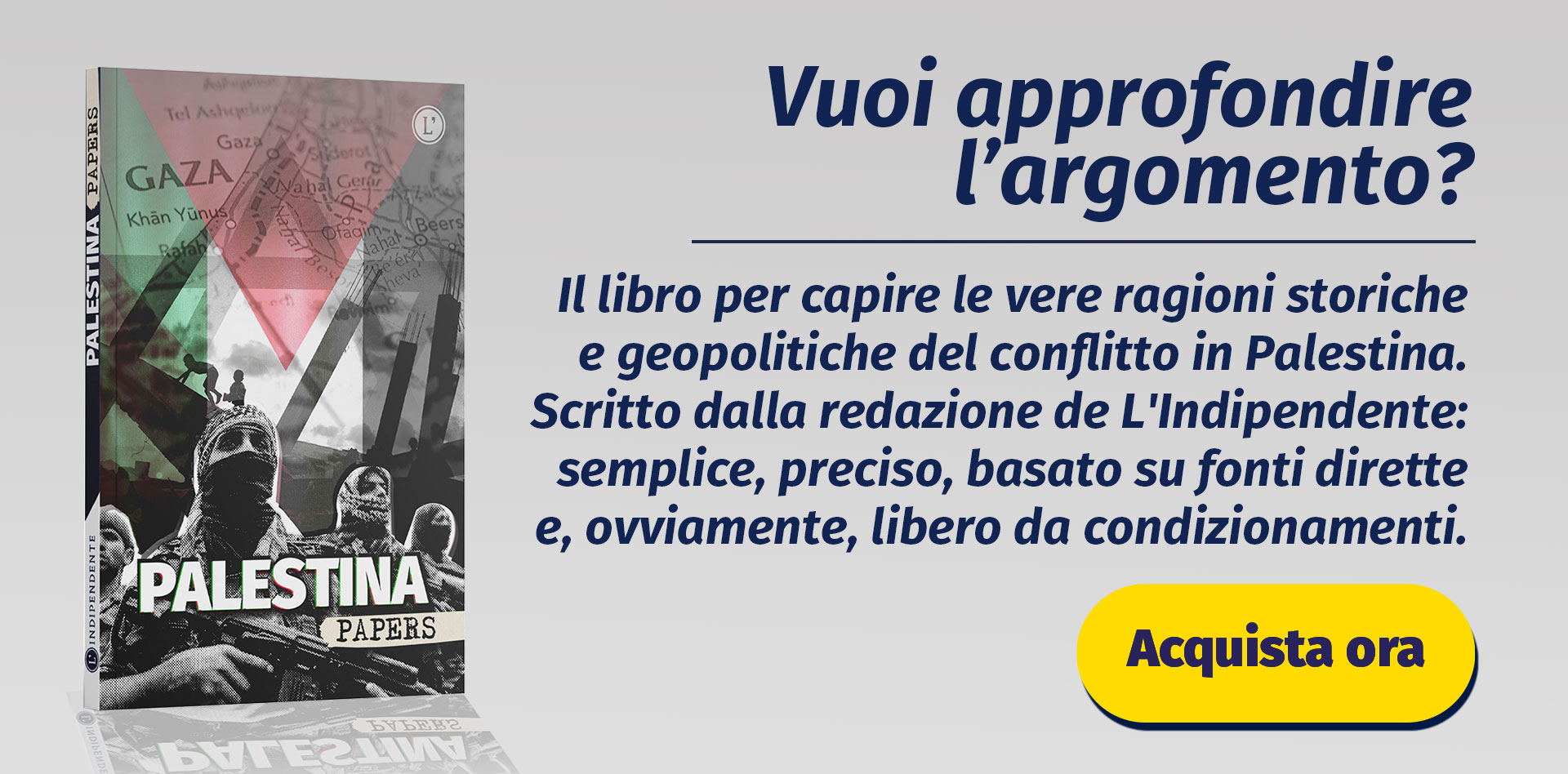Da secoli quello tra italiani e caffè è un rapporto d’amore che appare inscalfibile, che riempie di ritualità i vari momenti della giornata: al mattino per svegliarsi, sul lavoro per prendere una pausa, in famiglia nei momenti di condivisione. Ma il modo in cui lo si consuma cambia nel tempo e negli ultimi anni l’uso a casa e in ufficio del caffè espresso in capsule si è diffuso rapidamente, fino a rappresentare oltre il 20% del totale dei volumi di caffè acquistati nel Paese. Un successo che dipende dalla comodità del prodotto, immediatamente pronto per l’uso, e dalle capillari strategie di marketing delle aziende produttrici, che lo hanno spinto nella consapevolezza che la sua diffusione ne avrebbe aumentato i profitti. Il costo del caffè in capsule, di circa 30 euro/kg, è infatti di molto superiore rispetto ai 9,35 euro/kg necessari in media per quello macinato venduto nelle “vecchie” confezioni da 250 grammi. Eppure, il rovescio della medaglia di questa moda non risiede solo nell’ovvio impatto ambientale (dato dalla necessità di produrre e poi smaltire milioni di capsule monouso), ma anche – come ormai è provato a livello scientifico – da alcuni rischi non trascurabili per la salute umana.
Le capsule possono essere fatte di tre materiali diversi: plastica, alluminio e plastica compostabile. Al momento, le capsule in commercio in Italia fanno riferimento alla compatibilità con due sistemi diversi di macchine da caffè: il sistema Dolce Gusto e quello Nespresso. Le macchine Nespresso sono note per il loro design elegante e compatto, ideali per chi ha spazi limitati in cucina. Offrono un sistema di estrazione a pressione elevata, garantendo una bevanda ricca e cremosa che soddisfa anche i palati più esigenti. Al contrario, le macchine Dolce Gusto presentano un design più versatile e moderno, con una gamma di colori e forme che si adattano a diversi stili di arredamento. Sono progettate per preparare una varietà di bevande, non solo caffè espresso ma anche cappuccino, caffelatte, latte macchiato, offrendo più opzioni al consumatore.
Le capsule compatibili con il sistema Dolce Gusto non sono di certo la migliore scelta per l’ambiente: sono più grandi rispetto a quelle del sistema Nespresso, pesano di più e sono solo di plastica tradizionale non compostabile. Inoltre contengono più caffè, in media 7,3 grammi rispetto ai 5,5 delle capsule Nespresso.
Una bomba ecologica
Sono tre i tipi di capsule che possiamo trovare al supermercato. In primo luogo vi sono quelle in alluminio, facilmente riconoscibili perché i produttori tendono a specificare il materiale sulle confezioni, in quanto l’alluminio è considerato il migliore per preservare l’aroma del caffè.
Poi abbiamo le capsule in plastica, che costituiscono la stragrande maggioranza ma, a differenza di quelle in alluminio, sono riconoscibili da piccole diciture poste sul retro della confezione, in quanto non sono percepite come un valore aggiunto dal consumatore. Alcuni marchi di capsule in plastica aggiungo diciture come quella di «capsule riciclabili», tuttavia, perché il loro impatto ecologico sia davvero ridotto, sarebbe necessario che tutti gli utenti seguissero la corretta procedura di riciclo – che implica l’apertura di ogni singola capsula dopo l’uso e l’eliminazione della polvere esausta del caffè, per poi differenziare la plastica negli appositi contenitori.

Infine ci sono le capsule compostabili, le uniche realmente ecologiche per quanto riguarda lo smaltimento: possono essere gettate dopo l’uso direttamente nel bidone dell’umido di casa in quanto soggette a biodegradabilità nell’arco di alcuni mesi. I produttori sono in questo caso molto attenti a evidenziare la qualità ambientale del prodotto, eppure in commercio ne esistono ancora pochissime. Va poi sottolineato come l’impatto ecologico, per quanto ridotto, esista comunque: le capsule sono infatti conservate in confezioni usa e getta (la cui fabbricazione non è certo a impatto zero) le quali impiegano spesso coloranti la cui tipologia non viene specificata sulla confezione.
L’impatto delle capsule sul nostro pianeta in termini di rifiuti è altissimo, a prescindere dal materiale di fabbricazione. Di quelle in plastica già abbiamo detto. Quelle in alluminio sono anche peggio, perché alle medesime difficoltà di riciclo – visto che il prodotto dovrebbe essere separato tra involucro e contenuto di caffè esausto dal consumatore dopo l’uso – si aggiunge il fatto che l’alluminio, se finisce nell’inceneritore, sprigiona sostanze tossiche come la diossina. Non dimentichiamo poi che esiste il problema ecologico anche della confezione esterna del prodotto e della frequente presenza della bustina di plastica che avvolge insensatamente ogni singola capsula. Ci sono infine i costi ambientali poco noti ai consumatori, che riguardano la produzione dell’alluminio, che si estrae dalla bauxite attraverso complessi processi chimici che producono fino a quattro tonnellate di fanghi nocivi di scarto per ogni tonnellata di prodotto finito.

Da qualunque punto di vista, quindi, non bisogna mai credere alla retorica green della comunicazione pubblicitaria nel caso delle capsule: di qualsiasi materiale siano composte, sono insostenibili dal punto di vista ambientale. La capsula, in quanto prodotto usa e getta, è per definizione insostenibile rispetto al consumo di caffè fatto con la moka o espresso erogato dalle macchinette “vecchia maniera” che lavorano direttamente il caffè in polvere.
Un espresso di sostanze tossiche?
A preoccupare i consumatori rispetto all’uso di caffè in capsule non devono essere solo i risvolti ambientali. Il quadro, infatti, è piuttosto fosco anche per la salute umana. Nel caffè in plastica troviamo gli ftalati, sostanze classificate scientificamente come interferenti endocrini (ovvero in grado di interferire e alterare il funzionamento di alcune ghiandole responsabili della produzione degli ormoni nel nostro organismo, come la tiroide, il seno, i testicoli). Gli ftalati sono prodotti a livello industriale in grandi quantità e vengono comunemente utilizzati come emollienti e additivi plastici, trovando impiego in numerose applicazioni industriali e prodotti di largo consumo. Si aggiungono ai materiali plastici, in lattice, o nei cosmetici di bellezza, per vari scopi come conferire flessibilità, garantire la stabilità del colore o la resistenza. Particolarità dell’utilizzo degli ftalati è che essi non vengono legati alla plastica alla quale sono aggiunti, potendo quindi percolare o essere rilasciati nel tempo e a seguito di stress termici. Numerosi studi hanno riportato un’ampia e diffusa esposizione ambientale dell’uomo agli ftalati, identificando l’ingestione/alimentazione come principale via di assunzione di questi composti.
Sebbene la compatibilità di tali capsule di caffè con l’uso preposto sia dichiarata dalle aziende produttrici, a oggi la quantità effettiva di sostanze contaminanti rilasciate (e in particolare di interferenti endocrini come gli ftalati) nella bevanda finale non è nota e non viene comunicata dalle aziende produttrici. Gli ftalati vengono rilasciati dalla plastica delle capsule, quando esse entrano in contatto con l’acqua riscaldata a circa 90°C, per ottenere la percolazione del caffè. Invece le capsule in alluminio rilasciano durante la perforazione microparticelle metalliche di vari metalli tossici come vanadio, cadmio, ferro, piombo e titanio. Tutte queste sostanze (ftalati e/o metalli tossici) entrano pertanto nel caffè e, una volta ingerite, svolgono nell’organismo un’azione simil-estrogenica, andando a interferire e a “disturbare” alcune ghiandole normalmente soggette al funzionamento e regolamento di determinati ormoni. Così, ad esempio, la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILIT) riferisce che «nei testicoli svolgono una funzione anti-androgenica, potendo causare infertilità; mentre nelle donne, in virtù della loro azione simil-estrogenica, a lungo andare possono essere all’origine di patologie (anche neoplastiche) del seno, organo bersaglio tra i principali di quegli ormoni».

I produttori di capsule dichiarano che il rilascio di queste sostanze tossiche è ben al di sotto dei limiti di legge fissati dalla normativa europea, ma questo non è un aspetto che deve rassicurare più di tanto, in quanto molti studiosi di tossicologia avvertono che esiste la tossicità da «effetto accumulo»: essendo sia le plastiche che i metalli pesanti sostanze che il corpo non riesce a espellere e smaltire facilmente, essi si accumulano e si depositano in vari organi e tessuti, causando nel tempo danni e l’innesco di patologie di vario tipo, come quelle neurologiche. Se si tiene conto, poi, che oltre all’assunzione di caffè i consumatori hanno a che fare quotidianamente con numerosi altri alimenti confezionati o cucinati in contenitori di plastica o alluminio, si comprende facilmente come si vada inevitabilmente incontro a un subdolo, quasi inosservato effetto di accumulo, con gravi ripercussioni sulla salute. Nel 2019, il programma Report della RAI ha fatto analizzare in laboratorio i quantitativi di alluminio, ftalati e altri metalli tossici rilasciati nel caffè a seguito dell’uso delle capsule di caffè e i risultati sono stati mostrati ad alcuni esperti tossicologi come la dottoressa Belpoggi dell’Istituto Ramazzini di Bologna o il professor Carlo Foresta dell’Università di Padova. Entrambi gli esperti hanno espresso forti preoccupazioni sulla ingestione di queste sostanze in via quotidiana parlando di effetto tossico da accumulo che, come detto, è indeterminato e ignoto alla scienza allo stato attuale delle cose. Il prof. Foresta ad esempio ha affermato che «l’Europa ha dato questo limite e quindi dobbiamo attenerci a questo. Io sono un po’ scettico su questa faccenda perché a dire il vero [gli ftalati, ndr] sono presenti in tante altre condizioni, nei rivestimenti alimentari, negli abiti, nelle sostanze di plastica, sono in giro dappertutto. La sommatoria di tutte queste contaminazioni potrebbe essere superiore al limite consentito».
Un’altra sostanza molto tossica che è stata ritrovata nel caffè delle capsule è il furano. Uno studio realizzato dall’Università di Barcellona e pubblicato sulla rivista scientifica Journal of Agricultural and Food Chemistry mostra che il caffè preparato con le macchine a capsula contiene una concentrazione di furano da due a tre volte superiore di quella contenuta nel caffè delle caffettiere tradizionali o del caffè istantaneo. Il furano è un composto tossico e classificato come cancerogeno, al pari dell’acrilammide, che compare quando un alimento o una bevanda sono esposti a temperature elevate. Pertanto già la torrefazione, cioè la tostatura dei chicchi di caffè, produce furano che poi si ritrova in parte nella bevanda (una parte evapora, essendo un composto volatile). Il fatto che nel caffè in capsule sia rilevata una maggior quantità di furano rispetto al caffè prodotto con la caffettiera tradizionale potrebbe essere dovuto al fatto che la tostatura del caffè in capsula avviene a temperature molto più alte rispetto a quello in polvere o destinato ad altri usi. Questo da un lato consente ai produttori di tostare e avere il caffè pronto all’uso in tempi molto brevi, dall’altro fa sviluppare livelli maggiori di furano rispetto alla tostatura con temperature più basse. Un’altra ipotesi avanzata dagli esperti sostiene che la chiusura ermetica delle capsule impedisca al furano, che è particolarmente volatile, di fuoriuscire quando la pressione e l’acqua calda fanno penetrare la sostanza nella bevanda.
Il caffè fa bene o fa male?
Secondo i numerosi studi disponibili, sembra che il consumo abituale di caffè abbia un effetto protettivo verso alcune malattie. Ma la questione è più complessa e meno scontata di quello che sembra e in realtà il consumo di caffè è benefico per alcuni individui ma potrebbe essere nocivo e pericoloso per altri. Gli studi più recenti indicano infatti che esiste una diversa predisposizione genetica alla tolleranza della caffeina a seconda degli individui. Uno studio condotto all’Università di Toronto ha scoperto che alcuni individui possiedono una variante di un gene, chiamata CYP1A21A, che scompone la caffeina presente nell’organismo con una velocità 4 volte maggiore rispetto agli individui che invece possiedono il gene CYP1A21F. Per chi appartiene al primo gruppo, bere 2-3 tazzine di caffè al giorno diminuisce del 22% il rischio di infarto. «Il pericolo di infarto cresce del 36% nei metabolizzatori lenti che bevono due o tre tazze di caffè al giorno e si arriva fino al 64% per i forti consumatori di caffè, ossia coloro che ne consumano quattro o più tazze al dì», concludono i ricercatori.
[di Gianpaolo Usai]