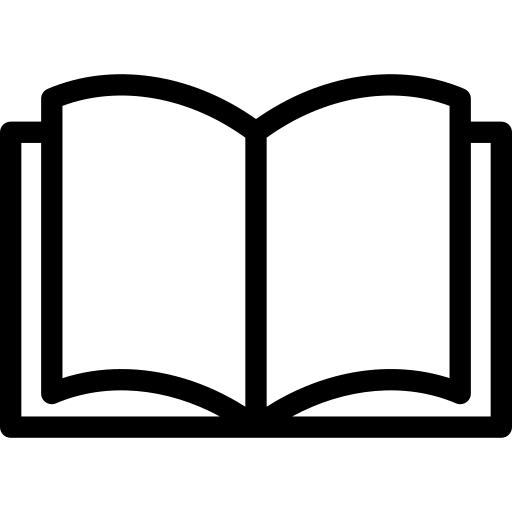I carabinieri di Parma hanno arrestato Harushimana Guillaume, 50enne originario del Burundi, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare per il triplice omicidio delle suore saveriane Olga Raschietti, Lucia Pulici e Bernardetta Boggian, uccise nel settembre 2014 a Kamenge, Bujumbura. Le prime due furono assassinate il 7 settembre con colpi contundenti e taglio alla gola, la terza decapitata la notte successiva. Dopo due archiviazioni (per difetto di giurisdizione e carenza di elementi), l’inchiesta è stata riaperta nel 2024. Secondo la procura, mandanti ed esecutori avrebbero legami con la polizia segreta burundese e con il generale Adolphe Nshimirimana.
Sciopero degli aerei: 300 voli cancellati
Alcoltest e droghe al volante: quali sono i diritti del conducente e come esigerne il rispetto
È una notte tiepida di luglio, hai superato alla grande tutti gli esami del semestre e ti sei concesso una serata di svago con gli amici di sempre. Tante chiacchiere, qualche bicchiere, una canna che gira di mano in mano al ritmo del frinire dei grilli. D’altronde, hanno avuto tutti vent’anni, perfino gli avvocati.
Guidi la tua 500 rilassato verso casa, quando una divisa con in mano una paletta t’impone l’alt. Lasci il volante solo per fare il segno della croce mentre accosti.
Tipologie di accertamento
Il Codice della Strada distingue due fasi principali di accertamento, sia per l’alcol (art. 186 C.d.S.) che per le sostanze stupefacenti (art. 187 C.d.S.).
Mediante gli accertamenti preliminari (o qualitativi) gli organi di Polizia Stradale sottopongono i conducenti a test non invasivi, spesso tramite apparecchi portatili (comunemente noti come “pre-test” o “blow test”). Questi accertamenti hanno una funzione meramente esplorativa e servono ad acquisire elementi utili per motivare l’eventuale obbligo di sottoporsi a un test probatorio.
Se l’esito dei test preliminari è positivo, in ogni caso di incidente stradale o quando vi sia altrimenti motivo di ritenere che il conducente sia in stato di alterazione, gli organi di polizia hanno la facoltà di effettuare l’accertamento con valore legale tramite accertamenti probatori (o quantitativi). Questi test includono gli accertamenti con etilometro, nonché quelli tossicologici analitici su campioni di fluido del cavo orale o prelievi di liquidi biologici presso strutture sanitarie.
Le sanzioni per l’alcol e le modifiche sugli stupefacenti

Ti stai chiedendo se hai bevuto troppo, sai vagamente che a diversi livelli di sbornia corrispondono sanzioni più o meno gravi e ignori completamente se anche la cannetta fumata allegramente in compagnia aggraverà la tua posizione.
Ebbene, sul fronte dell’alcol ci hai più o meno preso: l’art. 186 C.d.S. stabilisce le seguenti soglie e sanzioni (amministrativa la prima, penali la seconda e la terza):
- tasso alcolemico tra 0,5 e 0,8 grammi per litro: sanzione amministrativa da
543 a 2.170 euro e sospensione della patente di guida da tre a sei mesi; - tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 grammi per litro: ammenda da 800 a 3.200 euro, arresto fino a sei mesi, sospensione della patente di guida da sei mesi a un anno;
- tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro: ammenda da 1.500 a 6mila euro, arresto da sei mesi a un anno, sospensione della patente di guida da uno a due anni.
Sul fronte delle sostanze stupefacenti, recentemente il legislatore ha tentato di inasprire il quadro normativo nei confronti dell’assuntore che si pone alla guida. Fino al dicembre del 2024, infatti, l’art. 187 del Codice della Strada sanzionava colui che veniva fermato alla guida in stato di alterazione determinato dall’assunzione di sostanze psicotrope. In forza della riforma del dicembre 2024, voluta dal ministro Salvini, lo stato di alterazione non è più rilevante per la commissione dell’illecito, che è ora integrato dalla semplice assunzione di sostanze stupefacenti in un momento antecedente alla conduzione del veicolo. In pratica, se all’esito dei controlli biologici risultano valori compatibili con il consumo di sostanze (avvenuto anche molto tempo prima dell’accertamento) il conducente è di per sé punibile.
La Corte Costituzionale è dovuta intervenire per correggere l’evidente stortura generata dalla riforma, ossia la punibilità di una condotta che di per sé non integra necessariamente un pericolo per la collettività: con la sentenza n. 10 del 2026, il consesso ha fornito un’interpretazione costituzionalmente orientata della norma, circoscrivendone l’ambito applicativo a quei soli casi in cui il soggetto si ponga alla guida avendo ancora nel proprio corpo quantitativi di sostanze stupefacenti in grado di produrre un effetto di alterazione psico-fisica potenzialmente incidente sulla sua capacità di guida. L’illecito può quindi considerarsi integrato qualora la pregressa assunzione di sostanze sia tale da arrecare un pregiudizio quantomeno potenziale per la sicurezza della circolazione stradale.
La sanzione prevista è dell’ammenda da 1.500 a 6mila euro, l’arresto da sei mesi a un anno, con sospensione della patente di guida da uno a due anni.
Detto ciò, non ne sai niente di riforme e pronunce di legittimità costituzionale, sei preso dal panico, nelle serie TV questo è il momento in cui chiamano l’avvocato, ma tu scorri febbrilmente la rubrica del telefono e non ricordi se l’hai memorizzato sotto la S o sotto la G. Forse gli ultimi 2 shot di tequila si potevano evitare.
Il diritto fondamentale all’assistenza difensiva
Per la fase preliminare, la giurisprudenza ha chiarito che non sussiste l’obbligo di dare al conducente l’avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore.
Viceversa, la polizia giudiziaria, prima di procedere alla richiesta di sottoporsi all’alcoltest con etilometro o ai prelievi per l’analisi di sostanze stupefacenti, ha l’obbligo di avvertire la persona della facoltà di farsi assistere da un difensore. Questo avvertimento è un presupposto necessario per la legittimità dell’intera procedura e la prova dell’avvenuto avviso può essere fornita tramite il verbale di accertamento. È importante sottolineare che il diritto garantito è quello di essere informati della facoltà e di poter contattare un difensore. Tuttavia, trattandosi di un atto urgente e indifferibile, il cui esito può essere compromesso dal decorso del tempo, gli agenti accertatori non hanno l’obbligo di attendere l’arrivo del difensore prima di procedere con il test: una protrazione eccessiva dell’attesa potrebbe, infatti, incidere sull’attendibilità dell’accertamento.
Il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti
Preso dal panico, decidi di opporre il tuo rifiuto agli accertamenti probatori. Infatti ignori che tale rifiuto costituisce un’autonoma fattispecie di reato, punita con le peggiori sanzioni previste per la guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico più elevato: l’arresto da 6 mesi a 1 anno, l’ammenda da 1.500 a 6mila euro, la sospensione della patente da 6 mesi a 2 anni, la confisca del veicolo. Un disastro su tutta la linea: per il nostro ordinamento «mi rifiuto» equivale a «sono ubriaco fradicio». A questo punto ti conviene proprio chiamare Saul. E la prossima volta, una bella tisana al finocchio e poi dritto a nanna.
Leonardo SPA cresce più del previsto grazie al riamo: maxi dividendi agli azionisti
«I risultati preliminari del 2025 evidenziano un sensibile aumento di tutti gli indicatori economico-finanziari oltre ad una significativa riduzione dell’indebitamento netto di Gruppo». Così Roberto Cingolani, amministratore delegato di Leonardo, annuncia la crescita fuori dalle aspettative della compagnia, e un aumento della distribuzione dei dividendi che dovrebbe corrispondere a circa il 20% in più rispetto al 2024. L’anno scorso, le azioni dell’azienda sono cresciute quasi del 90%, mentre l’EBITA (gli utili prima degli interessi, delle imposte e degli ammortamenti) si è attestato a 1,752 miliardi, registrando un +14,9% annuo. Leonardo è la maggiore azienda bellica italiana, controllata al 30,2% dal ministero dell’Economia e delle Finanze. Negli ultimi anni è continuata a crescere anche grazie all’aumento delle esportazioni nei vari teatri di guerra, primi fra tutti quelli di Ucraina e Palestina.
I conti di Leonardo sono stati diffusi ieri poco prima dell’apertura della Borsa. Nel 2025, l’azienda ha registrato un aumento significativo e superiore alle aspettative in tutti gli indicatori: gli ordini hanno registrato un incremento del 13,5%, toccando quota 23,8 miliardi di euro, anche grazie a «un importante ordine nel settore Aeronautica, in un contesto di mercato nel quale la domanda di sicurezza resta elevata»; i ricavi sono cresciuti del 9,8% «con un incremento in doppia cifra in tutti i settori di business», e si sono attestati a 19,5 miliardi di euro; il flusso di cassa operativo (dato che rappresenta la liquidità di un’azienda dopo il finanziamento delle spese in conto capitale) è aumentato del 22,4%; il debito netto, infine, è diminuito del 44,2%. Ordini, ricavi ed EBITA sono aumentati in tutti i settori dell’azienda. Dal punto di vista dei ricavi, il settore in cui si è registrato l’aumento maggiore è quello delle soluzioni cyber e di sicurezza, con un +23,1%; seguono elicotteri, aeronautica e spazio con un +11,1% ed elettronica per la difesa con un +7,6%.
Questi risultati sono stati possibili anche grazie alla guerra in Ucraina e al genocidio in Palestina. A testimoniarlo nel corso degli anni è sempre arrivato lo stesso mercato, con cali drastici delle azioni della compagnia ogni volta che lo scenario internazionale sembrava profilare l’avvicinamento a una prospettiva di pace: lo scorso agosto, il solo annuncio dell’incontro che si sarebbe tenuto tra Trump e Putin ha fatto calare le azioni dell’azienda del 5,66%; con l’arrivo della tregua di ottobre a Gaza, invece, il colosso bellico ha perso il 10,7%. Viceversa, gli annunci militaristi dei leader europei hanno sempre fatto schizzare alle stelle il valore delle azioni dell’azienda, tanto che lo scorso marzo, con il mero lancio del piano di riarmo comunitario da parte della presidente von der Leyen, Leonardo aveva registrato un’impennata a Piazza Affari del +16,6%. Lo stesso Cingolani sostiene che i risultati del 2025 vanno letti come il «compimento di un virtuoso percorso iniziato tre anni fa, durante il quale abbiamo coniugato ad una chiara visione strategica una efficiente esecuzione nei processi per la piena realizzazione della Leonardo “one company”»; ormai due anni e mezzo fa, iniziavano i bombardamenti a tappeto di Gaza da parte di Israele.
Il ruolo di Leonardo nel genocidio a Gaza è stato evidenziato dagli stessi israeliani, che hanno dichiarato al sito specializzato Israel Defense che i missili che hanno colpito la Striscia provenivano anche da cannoni fabbricati in Italia e venduti a Tel Aviv. Un dato citato anche dall’Osservatorio sulle armi nei porti europei e mediterranei The Weapon Watch, che ha pubblicamente smentito l’azienda, dopo che quest’ultima aveva affermato che l’esercito israeliano non stesse utilizzando mezzi di sua produzione nella carneficina di Gaza. A tal proposito la campagna BDS Italia ha pubblicato un rapporto in cui mette a nudo i rapporti dell’azienda italiana con Israele. In ogni caso, l’aumento del 2025 non è isolato: anche lo scorso periodo l’azienda aveva chiuso l’anno con risultati record, con un incremento dell’utile netto del 63%, e un raddoppio dei dividendi per il 2025; allo stesso modo nel 2023 l’azienda contava ordini sopra le previsioni a 17,9 miliardi di euro (+3,8% rispetto al 2022) e ricavi per un ammontare di 15,3 miliardi (+3,9%).
Messico, ripartono i voli nello Stato di Jalisco
Dopo le violenze dello scorso fine settimana, il traffico aeroportuale negli scali di Guadalajara e Puerto Vallarta, nello Stato messicano di Jalisco, è tornato regolare. A dare la conferma è il Gruppo Aeroportuale del Pacifico, che ha comunicato che le operazioni risultano completamente ristabilite. Il traffico era stato interrotto dopo che membri del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), uno dei maggiori gruppi del narcotraffico del Paese, sono scesi per le strade del Messico scatenando una guerriglia, in risposta all’uccisione del loro leader Nemesio Oseguera, meglio conosciuto come “el Mencho”, da parte dell’esercito messicano.
Paramount rilancia l’offerta a Warner Bros a 31 dollari ad azione
Warner Bros. Discovery ha annunciato che la Paramount ha aumentato il prezzo della sua offerta di acquisizione a 31 dollari per azione. Lo scorso dicembre, l’azienda aveva offerto 30 dollari ad azione lanciando una offerta ostile verso l’accordo che Warner Bros aveva siglato con Netflix. Da allora è in vigore un braccio di ferro tra Netflix e Paramount per l’acquisizione del marchio. Paramount aveva già avanzato diverse offerte a Warner Bros, ma il consiglio di amministrazione si è sempre schierato a favore della vendita a Netflix; in risposta, ha lanciato contro offerte direttamente agli azionisti.