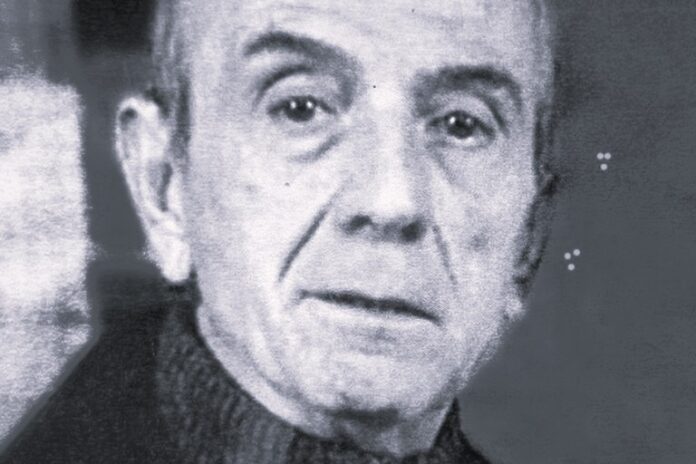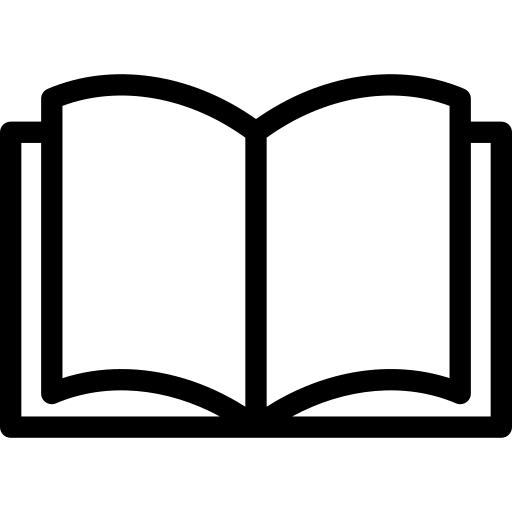Il Ciad ha chiuso il suo confine orientale con il Sudan. La notizia è stata data da fonti militari all’agenzia di stampa Reuters, e confermata da una nota governativa. La scelta arriva dopo una serie di scontri registrati sabato tra miliziani appartenenti al gruppo sudanese delle Forze di Supporto Rapido e membri dell’esercito ciadiano nella città di confine di Tine, in seguito a cui sono stati uccisi cinque soldati. In seguito agli scontri sono stati uccisi anche tre civili e ferite altre 12 persone. Gli ufficiali citati da Reuters hanno affermato che altre truppe ciadiane sarebbero state dispiegate nell’area.
È morto Domenico Belfiore, mandante dell’omicidio di Bruno Caccia, insieme ai segreti sul delitto
Si è spento, all’età di 74 anni, il boss di ‘ndrangheta Domenico Belfiore, condannato in via definitiva come mandante dell’omicidio del magistrato Bruno Caccia, avvenuto il 26 giugno 1983. Un delitto storico: Caccia è, ancora oggi, l’unico magistrato ucciso dalle mafie nel nord Italia. Sebbene la magistratura sia stata compatta nel ritenere Belfiore – punto di riferimento dei clan di ‘ndrangheta nel nord Italia – l’uomo che ha ordinato di mettere a morte il giudice, un grande buco nero è rimasto aperto negli anni sulle cointeressenze che potrebbero aver segnato quell’azione omicidiaria. La quale fu subito oggetto di depistaggi e su cui, a distanza di decenni, ancora si aprono nuove piste di indagine.
Negli anni Settanta, Bruno Caccia svolse un ruolo centrale nella lotta al terrorismo, raccogliendo le dichiarazioni confidenziali di Patrizio Peci e firmando la richiesta di rinvio a giudizio del nucleo storico delle Brigate rosse. Nel 1980 fu nominato Procuratore capo a Torino, occupandosi, tra le altre inchieste eccellenti, sul cosiddetto “Scandalo petroli”, che coinvolgeva ufficiali della Guardia di finanza e dirigenti statali in storie di contrabbando ed evasione fiscale, e sul caso “Zampini”, prima Tangentopoli torinese che vide al centro personaggi della giunta e dell’amministrazione comunale. Inoltre, iniziò a svolgere e coordinare importanti indagini sulle compagini criminali mafiose – siciliane e calabresi – che avevano iniziato a insediarsi in Piemonte. La sua uccisione avvenne il 26 giugno 1983, quando, mentre portava il suo cane a fare una passeggiata nei pressi della sua abitazione, fu affiancato da un’automobile da cui furono sparati 14 colpi di pistola, con altri tre esplosi a breve distanza. Dopo l’omicidio arrivarono ai principali quotidiani italiani presunte rivendicazioni da ambienti terroristici, ma gli uomini delle Brigate Rosse e di Prima Linea – su cui si era concentrata l’opera repressiva di Caccia – negarono di aver avuto un ruolo nel delitto.
Domenico Belfiore entrò in questa storia quando, abbandonata la pista terroristica, gli inquirenti iniziarono a concentra su quella ‘ndranghetista. Le indagini presero una piega decisiva quando un detenuto, Francesco Miano, cominciò a collaborare con i servizi segreti dall’interno del carcere. Dotato di un registratore, Miano raccolse testimonianze tra i compagni di cella su quanto accaduto al procuratore Bruno Caccia; tra le registrazioni più incisive vi fu quella con Domenico Belfiore, anche lui recluso: sotto pressione, Belfiore riconobbe di aver avuto un ruolo chiave nell’agguato, assumendosi la responsabilità dell’ordine di uccidere. Belfiore e altri due imputati vennero rinviati a giudizio; il processo, avviato a Milano nel 1989, si concluse dopo vari gradi con la condanna all’ergastolo di Belfiore nel 1992, ritenuto il mandante dell’omicidio. La ricostruzione giuridica indicò come movente la volontà del gruppo di rimuovere un magistrato integerrimo e “intoccabile”, considerato ostacolo alla loro espansione. All’epoca, come oggi, la legge vietava però qualunque rapporto tra magistratura e servizi segreti, ritenendo inammissibile affidare le indagini a strutture dipendenti dalla Presidenza del Consiglio; eppure, tale scelta investigativa fu adottata e autorizzata dai magistrati torinesi, pur non essendo più formalmente competenti sul caso, nella convinzione di ottenere risultati altrimenti irraggiungibili. Secondo il legale della famiglia Caccia, Fabio Repici, questa impostazione finì però per condizionare e limitare l’accertamento della verità processuale.
Solo nel 2020 si è arrivati anche alla condanna definitiva di Rocco Schirripa, aderente al clan Belfiore, accusato di avere partecipato all’agguato. A evidenziare il fatto che l’omicidio Caccia potrebbe nascondere molto più di quanto la magistratura abbia accertato è stato lo stesso procuratore generale Alfredo Pompeo Viola, pm del processo Schirripa. «Un delitto del genere è ideato, progettato e infine realizzato in contesti organizzati e quello del dottor Caccia prima vittima di mafia al Nord, è logicamente ipotizzabile che non sia stato compiuto solo dai due sparatori e dai due condannati, Belfiore definitivo e Schirripa per cui chiedo lo stesso epilogo», ha detto il magistrato. In passato, un’ipotesi entrata nelle indagini suggeriva che Caccias sarebbe stato eliminato per bloccare un’indagine sul riciclaggio della mafia nei casinò di Saint-Vincent. Un rapporto della Guardia di Finanza puntò su frequentatori del casinò, tra cui Rosario Pio Cattafi, poi condannato per associazione mafiosa e uomo di estrema destra, ma la pista venne archiviata e non trovò approfondimento nei processi successivi. Poi, lo scorso anno, una consulenza balistica della polizia scientifica ha evidenziato una compatibilità di classe d’arma dei proiettili calibro rinvenuti sulla scena dell’omicidio con quelli ottenuti dai test di sparo con la pistola trovata e sequestrata dalle forze dell’ordine a casa di Francesco D’Onofrio, arrestato nel 2024 in un’indagine sulle infiltrazioni della ‘ndrangheta in Piemonte. Anche su questo lavorerà la magistratura.
Sta di fatto che, su queste storie, Domenico Belfiore non può più parlare. È deceduto a Chivasso, nel torinese, venerdì 20 febbraio. L’uomo, però, fa notizia anche da morto. Infatti, il manifesto funebre apparso davanti alla camera mortuaria in cui riposa la salma del boss annuncia il rito religioso presso la parrocchia Madonna di Loreto, nella cittadina piemontese. Per questo motivo, si è alzato un gran polverone. «Mi addolora il fatto che questa persona che ha ucciso mio padre non si sia mai pentito, abbia continuato a dire bugie e non abbia contribuito a far luce dopo tanti anni su questo assassinio», ha dichiarato Paola Caccia, figlia del magistrato assassinato nel 1983. «Mi lascia perplessa la scelta di officiare le esequie in chiesa per una persona che in vita ha seminato violenza e terrore».
USA, bufera di neve nel Nord-Est: 5mila voli cancellati e forti disagi
Una potente bufera di neve sta investendo il Nord-Est degli Stati Uniti, con forti nevicate, raffiche di vento fino a circa 110 km/h e disagi diffusi ai trasporti: circa 5.000 voli sono stati cancellati, si registrano interruzioni di corrente e centinaia di scuole chiuse. In alcune zone orientali della Pennsylvania sono già caduti fino a 45 cm di neve; le nevicate più intense hanno interessato Delaware, New Jersey, New York, Connecticut, Rhode Island e Massachusetts; la tempesta si sposterà poi verso le coste del Canada. A New York City le scuole resteranno chiuse e non è prevista didattica a distanza.
Messico, esplodono le violenze dopo l’uccisione del boss della droga el Mencho: 26 morti
Dalla notte tra ieri e oggi, 23 febbraio, le strade del Messico sono teatro di blocchi e scontri armati tra membri del personale di sicurezza e appartenenti alle bande armate. I combattimenti sono iniziati dopo l’uccisione di Nemesio Oseguera, meglio conosciuto come “el Mencho”, vertice del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), uno dei maggiori gruppi del narcotraffico del Paese, con base nell’omonimo Stato di Jalisco. El Mencho è stato ucciso in un’operazione militare a Tapalpa, nel medesimo Stato, svolta in coordinazione con gli Stati Uniti. A poche ore dall’annuncio della sua morte, membri e sostenitori del CJNG hanno messo a ferro e fuoco l’intero Messico, instaurando blocchi, incendiando strade e negozi, e facendo esplodere scontri a fuoco in almeno 20 dei 31 Stati del Paese. Il bilancio, a ora, è di 26 vittime. Le autorità hanno disposto lo stato d’allerta, chiuso le scuole e consigliato alla popolazione di rimanere chiusa in casa, mentre le compagnie aeree hanno cancellato i voli.
L’annuncio della morte del Mencho è stato dato oggi dal ministero della Difesa messicano. Da quanto spiega il ministero, l’operazione è stata condotta dalle Forze Speciali dell’Esercito Messicano con il coinvolgimento di diversi velivoli dell’Aeronautica Militare e della Forza di Reazione Immediata della Guardia Nazionale, e con il sostegno informativo dell’intelligence militare centrale, del Centro Nazionale di Intelligence e della Procura Generale. La missione ha inoltre trovato l’appoggio degli Stati Uniti, che tuttavia non è chiaro che ruolo abbiano giocato nelle operazioni; quello che è certo è che abbiano fornito non meglio precisate «informazioni supplementari». Lo scopo dichiarato dell’operazione era quello di arrestare el Mencho, ma, riporta il ministero, il personale sarebbe stato attaccato e, «per legittima difesa», avrebbe «respinto l’aggressione», uccidendo quattro membri del CJNG e ferendone gravemente altri tre. Da quanto riporta il governo, questi ultimi sono stati trasportati via aereo a Città del Messico, morendo prima di potere ricevere cure. Tra questi, c’era proprio el Mencho. Il comunicato prosegue affermando che «le autorità competenti saranno responsabili delle procedure forensi per la sua identificazione»; non è chiaro cosa queste comportino, visto che el Mencho sarebbe morto sotto custodia dell’esercito.
Dopo l’operazione, il ministero ha dispiegato a Jalisco il personale della Guardia Nazionale e truppe dell’Esercito provenienti dal Messico centrale e dagli Stati confinanti per rafforzare il contingente in caso di risposte da parte del CJNG. Il gruppo del narcotraffico, infatti, non si è fatto attendere: in poche ore, sostenitori del Mencho sono scesi per le strade degli Stati di Jalisco, Bassa California, Quintana Roo, Nayarit, Sinaloa, Colima, Guanajuato, Guerrero, Stato del Messico, Michoacán, Nuevo Leon, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosi, Tamaulipas, Veracruz e Zacatecas. In diffuse aree del Paese si sono registrati scontri a fuoco, blocchi, e incendi dolosi per le strade, dove i gruppi armati hanno dato fuoco a macchine, locali commerciali, autobus, stazioni di servizio, banche e supermercati. Gli scontri più feroci sono scoppiati proprio nello Stato di Jalisco, dove è stato preso d’assalto un edificio della Guardia Nazionale. In totale il personale di sicurezza ha smantellato 250 posti di blocco del cartello in 20 stati; in tutto il Messico, sono state uccise almeno 26 persone: 17 agenti delle forze dell’ordine (15 membri della Guardia Nazionale, un agente della Procura e una guardia carceraria), una civile (i media menzionano una donna al terzo mese di gravidanza), e otto membri di bande armate. Arrestate, inoltre, 27 persone, di cui 11 per episodi di violenza e 14 per i saccheggi.
Le autorità di Jalisco hanno lanciato lo stato di allerta, mentre diversi Stati hanno imposto il lavoro da remoto, interrotto i servizi di consegna a domicilio, chiuso le scuole, sospeso i trasporti pubblici, e chiesto ai trasportatori di rientrare nei depositi. I turisti sono stati invitati a non lasciare i propri alberghi, e i residenti le proprie case. Sebbene nessun aeroporto sia stato chiuso, i blocchi stradali hanno avuto ripercussioni sulle operazioni aeree, con la maggior parte dei voli nazionali e internazionali cancellati sia a Guadalajara che a Puerto Vallarta, entrambe nello Stato federato di Jalisco. L’ambasciata statunitense, inoltre, ha chiesto ai propri cittadini di limitare al minimo gli spostamenti. Gli stessi USA hanno confermato di avere preso parte alle operazioni; la portavoce dell’amministrazione Trump, Karoline Leavitt, ha spiegato che «Trump definito il CJNG un’Organizzazione Terroristica Straniera perché è esattamente ciò che è». Il gruppo è una delle maggiori organizzazioni messicane del narcotraffico, e opera su scala internazionale; prima della sua uccisione, gli USA avevano offerto una ricompensa di 15 milioni di dollari per chi avesse fornito informazioni sul Mencho.
Una raffica di scioperi coinvolgerà i trasporti questa settimana
I lavoratori del settore dei trasporti incroceranno le braccia per più giorni questa settimana. Si inizierà con lo stop dell’intero comparto dell’aviazione civile di giovedì 26 febbraio, data decisa dopo che il ministro dei Trasporti Salvini aveva precettato lo sciopero del comparto durante lo svolgimento delle Olimpiadi. Alcune compagnie, come Ita Airways, hanno annunciato la cancellazione di oltre la metà dei collegamenti previsti per quel giorno e il successivo. Venerdì 27 e sabato 28 sarà la volta di Ferrovie per lo Stato, con lo stop ai treni di lunga percorrenza e regionali. A fermarsi saranno anche i lavoratori del trasporto merci su rotaia.
Rogoredo, fermato con l’accusa di omicidio volontario il poliziotto che sparò a Mansouri
Tra proteste, militarizzazioni e sabotaggi, sono finite le Olimpiadi Invernali
Si sono concluse, accompagnate dal corteo di protesta della Rete Olimpiadi No Grazie, le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026. L’evento, iniziato lo scorso 6 febbraio, è stato segnato per tutto il suo svolgimento da proteste e sabotaggi, in un contesto di militarizzazione dei centri urbani interessati e mancato raggiungimento delle aspettative di afflusso all’evento – con migliaia di biglietti rimasti invenduti e appartamenti sfitti, anche a causa dei prezzi estremamente elevati. Così, mentre la viabilità di Verona veniva modificata per via dello svolgersi della cerimonia di chiusura presso l’Arena, alcune centinaia di cittadini si sono ritrovati in piazza per ricordare «quanto rappresentano queste Olimpiadi», tra insostenibilità ambientale e spreco di risorse economiche.
Mentre all’arco della pace a Milano veniva spento il braciere olimpico, a Verona sfilavano artisti, atleti e bandiere. All’interno delle mura dell’Arena presenti diverse figure istituzionali, come la prima ministra Giorgia Meloni, che hanno assistito alla cerimonia di chiusura e al passaggio di consegne alla Francia, che ospiterà i prossimi giochi invernali. All’esterno, invece, un corteo formato da molteplici realtà attiviste: i manifestanti si sono ritrovati alle 15:30 presso Porta Palio, per poi muoversi verso Piazza Sacco e Vanzetti, davanti all’arsenale. Per l’occasione sono state schierate decine di agenti delle forze dell’ordine in tenuta antisommossa, che hanno blindato le strade accompagnati dalle camionette.
Le Olimpiadi sono iniziate lo scorso 6 febbraio, segnate da militarizzazione, prezzi alle stelle e biglietti invenduti. Nonostante le celebrazioni, non sono andate come sperato: all’inizio dell’evento, era prevista la vendita di 1,5 milioni di biglietti, ma ne erano stati strappati solo 1,2 milioni, di cui 300mila destinati agli sponsor; il mancato raggiungimento della soglia prevista ha costretto gli organizzatori a lanciare promozioni come il “compri 2 e paghi 1” e agevolazioni ai volontari. Il tema dell’invenduto è stato denunciato anche dall’Associazione italiana gestori affitti brevi, che al posto del boom turistico sperato si è ritrovata il tasso di occupazione delle case peggiore degli ultimi 11 anni. Nei mesi, tra i proprietari c’è chi ha scommesso sulla buona riuscita dell’evento, arrivando a chiedere fino a 180mila euro per due settimane a Milano. Presto, tuttavia, si è dovuto scontrare con la realtà; a gennaio la bolla speculativa è esplosa, con cali dei prezzi medi per gli affitti nelle località interessate pari al 30%.
«La manifestazione non è una protesta generica, ma un atto di accusa contro un modello che privatizza i profitti e socializza i costi, che distrugge territori in nome dell’evento, che riduce gli spazi democratici, che normalizza guerra e distruzione ambientale sotto la copertura dello sport», si legge in un comunicato della Rete Olimpiadi No Grazie. Quello del danno ai territori è stato sin da subito uno dei temi più criticati alle opere in programma per le Olimpiadi Milano-Cortina. Il progetto simbolo di tali contestazioni è stato quello della pista da Bob di Cortina, per la quale sono stati tagliati oltre 20mila m2 di bosco e 500 larici secolari, assieme a un altro migliaio di piante. In generale, la costruzione delle opere è stata corredata da scandali, sprechi e malagestione: numerose opere non hanno visto la luce in tempo per l’inizio dell’evento, e più di una volta la Fondazione si è trovata costretta a chiedere prestiti aggiuntivi alle regioni; l’ultima volta, a poco più di una settimana dall’inaugurazione.
L’altro volto delle Olimpiadi sono state proprio le proteste. Oltre ai danni ambientali e sociali ai territori coinvolti, i vari cortei che hanno sfilato contro l’evento hanno criticato la partecipazione di Israele alla kermesse sportiva. La risposta della politica è stata quella di militarizzare le principali città coinvolte, specie in coincidenza con lo svolgimento degli eventi, così come successo ieri a Verona; la prima ministra Meloni, invece, ha rilasciato accese dichiarazioni contro i dimostranti affermando che chi manifestasse contro le Olimpiadi fosse contro l’Italia.
In questi giorni, infine, si sono moltiplicati gli episodi di sabotaggio nelle ferrovie, contro cui il governo ha schierato l’antiterrorismo. Il primo episodio risale al 7 febbraio, quando è stato incendiato un tratto della linea Ancona-Rimini: «Quest’azione mira a rendere visibili le contraddizioni che si porta con sé lo spettacolo delle Olimpiadi, in questo caso quelle invernali Milano Cortina ’26. Tra i vari partner ufficiali di questi giochi ci sono aziende come Leonardo, ENI, Gruppo FS, che collaborano e speculano su guerre e devastazione della terra in nome del feroce progresso capitalista», si legge in un comunicato apparso su La nemesi, blog di area anarchica. Nelle stesse ore, nei pressi di Bologna, un incendio ha tranciato i cavi di un deviatoio, portando alla chiusura temporanea della linea ferroviaria. Una settimana dopo si sono verificati altri tre atti di sabotaggio, uno tra le stazioni di Abbadia e Mandello del Lario, un secondo sulla linea AV Roma-Napoli, e un altro sulla linea AV Roma-Firenze, fra Tiburtina e Settebagni.
Venezuela: 200 detenuti politici in sciopero della fame
Oltre duecento detenuti politici in Venezuela hanno iniziato uno sciopero della fame per chiedere una nuova legge sulla amnistia. La protesta è stata lanciata in risposta all’approvazione dell’ultima norma sulla questione, che li esclude dalla scarcerazione. Lo sciopero è iniziato nel carcere di Rodeo I, circa 40 chilometri a est della capitale Caracas, dove sono detenuti diversi militari. A scioperare sia venezuelani che stranieri.