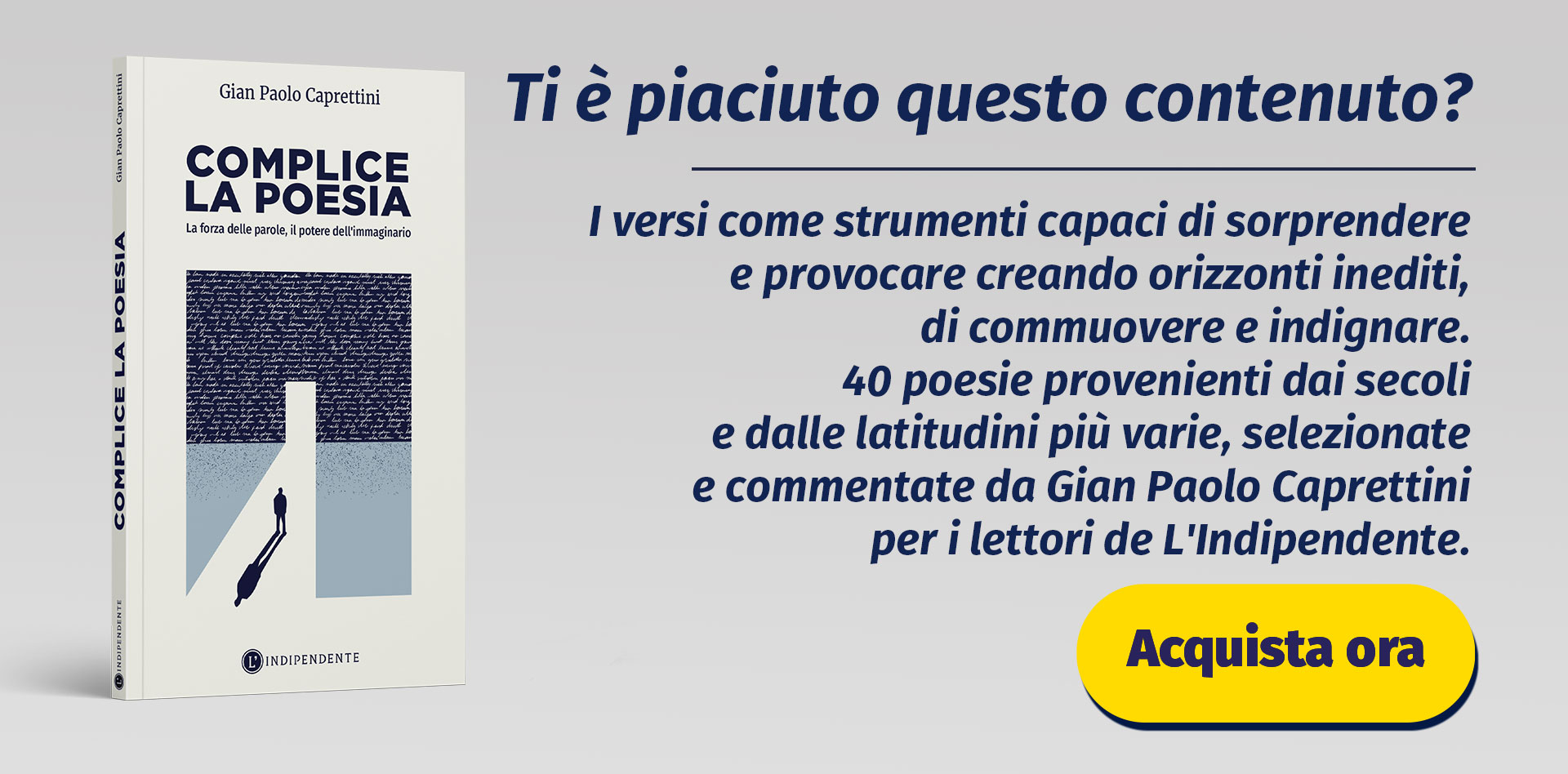Ci sono giorni che somigliano al riprender fiato, al trattenere il respiro e lasciare il mondo in attesa. Ci sono estati che non vogliono morire. Lungo la strada si aprono fiori che, a toccarli, fanno cadere una pioggia di ruggine autunnale. Pare che su ogni sentiero sia passato un vecchio circo fatiscente, lasciandosi dietro una traccia di ferro antico a ogni giro di ruota.
La ruggine era sparsa dappertutto, spruzzata sotto gli alberi e sugli argini dei fiumi, persino tra i binari dove un tempo passava una locomotiva che ormai non c’era più. Così i fiocchi caduti dai fiori e i binari arrugginivano insieme sul confine dell’autunno.
«Guarda, Doug» disse il Nonno, guidando dalla fattoria verso la città. Alle loro spalle, nel Kissel Kar, c’erano sei grandi zucche appena colte fresche nell’orto. «Vedi quei fiori?». «Sissignore».
«Soffioni, Doug. Si chiamano così. Senti l’aria? Agosto torna ancora… Addio all’estate».
«Cielo» disse Doug, «che tristezza».
La Nonna entrò nella dispensa e sentì il vento che soffiava da ovest. Nel recipiente la pasta lievitava come una testa sontuosa, la testa di un alieno che rinasce dal deposito degli anni precedenti. Toccò il rigonfiamento sotto il tessuto di cotone: era la terra del mattino prima che arrivasse Adamo. Era il mattino dopo il matrimonio di Eva con quello sconosciuto, nel letto di foglie.
La Nonna guardò dalla finestra il sole che attraversava il giardino e riempiva i meli di luce d’oro, poi disse le parole consuete: «Addio, estate, eccoci al primo ottobre. La temperatura è venticinque gradi, la bella stagione non vuol sapere di andarsene. I cani sono fuori, stesi sotto gli alberi; le foglie non cadono, la gente vorrebbe piangere e invece ride».
Sul prato passava qualche nuvola. Quando il sole arrivò fino in dispensa, la Nonna quasi sussurrò: «Estate, addio».
Quando sta finendo agosto, ogni volta sento risuonare queste parole che iniziano Farewell to Summer (Addio all’estate, 2006) di Ray Bradbury, un romanzo che ha delle somiglianze pazzesche con le pagine di García Márquez, perché con loro la realtà diventa il luogo di eventi densi, fitti di un eros quasi musicale e la loro scrittura si trasforma in immagini vertiginose.
I due scrittori hanno infatti cantato un’epica decadente, da poveri e sconfitti che interpretano il mondo con qualche ricetta della tradizione, con qualche lacrima che resiste a mostrarsi, con quel senso eccelso della metafisica della gente che sa celebrare, come fanno i poeti, i giorni perduti. E che in ogni atto della vita svolge la normalità fusa col mito, ma un mito che sfugge in un’astuzia popolana ma sublime.
Chi ha scritto Fahrenheit 451 (Bradbury nel 1976) e Ci vediamo in agosto (l’ultimo lavoro di Gabo) – i due scrittori che ho nominato, araldi di una scrittura onirica che mostra le visioni come quadri naïf – che altro ci può riservare se non una rappresentazione del tempo che fa trasudare la sua acidità dai binari, che muore lentamente perché ha vissuto nel ripetersi, nell’avvicendarsi dell’ovvio, un divenire scaltro e disilluso.
Le stagioni ritornano, il tempo non va avanti come una freccia ma assomiglia al respiro, ha diastoli e sistoli, sensazioni che rimangono per giorni vetrificante, come scrive prodigiosamente García Márquez.
Allora anche noi, io, tu che mi leggi e quelli a cui ora stiamo pensando, affrontiamo la fine di agosto come la pienezza di un tempo vero che ci distrae, ci illude e ci incanta.
Rimaniamo allora per tutto l’anno un po’ prigionieri di agosto, dei suoi diritti alla fantasia, delle feriae Augusti, del tempo in cui anche un imperatore, insieme generoso e crudele, amava, si fa per dire, i suoi sudditi.
[di Gian Paolo Caprettini]