Addio alle armi (‘A Farewell to Arms’), il romanzo di Ernest Hemingway, uscito a puntate sullo Scribner’s Magazine nel settembre 1929, sorprese e incantò subito il pubblico per la sua carica “romantica e modernista”, come ricorda Fernanda Pivano nel suo appassionato libro sullo scrittore americano. Alternare, anzi fondere, guerra ed amore, trasfigurando le esperienze personali in una speciale visione tragica, mostra ancora più in profondo gli orrori della guerra, quando va a coincidere con la vita stessa e lascia del tutto abbandonati i sopravvissuti.
Ne deriva una solitudine di massa che coincide con l’idea di trovarsi in un fantascientifico tempo senza tempo, soggetto a perenne transizione, in un’epoca che non si sa dove porterà. Questa sensazione è stata avvertita anche dopo la seconda guerra mondiale. Prima che Marshall McLuhan parlasse della necessità di una visione cosmica, di una prossima «interpenetrazione galattica» e della nascita di una nuova coscienza, un grande filologo tedesco, Erich Auerbach, a metà degli anni Cinquanta, scrisse che la civiltà europea era oramai alla fine della sua esistenza, pronta ad essere inghiottita in un’altra entità storica.
L’idea di crisi e di transizione, chissà verso dove, è stata una ossessione della modernità che la post-modernità ha creduto bene di superare polverizzandola in una miriade di problemi, creando una matassa di nodi difficili da sciogliere, perché la moltiplicazione delle questioni da affrontare e la simultanea perdita di orizzonti di valori non è gestibile, se non in una dimensione rinunciataria, falsamente libera.
L’idea di guerra – e quella collaterale di pace costruita sulla deterrenza o paura reciproca – nasce proprio da qui, dalla incapacità, da parte di chi governa, di individuare priorità, di metterle a regime per un po’ di anni, di condividere le difficoltà, di cercare competenze appropriate. La guerra, di difesa o di offesa non importa, taglia tutti i nodi, rende inutile qualsiasi forma di intelligenza, tranne quella primordiale e irresponsabile della sfida.
Questa attuale idea malsana del riarmo, fondata sulla misera fandonia della sicurezza, lascia ancora una volta l’umanità isolata, come il protagonista di Addio alle armi, che alla fine, rimasto solo, torna in albergo sotto la pioggia. Egli, tuttavia, qualche tempo prima, era stato testimone di un’atmosfera di liberazione. Una liberazione però passata attraverso l’idea di morte, come nella immortale fine dell’Elettra di Sofocle. «“La guerra non continua” disse un soldato. “Stiamo andando a casa. La guerra è finita.” “Stiamo tutti andando a casa.” “Venga, Tenente…” “Chi è un tenente? Abbasso gli ufficiali…” “Credono tutti che sia finita, ma non ci credo.” “Viva la pace” gridò un soldato. “Andiamo a casa.”… “Di che brigata siete?” gridò un ufficiale. “Brigata di pace” gridò qualcuno. “Brigata della pace.” L’ufficiale non disse niente.» (Addio alle armi, Mondadori 1965, pp. 166-67).

Per di più, non riusciamo ad abbandonare una volta vecchi tabù. Prendiamo la questione territoriale, che è la causa scatenante di una infinità di battaglie e di guerre per la delimitazione dei confini. Non c’è bisogno di esperti per capire che la divisione territoriale del 1947 imposta nel Medio Oriente, producendo una serie di enclave, avrebbe generato inadempienze e invasioni. E poi anche per l’Ucraina, dove Kiev ebbe nel Medioevo un ruolo di grande capitale di quella che poi abbiamo chiamato Russia, si devono gestire tematiche plurisecolari di invasioni e di opposte identità religiose. Ma perché dev’essere la guerra a gestirle? Se inevitabile è stata la guerra ancora più inevitabile deve risultare la pace.
Tuttavia nemmeno la consapevolezza, la cultura bastano: possono servire a capire ma non risolvono. Le scelte devono venire dalla politica. I veri nemici sono i problemi lasciati aperti, mai le persone e meno che mai le altre nazioni e gli altri Stati.
La vita è risoluzione di problemi, la vita sociale esige una tradizione, depurata dai suoi tabù, affermava Karl R. Popper. In Europa l’accantonamento della identità e della eredità cristiana non ha comportato soltanto conseguenze di tipo religioso. Ha comportato ad esempio la cancellazione del concetto della responsabilità personale, edificato dalla nostra ricerca filosofica. Il fraintendimento dei valori della tradizione laica ha portato, a sua volta, l’idea di tolleranza delle diversità a confondersi con la resa a forme culturali e religiose importate, per cui l’idea di libertà ci si è capovolta addosso portandoci a dover sostenere la legittimità di qualsiasi opzione, anche distruttiva.
Scriveva don Primo Mazzolari, nel 1945, mentre stava finendo la guerra in Europa:«il fascismo è caduto, ma il suo metodo è purtroppo ancora vivo presso tanti antifascisti….Se non si capisce che ci si può accordare sul bene del Paese pur avendo opinioni diverse su molte questioni, vuol dire che c’è l’uomo da rifare prima del Paese». Sono questi i valori da trasmettere ai nuovi cittadini che entrano o che passano in Italia.
Ancora l’etica, dunque. E allora facciamo un altro tipo di guerra, armiamoci per differenti vittorie: per rendere efficiente e all’avanguardia la nostra sanità pubblica, per fare delle nostre scuole luoghi di apprendimento di contenuti importanti, di modalità di relazioni aperte e produttive, come occasioni per crescere come vera comunità. Battiamoci contro la mancanza di risorse fondamentali della vita che troppe donne e troppi uomini, troppe famiglie conoscono ogni giorno.
Ci vuole volontà e intelligenza da parte di chi governa, ci vogliono sacrifici, molti consistenti sacrifici da parte di chi è più fortunato. Lo Stato però deve esserne amministratore non detentore, deve fare circolare le nuove risorse canalizzandole nelle necessarie direzioni.
Ma forse le armi continuano ad essere la scorciatoia di chi non ha coraggio, di chi ha paura di perdere qualcosa, di chi non accetta che sia un altro a vincere. La vera sfida, per chi governa con senso di giustizia è quella di accettare che i beneficiari degli interventi nella buona direzione non siano comunque contenti. E che quindi sia necessario fare di più: cioè costruire armi per il benessere sociale sempre più sofisticate, sempre più intelligenti, sempre più potenti.
[di Gian Paolo Caprettini]

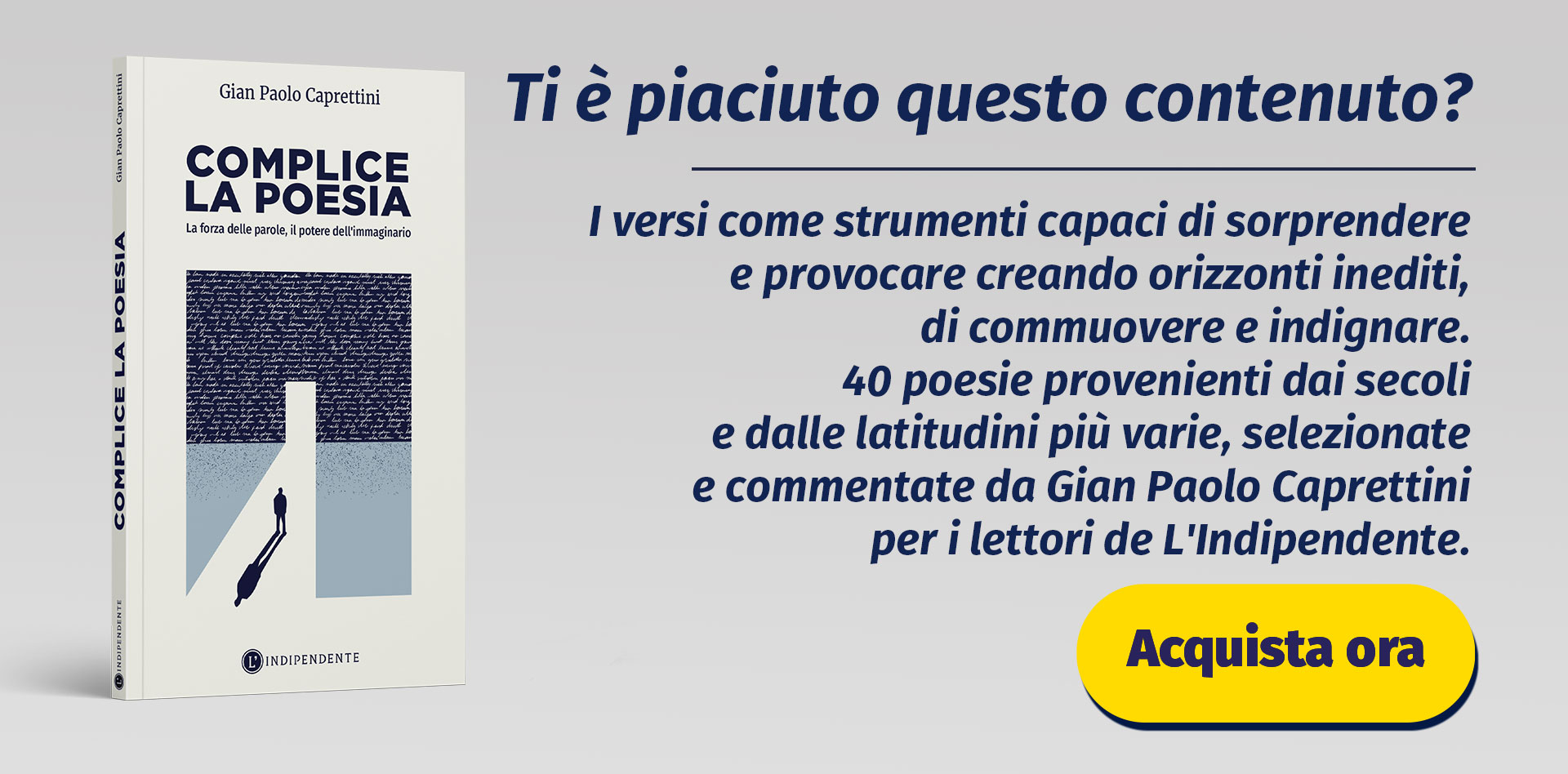



È vero, non c’è nulla da aggiungere; articolo magnifico. Grazie.
Vi ringrazio davvero! Ho lavorato molto a questo pezzo. G.P. Caprettini
Articolo meraviglioso. Grazie.
Volevo scrivere un commento simile, ma dato che c’è già, mi accodo.